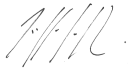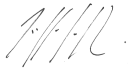"OSCURA
È LA VITA, È LA MORTE"
- MAHLER E "IL CANTO
DELLA TERRA"
Dopo l’Ottava
Sinfonia (1906/07),
l`utopistica e visionaria
evocazione di un eros
onnipossente, Das Lied
von der Erde (Il canto
della terra) si configura
antiteticamente come opera
emblematica della solitudine
devastante intrinseca alla
condizione umana. La sua
genesi si fa risalire
all’estate del 1907, un
periodo cruciale nella vita
di Gustav Mahler: qualche
settimana dopo le sue
dimissioni dall’Opera di
Vienna gli moriva la figlia
primogenita e gli era
diagnosticata una grave
disfunzione cardiaca. Nella
solitudine di un villaggio
tirolese la lettura di un
volumetto di antiche liriche
cinesi, nelle quali la
celebrazione della natura e
delle gioie effimere della
vita è adombrata e filtrata
in un linguaggio improntato
a radicale pessimismo,
maturò in lui l’ispirazione
del Lied von dee Erde,
un ciclo sinfonico di sei
lieder. Il lavoro fu
compiuto nell'estate
seguente e l'orchestrazione
nel 1909. La prima
eseeuzione, postuma, ebbe
luogo a Monaco il 20
novembre 1911l sotto la
direzione di Bruno Walter.
Che Mahler
intendesse qui trascendere
una cornice liederistica e
attingere ad una espansa
scrittura sinfonica è
rivelato chiaramente dal
sottotitolo dell`opera:
"Sinfonia per tenore,
contralto (o baritone) e
orchestra". Significativi in
tal senso sono anche
l'impianto sonatistico del
primo e dell`ultimo lied,
gli ampi interludi
strumentali, le correlazioni
motivico-tematiche tra i
singoli lieder, la
gravitazione verso il
movimento finale che è
tipica del sinfonismo
mahleriano, e ancora la
disposizione ciclica dei sei
lieder, con due movimenti
estremi sonatistici, un
movimento moderato (il lied
n. 2) e tre Intermezzi (i
nn. 3-5) con virtuale
funzione di scherzo
tripartito.
Nel primo
lied, Das Trinklied vom
Jammer der Erde,
all’apparente forma strofiea
è sotteso un libero impianto
sonatistico, con doppia
esposizione (strofe l e 2),
sviluppo (strofa 3, vv. l
-2) e ripresa. Né manca il
canonico dualismo tematico:
esaltata ed esuberante la
prima idea, più meditativa
la seconda (alle parole
“Wenn der Kummer naht”). Il
tema della nullità e
caducità dell’uomo assume
qui toni di tragico
demonismo, suggellato dal
cupo refrain “Dunkel
ist das Leben, ist der Tod”
(“Oscura è la vita, è la
morte”).
Nel secondo lied, Der
Einsame im Herbst, è
adombrato il desolato
paesaggio di un essere
solitario, soltanto
desideroso dell'ultima pace,
dell’ultima dimora.
L'orchestrazione è parca,
quasi cameristica, ispirata
a un principio di polifonia
lineare radicale dove la
voce e gli strumentini
solisti si stagliano a più
riprese sullo sfondo
ossessivamentc monotono dei
violini, emblematico
dell’indifferenza in cui si
compie l’amaro destino
umano.
Von der
Jugend sembra evocare
come in una miniatura
un’utopia di socievolezza.
Ma la fragile patina
incantata è solo uno schermo
dei contenuti più veri, già
smascherati dal tono
meccanico di filastrocca e
quindi dal passaggio al modo
minore nella quinta strofa,
là dove l’immagine del
padiglione di porcellana
appare “bizzarramente
riflessa” e sottoposta ad un
gioco di specchi deformanti.
Come negli altri lieder del
Canto della terra, il
materiale esotico (spunti
pentatonici, soluzioni
timbriche caratteristiche),
lontano dall’originare un
seducente tono fiabesco,
tipico di tante “cineserie”
di quell’epoca, crea
piuttosto un effetto di
straniamento. L'esotismo del
ciclo mahleriano discopre
così ragioni ben più
profonde e oscure: non
gratificante e suggestivo
colorito atmosferico, ma
modulo inquietante per
sottolineare una dimensione
deformata, una visione
onirica segnata da intime
lacerazioni e dissociazioni.
E in questa prospettiva di
distorsione straniante il
mito della giovinezza, come
il Dorian Gray di Oscar
Wilde, svela la sua più
autentica e vera essenza di
larva ingannevole.
Analoga è la
poetica in Von der
schönheit:
all’immagine floreale delle
belle fanciulle (già
incrinata dalla fissità di
moduli pentatonici e da
stranianti effetti esotici)
segue una sezione intermedia
incentrata sui “bei
giovani... a cavallo di
animosi destrieri”. Il
linguaggio musicale
realistico, definito da una
dura condotta lineare e
taglienti urti timbrici,
crea una temperie di crudi
colori che rimanda a
significati ideali ben più
profondi: sembra il violento
insorgere di una crisi
nevrotica, al cui impatto il
mito della bellezza, uno dei
“fradici gingilli di questa
terra” (come recitava il
lied iniziale), non può che
crollare e dissolversi. Così
la ripresa conclusiva del
lied, là dove appare la più
bella delle fanciulle, non
può che ripiegare
dolorosamente nella
struggente amarezza per un
miraggio svanito.
Una variazione
tragicamente umoristica del
tema della nullità di ogni
cosa è offerta dal quinto
lied, Der Trunkene im
Frühling, un alienante
brindisi all’infelicità.
Consapevole della caducità
della vita e del valore
effimero d’ogni sua gioia,
all’uomo non resta che
ottenebrare la propria
coscienza nei fumi del vino.
Il richiamo della natura
(qui è l’uceello che
annuncia la primavera) non
può rompere l’allucinante
incantesimo di ebbra
eccitazione di cui la
musica, nel sue
stravolgimento quasi
espressionistico, nella sua
artefatta esaltazione
(l’ebbro sa cantare solo in
modo maggiore!), rivela
tutta la menzogna.
Nucleo ideale
dell’intero Lied von der
Erde, Der Abschied
è una delle pagine piu
sconvolgenti di tutta la
letteratura musicale. Sia la
prima che la seconda parte
(su liriche di autori
differenti) si avviano come
una cupa marcia funebre,
segnata dagli inesorabili
colpi del tam-tam (e
suggellata nella seconda
parte dalle sorde sonorità
di corni e tromboni), per
aprirsi nel sccondo tenia
(“Der Bach singt” nella I
parte, “Ich wandle nach der
Heimat!” nella II) e nel
terzo tenia (“Ich
sehne mich” nella I parte,
“Die liebe Erde” nella II) a
squarci lirici, a un melos
“infinito” e irrisolto in
cui sembra realizzarsi un
surreale equilibrio di
algida linearità e scavo
emotivo, mentre il tessuto
orchestrale, spesso ridotto
a uno scarno aggregato,
sembra evocare abissi
esistenziali. Gli strumenti,
atomizzati e dispersi in
solitudini agghiaccianti, si
frantumano ncll’epilogo in
sonorità sempre più
dissociate, tra le spente
interiezioni del contralto
“ewig... ewig...”. E in
questo quadro di sgomenta
solitudine, dove l’unica
istanza di liberazione è la
dissoluzione nell’eterno
ciclo della natura, ma priva
del conforto di una
fideistica visione
panteistica, si consuma
infine anche il commiato
dalla sensibilità romantica,
da tutta un’epoca storica.