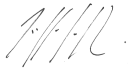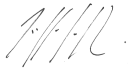|
Fra i
varii influssi cui la cultura
tedesca si apre
d’improvviso nell’ultimo
decennio dell’Ottocento,
al termine di un secolo di
sostanziale chiusura
ad apporti europei, si impone
quello che definiremmo
una sorta di impressionismo
simbolico e
decadente. La sua provenienza
spazia, per citare
soltanto nomi che
influenzeranno gli esordii
musicali
di Schönbcrg, dal franco-belga
Maeterlinck al
danese Jacobsen (sul cui testo
saranno composti i Gurrelieder).
Prodotto di questa apertura
culturale, di
natura eminentemcnte
eclettica, ma pure sintesi del
cattivo gusto che le si
accompagna, è Richard
Dehmel, autore di quella Verklärte
Nacht (Notte
trasfigurata) che Schönherg
intese illustrare ed interpretare
con un “poema sinfonico”
composto nel 1899
per il singolare organico
cameristico costituito da
un sestetto d’archi (la
trascrizione per orchestra
d’archi risale al 1917 ed è
stata riveduta nel
1943).
La trasfigurazionc di cui
parla il titolo è la trasformazione
di un tema tragico, e tuttavia
intriso di sentimentalismo,
in sogno e redenzione mistica.
Una
chiara notte di luna (fredda e
stanca, ma non ancora
malata come quclla di Pierrot)
accoglie due amanti che
passeggiano in un parco: la
trascrizione emotiva del
testo poetico, secondo una
breve analisi dello stesso
autore, è pressoché letterale.
In un drammatico colloquio la
donna confessa al compagno di
aspettare un bambino da un
altro uomo, incontrato prima
di lui, ma la sua infelicità
(tema discendente ai
violoncelli con caratteristica
nota puntata) non le impedisce
di amarlo profondamente.
Mentre
una successionc veemente ed
appassionata dei violini
(irregolarità ritrniche di
terzine e sestine) ne esprime
il senso di colpa, una marcata
scansione nel grave è la voce
del suo terrore per il
giudizio dell’amato. Ma la
risposta dcll’uomo, l’ampia
melodia morbida e affettuosa,
all`acuto dei violini ed
annegata in uno sfavillare di
luci, di suoni arrnonici, di
pizzicati e di disegni
ondcggianti, splende di un
ardore che sa trovare negli
incanti della natura la linfa
della sua generosità. Il
colloquio è ora un dialogo
d’amore e il figlio dell`altro
sarà una loro creatura.
Il lettino del dottor Freud è
ancora lontano e la
passeggiata nel bosco non si
trasforma in un incubo
dell'inconscio come, di lì a
qualche anno, in Erwartung,
ma in un trepido sogno:
altrellanto lontano è
l’atematismo di quel
capolavoro successivo. Qui, lo
straordinario fluire di una
vena esuberante e turgida, ma
non priva di anticipazioni Jugendstil,
ancora intesse temi e motivi
sul modello della variazione
brahmsiana e rivive armonie ed
enfasi wagneriane.
Il poema
sinfonico Pelleas und
Melisande, del 1902-03,
segue “da capo a fondo lo
splendido dramma di
Maeterlinck”. Vi sovrappone
tuttavia uno schema in quattro
parti che riprende il classico
modello della sinfonia. La
prima sezione, l’incontro tra
Golaud e Melisande
nell'oscurità della foresta,
ha il carattere tragico e
angoscioso di un appuntamento
col destino (tema con settima
maggiore ascendente). In una
compresenza di linee e
frammenti derivati, che
intrecciano, qui come in altri
passi del lavoro, tessuti
polifonici d`inestricabile
densità, emergono i Leitmotive
dei personaggi: tenera c
indifesa la melodia all’oboe
di Melisande, espansivo il
tema di Golaud ai tre corni,
eroico e appassionato, alla
tromba, quello di Pelleas.
La scena
della fontana, seconda parte,
funge da scherzo. Golaud cade
da cavallo nell’istante in cui
l'inconsapevole Melisande
perde la sua vera nuziale nel
pozzo. Quando la fanciulla
lascia fluire dal balcone i
suoi lunghi capelli biondi, su
festoni di terzine (quanto di
vegetale posseggono le
immagini femminili di quegli
anni!), sullo sfondo delle
arpe due violini suonano il
suo motivo mentre un
violoncello solo pronuncia il
tema di Pelleas. Il successivo
episodio, con Golaud che guida
Pelleas nei sotterranei del
castello, in un`autentica
discesa agli inferi, è tra i
vertici inventivi della
composizione: livido di
stagnanti fissità marine e di
misteriosi risucchi (i
celebrati, e mai prima
sperimentati, glissandi di
tromboni).
Un lungo tema d’amore,
insolitamente non oscurato da
cromatismi, apre l'ampio
‘adagio’ e si estende con
crescente fervore fino
all'estatico abbraccio degli
amanti, crudelmente interrotto
dall’aspro intervento di
Golaud, che uccide Pelleas.
L’ultima parte suona come una
grande ricapitolazione
tematica (Berg individuò non
meno di venti temi conduttori
nell’opera) e si apre con il
tema della morte dell’inizio.
Reminiscenze tristaniane ed
echi straussiani si fondono,
in un costante ampliamento
degli orizzonti tonali, con
premonizioni berghiane.
Straordinaria, sul tema di
Melisande riesposto a mo’ di
corale dagli ottoni, una
discesa di flauti e ottavini
sulla scala per toni interi,
prima che il tema del destino
suggelli la vicenda.
|