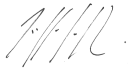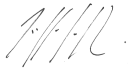La prima
esecuzione assoluta della Sinfonia
in la b. M op. 55 ebbe
luogo alla Free Trade Hall
di Manchester il 3 dicembre
1908. Agli amici Ernest
Newman e Walford Davies, che
gli avevano chiesto qualche
dichiarazione da inserire
nel testo dei programrni di
sala, Elgar si era limitato
a dire poche parole: “Al di
là delle note non c’e una
specifica vicenda, tanto
meno un programma: c’è però
il frutto di una vasta
esperienza esistenziale,
nutrito di amore per il
prossimo e di grande
speranza per il futuro”.
August
Johannes Jaeger, amico di
tutta una vita, a cui il
musicista aveva dedicato il
celebre “Adagio” (“Nimrod”)
della nona variazione di
Enigma, sfogliando la
partitura aveva notato: “Il
movimento lento della Prima
Sinfonia è degno di
Beethoven: autentico,
originale e nobile”. Sulla
medesima lunghezza d’onda
vennero a sintortizzarsi le
recensioni dell’opinione
pubblica inlese, per la
quale non era soltanto la Prima
di Elgar, ma la vera e
propria “prima” sinfonia
della letteratura musicale
britannica. Nonostante la
tradizionale compostezza, il
pubblico csplose in un
diluvio di applausi al
termine dell‘“Adagio”
e il direttore Hans Richter,
per nulla contrariato,
invitò l’autore alla ribalta
sin da quel momento, senza
attendere la conclusione del
lavoro.
Quattro giorni
dopo, allorché lo stesso
Richter presentò a Londra la
Sinfonia in la b. M
alla Queen’s Hall alla testa
della London Symphony
Orchestra, prima di dar
inizio alle prove si rivolse
agli strumentisti
dichiarando: “Cari signori,
stiamo per eseguire la più
irnportante Sinfonia dei
tempi moderni, e non
soltanto di questo paese.
L’Adagio è un movimento
lento che Beethoven avrebbe
potuto scrivere”. Le
ovazioni si rinnovarono dopo
ogni movimento e al termine
fu un assoluto trionfo,
propagatosi poi in tutta
Europa, con ottantadue
esecuzioni nel solo 1909, a
Vienna come a Lipsia e a
Berlino, ma anche a San
Pietroburgo, in America e a
Sydney. Le considerazioni
più meditate della critica
inglese avevano individuato
nella grandiosità di
respiro, nell’intensità
dell’espressione e nella
nobiltà degli accenti i
tratti maggiormente
caratterizzanti dell’intero
lavoro, uno dei capisaldi
dell’arte di Elgar.
Al pari di
Brahms, anche Sir Edward
Elgar sembrava aver voluto
attendere la maturità per
affrontare il genere
sinfonico, nonostante che
già da una decina d’anni un
simile intento ritornasse di
frequente nel suo
epistolario. Più che per
ragioni estetiche o legate
all’evoluzione della sua
personalità creativa,
quell’eccesso di prudenza e
di circospezione nel
dedicarsi ad una
composizione orchestrale di
ampie proporzioni dipendeva
dalla riluttanza ad
abbandonare l’ambito più
familiare dei grandi
monumenti corali che gli
avevano dato fama, onori e
sicuri cespiti finanziarii,
da Caractacus (1898)
al Dream of Gerontius
(1900), a The Apostles
(1907). Elgar, tuttavia,
aveva registrato importanti
successi anche nel campo
esclusivarnente orchestrale:
basti pensare alle “Enigma”
Variations (1897), a In
the South (1904), ad Introduction
and Allegro (1905).
A
cinquant’anni Elgar entrò
finalmente nell’ordine di
idee di cimentarsi
nell’agone sinfonico, in un
genere cioè che la poetica
del tardo romanticismo
esaltava come il vertice di
ogni aspirazione
compositiva, e insieme,
punto d’incontro delle
emozioni soggettive e dei
mezzi linguistici al grado
più elevato. Dall’epoca
della Quarta Sinfonia
(1885) di Brahms, aucor più
dalla stagione dei poemi
sinfonici di Richard
Strauss, principiata da Aus
Italien (1886) e Macbeth
(1888), ferveva nella
cultura europea il dibattito
sul “nuovo” nel progresso
dell’arte, identificato non
soltanto nell’adesione alla
poetica, d’ascendenza
berlioziana, della musica a
programma, rna anche nella
dissoluzione del linguaggio
che gli autori
post-wagneriani, specie nei
paesi tedeschi, stavano
conducendo alle estreme
conseguenze, oltre i limiti
delle quali non sarebbe
rimasto altro che cambiare
strada o tornare sui propri
passi. Lo stesso Elgar,
durante un ciclo di
conferenze all’Università di
Birmingham nel 1905, si
soffermò sull’antinomia tra
musica assoluta e musica a
progrannna, affermando senza
mezzi termini che per lui
“la sinfonia senza un
programma costituiva
l’obiettivo più alto dello
sviluppo evolutivo
dell’arte”.
Eppure, anche
se non in forma esplicita,
un’idea-motto,
dall'atteggiamento
strumentale di marcia,
informa l’avvio della Prima
Sinfonia ritornando
nel finale. Un motivo che,
secondo la testimonianza
della consorte del musicista
inglese, Elgar suonava al
piano con vivo compiacimento
già nel tardo giugno del
1907.
La
composizione della Prima
Sinfonia fu iniziata a
Roma nell’inverno del 1907/8
quando, oltre al primo
movimento, fu abbozzato
l’inizio del secondo. Al
ritorno in patria,
nell’amata dimora di Plas
Gwyn, a Hereford, la
scrittura del lavoro si fece
pressante, con ultimazione
della partitura il 6
settembre del 1908.
Significativa la dedica a
Hans Richter, “vero artista
e vero amico”. Pubblicata
nello stesso anno da
Novello, la Prima,
della quale lo stesso Elgar
curò un'incisione nel 1930
sul podio della London
Symphony Orchestra, esige un
vasto organico comprendente
tre flauti e ottavino, corno
inglese, oboi, clarinetti e
fagotti a due, clarinetto
basso e contrafagotto,
quattro corni, tre trombe e
tre tromboni, bassotuba,
percussioni, due arpe e i
consueti archi.
Nella
trasparenza della trama
sinfonica, nonostante la
varietà e la complessità dei
mezzi orchestrali che
entrauo in gioco, si possono
cogliere certe connotazioni
linguistiche che denunciano,
secondo taluni, qualche
affinità con l’epos
mahleriano, mentre il
maestoso respiro del
movimento lento, nonché il
coinvolgimento di soggetti
tematici secondari nel
processo elaborativo, fanno
pensare un po’ a Bruckner.
L’articolazione del
movimento iniziale
(“Andante. Nobilmente e
semplice - Allegro”)
contempla una sezione
introduttiva, pacata e
solenne, che trascorre
all'"Allegro", animatissimo
e appassionato, ove colpisce
l’insolita strategia tonale
dispiegata dall’autore nel
dar ampio spazio alle varie
idee, principali e
secondarie, nella ricchezza
dell’eloquenza strumentale,
melodica e ritmica, siglata
da una suggestiva coda per
archi divisi. Una sorta di
scherzo è il secondo
movimento (“Allegro molto”)
in fa diesis minore con il
trio in si bemolle, nella
sfavillante vivacità delle
entrate degli archi e poi
dei fiati. Al cuore della Prima
Sinfonia, e della sua
celebrità tanto conclamata,
v’è il movimento lento
(“Adagio”), permeato d’una
intensa estasi lirica, che
trova, quasi alla fine del
brano, una linfa rinnovata
nell’enunciazione di una
nuova idea, “molto
espressiva e sostenuta”.
Infine il quarto movimento
(“Lento - Allegro -
Grandioso”) esalta il
magistero della scrittura
elgariana, il perfetto
controllo di tutte le
risorse della grande
orchestra tardo-romantica,
il vigore, l’autonomia,
l'originalità della
discorsività sinfonica.
La
glorificazione in musica
dello spirito vittoriano al
culmine del suo splendore,
quando l’Impero di Sua
Maestà britannica spaziava
su tutti i continenti, non
poteva trovare
un’incarnazione più
esauriente che nel ciclo
delle marce rubricate sotto
il titolo Pomp and
Circumstance op.39 e
che comprendono quattro
lavori scritti da Elgar fra
il 1901 ed il 1907, mentre
una quinta vide la luce nel
1930 e di altre sono
rirnasti vari abbozzi nello
scrittoio del compositore.
La più famosa e la N. 1
in re M, per il
suggestivo, sereno e
coinvolgente incedere della
sezione del trio denominata
“Land of Hope and Glory”.
Ultimata nell’agosto del
1901, dopo una prima
esecuzione a Liverpool
conobbe il trionfo a Londra,
con Sir Henry Wood sul podio
del Promenade Concert a
Queen’s Hall, quando il
pubblico, in preda ad un
entusiasmo irrefrenabile, ne
ottenne l'immediato bis.
La Marcia n. 4 in sol M
(1907) presenta qualche
affinità con la “Marcia dei
contrabbandieri” dalla Carmen
ed ha anche qualcosa di
ciaikovskiano (dallo Schiaccianoci).
Luigi
Bellingardi