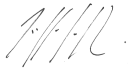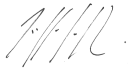|
Gentiluomo
dell’età vittoriana, Sir
Edward William Elgar è un
brillante e sicuro
compositore, il cui linguaggio
tardo-romantico deriva dal
sinfonismo europeo
dell’Ottocento, in particolare
tedesco, dal quale mutua la
struttura formale,
l’elaborazione tematica e il
magistero della scrittura
strumentale. A queste qualità
Elgar aggiunge, di
spiccatamente suo, un certo
spirito contemplativo e
l’influsso della natura.
Musicista di formazione
cosmopolita, Elgar credeva
nella immediatezza
dell’ispirazione: soleva
spesso dire “la musica è
scritta sulle nuvole del
cielo, e nell’aria
tutt’attorno a noi, basta
stendere la mano e prenderne
quanta se ne vuole”.
La fama
di Elgar è principalniente
legata al successo delle Enigma
Variations (1899),
dell’oratorio The Dream of
Gerontius (1900) e di
alcuni lavori orchestrali come
le Sinfonie n. 1
(1908) e n. 2 (1911),
il poerna sinfonico Falstaff
(1913) nonché il ciclo delle
marce Pomp and
Circumstance
(1901-1930). Nell’ambito
concertistico si ricordano il
Concerto per violino
(1910), varie pagine
cameristiche e vocali e anche
di soggetto sacro. Nella
generalità della sua opera
creativa si impone
l'incontrastata presenza di un
afflato melodico largamente
influenzato dal canto popolare
inglese. Sotto tale riguardo
Elgar fu infatti un pioniere e
un caposcuola della rinascita
di un linguaggio nazionale
britannico, all’alba del
Novecento, dopo l’oblio in cui
L'Inghilterra era vissuta,
quale paese musicale, nel
corso del XIX secolo.
Composto
prevalentemente nell’inverno
1918-19, il Concerto in mi
minore per violoncello e
orchestra fu ultimato
nell’agosto 1919 a Brinkwells
con la dedica a Sidney e
Frances Colvin, amici
carissimi del musicista. La
prima esecuzione assoluta si
svolse a Londra, alla Queen’s
Hall, il 26 ottobre dello
stesso anno con l’autore sul
podio e Felix Salmond come
solista all’arco. Il successo
fu soltanto di stima perché
Albert Coates, che nella
medesima serata completava il
programma dirigendo il Poema
dell'estasi di Scriabin
e la Seconda Sinfonia
di Borodin, si era accaparrato
gran parte del tempo destinato
alle prove. Uno dei testiruoni
dell’evento fu uno
strumentista della compaginie
orchestrale, violoncello di
fila diciannovenne, John
Barbirolli, il futuro grande
direttore. Nel ricordare
quella première, Barbirolli
precisa che, “nonostante la
tarda età del compositore, non
vi era nel lavoro alcuna
traccia di epigonismo
romantico o di crepuscolarismo
nella vena inventiva”.
Mentre
scriveva questa musica, che è
da considerarsi tra i lavori
più emblematici della sua
produzione, Elgar non faceva
mistero dell’angoscia che
l’aveva attanagliato durante
la prima guerra mondiale che,
al suo aninio d’artista, si
rivelava sempre più come una
svolta cruciale della cultura
europea, quasi il punto
terminale dell’era di una
civiltà. Di tale compianto
elegiaco per un “mondo di
ieri” sempre più lontano, il Concerto
per violoncello è, in un
certo senso, l'espressione al
pari del Finale della Seconda
Sinfonia e dei suoi cupi
presagi. Sotto parecchi
aspetti, nella concatenazione
del materiale tematico e nella
sagacia della scrittura
strumentale, questo lavoro può
essere accostato al Concerto
per violoncello di
Dvořák, mentre, nel riflettere
l’osmosi tra biografismo e
arte della produzione
elgariana, si può concordare
con l’opinione di Michael
Kennedy, secondo il quale
“soltanto Mahler, con la
temperie dramrnatica della Sesta
Sinfonia, ha individuato
con pari forza nella sua
musica il presagio del proprio
destino”.
Il Concerto
in mi minore si apre con
un breve recitativo del
violoncello solista (Adagio).
Il primo movimento, Moderato,
enuncia una bella idea
tematica nel canto delle viole
in 9/8, ripreso dal
violoncello in un contesto
formale A-B-A ove la sezione
centrale in 12/8, introdotta
dal clarinetto, è in sol
maggiore. Senza soluzione di
continuità un breve assolo del
violoncello conduce al secondo
movimento, Allegro molto,
costruito sulla forma-sonata
liberarnente intesa, con una
scansione ritmica un po’
ossessiva e marcatamente
pronunciata e un bel risalto
al carattere “puntilista”
della scrittura strumentale
con gli archi divisi e leggeri
accordi degli ottoni. In si
bemolle maggiore si dipana il
terzo tempo, Adagio,
segnato da una spiccata
effusione melodica.
L’introduzione al Finale
sfocia nel movimento di
maggior respiro di questo
concerto, l’Allegro, ma non
troppo in forma di rondò
nella tonalità principale di
mi minore, ove la seconda idea
si caratterizza per la nobiltà
del suo incedere. Poco prima
della conclusione, un breve
episodio lento rammenta,
sull’esempio di Dvořák,
un’intensa frase dell’Adagio
e il Concerto in mi minore
approda, quasi
improvvisamente, alla fine,
fondendo strettamente assieme
il canto del violoncello
solista e il vigore espressivo
dell’orchestra.
*****
Alla scoperta
predilezione di Ciaikovski per
Mozart e, più in generale, per
il Settecento, sono
riconducibili l’ispirazione e
la genesi di questo lavoro,
scritto nel 1876 a beneficio
di Wilhehn Fitzenhagen,
celebre violoncellista tedesco
e didatta al conservatorio di
Mosca. Probabilmente l’epoca e
l’opera tanto ammirate da
Ciaikovski si identificavano
in un Settecento di maniera e
in una sorta di paradiso
perduto dell’armoniosa
euritmia degli schemi formali:
il tutto contemplato,
ovviamente, con gli occhi di
un protaonista dell’età
romantica.
Ciaikovski
non aveva molta familiarità
con le risorse tecniche del
violoncello e di buon grado si
risolse a ricorrere
all’ausilio di Fitzenhagen e
della sua esperienza. Ma
questi, con il pretesto di
rivedere e di abbellire la
scrittura della parte del
solista, non esitò a procedere
a non poche modifiche
sostanziali oltre che ad
alterare anche l’ordine delle
variazioni, rispetto
all’originaria stesura
Ciaikovskiana. Fitzenhagen
aveva, comunque, dalla sua
parte, un virtuosismo
eccezionale sì che la prima
esecuzione delle Variazioni
su un tema rococò op. 33
fu salutata da un franco
successo di pubblico e di
critica a Mosca il 18 (30)
novembre 1877, sul podio
Nikolai Rubinstein.
Qualche
tempo dopo, senza interpellare
l’autore, Fitzenhagen
procedette ad altre, ancor piu
sostanziali modifiche alla
stessa partitura e tale
rinnovata versione egli
presentò a Wiesbaden nel
giugno del 1879 riscuotendo,
tra l’altro, il consenso
entusiastico di Liszt. Da
allora, delle Variazioni
su un tema rococò viene
normalmente suonata l’ultima
stesura revisionata da
Fitzenhagen e pubblicata da
Jurgenson nel 1889, con il
consenso, seppur riluttante,
di Ciaikovski. In tempi
recenti in Unione Sovietica è
stata riesumata la prima
stesura autografa ed inserita
nel 1956 nell’edizione
nazionale.
Dopo una
breve introduzione
dell’orchestra, il violoncello
solo enuncia il Tema
che è una bella frase melodica
dal profilo aggraziato e dalla
casta, classica espressività.
A questa idea risponde un
breve inciso, assai più
personale, che, nel gioco dei
legni con la replica del
solista, funge da ritornello a
riappare più volte nel corso
dell’intero lavoro. Intessuta
di brillanti fioriture è la Variazione
I che si allaccia, nel
medesimo tempo, alla Variazione
II, caratterizzata da
un’atmosfera prossima ai
momenti più felici della vena
ballettistica dell'autore. La
Variazione III ha un
incedere sostenuto mentre
nella IV risultano
combinati assieme spunti del
terna e del ritornello. Nel
corso della Variazione V
il violoncello si impegna in
brillanti passaggi ornamentali
e da vita a due cadenze
solistiche, la seconda delle
quali crea un ponte per la Variazione
VI ove il tema
originario ritrova la sua più
schietta cantabilità sui
pizzicati degli archi. Infine
la Variazione VII dà
un’evidenza sempre maggiore al
ruolo del violoncello solista
sino a concludere la
composizione in un clima
improntato ad una doviziosa
seduzione sonora.
Luigi
Bellingardi
|