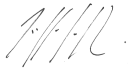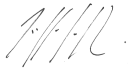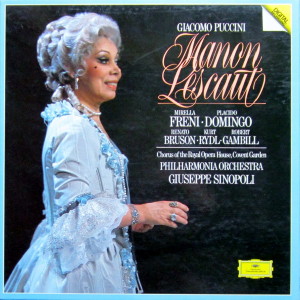 |
|
DG - 3
LPs - 413 893-1 - (p) 1984
|
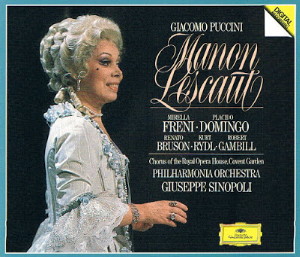 |
| DG - 2
CDs - 413 893-2 - (p) 1984 |
|
.jpg) |
| DG - 1
CD - 445 466-2 - (p) 1984 |
|
| Giacomo
PUCCINI (1858-1924) |
|
|
|
|
|
|
|
| Manon Lescaut |
|
122' 44" |
|
| Dramma lirico in
quattro atti (Libretto: Marco
Praga, Domenico Oliva, Giulio
Ricordi , Luigi Illica, Giuseppe
Giacosa da Abbé Prèvost) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Long Playing 1 |
|
35'
57" |
|
ATTO
PRIMO
|
1.
"Ave, sera gentile" (Edmondo,
Studenti, Fanciulle, Borghesi) |
4' 16" |
|
* |
|
2.
"L'amor? l'amor?!" (Des Grieux,
Edmondo, Studenti) |
1' 06"
|
|
*
|
|
3. "Tra voi,
belle, brune e bionde" (Des
Grieux, Edmondo, Studenti) |
1' 26" |
|
*
|
|
4.
"Ma bravo!" (Edmondo, Studenti,
Fanciulle, Borghesi) |
1' 54"
|
|
|
|
5.
"Discendono, vediam!" (Borghesi,
Edmondo, Studenti, Lescaut, Oste,
Des Grieux, Geronte) |
2' 04" |
|
|
|
6.
"Cortese damigella" (Des Grieux,
Manon, Lescaut) |
4' 12"
|
|
*
|
|
7.
"Donna non vidi mai" (Des
Grieux) |
2' 19" |
|
*
|
|
8.
"La tua ventura ci rassicura" (Edmondo,
Studenti, Fanciulle, Geronte,
Lescaut, Borghesi, Oste) |
6' 36" |
|
|
|
9.
"La tua Proserpina" (Edmondo,
Des Grieux) |
2' 12" |
|
*
|
|
10.
"Vedete? Io son fedele" (Manon,
Des Grieux) |
4' 03" |
|
*
|
|
11.
"Non c'è più vino?" (Lescaut,
Des Grieux, Manon, Edmondo,
Geronte, Oste) |
2' 56" |
|
*
|
|
12.
"Cavalli pronti avete?" (Lescaut,
Geronte, Edmondo, Studenti) |
2' 53" |
|
|
|
Long Playing 2 |
|
41'
31" |
|
| ATTO
SECONDO |
1.
"Dispettosetto questo riccio!" (Manon,
Lescaut) |
5' 38" |
|
|
|
2.
"In quelle trine morbide" (Manon) |
2' 20" |
|
*
|
|
3.
"Poiché tu vuoi saper" (Lescaut,
Manon) |
3' 18" |
|
|
|
4.
"Che ceffi son costoro? ... Sulla
vetta tu del monte" (Madrigale) (Lescaut,
Manon, Voce sola, Coro) |
2' 10" |
|
|
|
5.
"Paga costor!" (Manon, Lescaut) |
1' 22" |
|
|
|
6.
"Vi prego, signorina (Minuetto) ...
L'ora, o Tirsi, è vaga e bella" (Maestro
di Ballo, Geronte, Manon, Signori,
Abati) |
8' 59" |
|
|
|
7.
"Oh, sarò la più bella! ... Tu, tu,
amore? Tu?" (Manon, Des Grieux) |
8' 26" |
|
*
|
|
8.
"Ah! ... Affé, madamigella" (Manon,
Geronte, Des Grieux) |
1' 55" |
|
|
|
9.
"Ah! ah! Liberi! ... Ah! Manon, mi
tradisce" (Manon, Des Grieux) |
3' 57" |
|
|
|
10.
"Lescaut? Tu qui?" (Des Grieux,
Manon, Lescaut, Sergente) |
3' 26" |
|
|
|
Long Playing 3 |
|
45'
16" |
|
| INTERMEZZO |
1.
(Strumentale) |
5' 35" |
|
|
| ATTO TERZO |
2.
"Ansia eterna, crudel" (Des
Grieux, Lescaut, Manon) |
4' 41" |
|
*
|
|
3.
"... e Kate ripose al Re" (Lampionaio,
Des Grieux, Manon) |
1' 26" |
|
*
|
|
4.
"Manon, disperato è il mio prego!" (Des
Grieux, Manon) |
1' 27" |
|
*
|
|
5.
"All'armi! All'armi!" (Voci,
Lescaut, Des Grieux, Manon,
Borghesi, Popolani, Sergente,
Comandante) |
1' 44" |
|
*
|
|
6.
"Rosetta! ... Eh! Che aria!" (Sergente,
Borghesi, Popolani/Lescaut, Gruppo
di borghesi/Manon, Des Grieux) |
4' 03" |
|
|
|
7.
"Presto! In fila! ... No! pazzo
son!" (Sergente, Des Grieux,
Gruppo di borghesi, Comandante) |
3' 58" |
|
*
|
| ATTO QUARTO
|
8.
"Tutta su me ti posa" (Des
Grieux, Manon) |
3' 04" |
|
*
|
|
9.
"Manon, senti, amor mio ... Vedi,
son io che piango" (Des Grieux) |
2' 10" |
|
*
|
|
10.
"Sei tu che piangi?" (Manon, Des
Grieux) |
4' 25" |
|
*
|
|
11.
"Sola, perduta, abbandonata" (Manon) |
5' 28" |
|
*
|
|
12.
"Fra le tue braccia, amore" (Manon,
Des Grieux) |
7' 15" |
|
|
|
|
|
|
|
| Mirella FRENI, MANON
LESCAUT |
CHORUS OF THE ROYAL
OPERA HOUSE, COVENT GARDEN |
|
| Renato BRUSON, LESCAUT,
sergente delle guardie del Re |
Nina Walker, Chorus
Master |
|
| Placido DOMINGO,
IL CAVALIERE RENATO DES GRIEUX, studente |
PHILHARMONIA
ORCHESTRA |
|
| Kurt RYDL, GERONTE
DI RAVOIR, tesoriere generale |
Giuseppe SINOPOLI |
|
| Robert GAMBILL,
EDMONDO, studente |
Musical Assistance:
Paul Wynne Griffiths |
|
| George MACPHERSON,
L'OSTE |
|
|
| John FRYATT, IL
MAESTRO DI BALLO |
|
|
| Brigitte FASSBAENDER,
UN MUSICO (voce sola) |
|
|
| Handel THOMAS, SERGENTE
DEGLI ARCIERI |
|
|
| Mark CURTIS, UN
LAMPIONAIO |
|
|
| John TOMLINSON,
UN COMANDANTE DI MARINA |
|
|
| Paschal ALLEN, UN
SERGENTE |
|
|
| CORO (Madrigale) |
|
|
| Elizabeth Stanford, Iris Saunders,
Elizabeth Sikora, Jean Tredaway |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Kingsway
Hall, London (Gran Bretagna) -
dicembre 1983 e gennaio 1984
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio
|
|
|
Production |
|
Günther
Breest |
|
|
Coordination |
|
Claudia
Hamann |
|
|
Recording
Supervision |
|
Wolfgang
Stengel |
|
|
Recording
Engineer |
|
Klaus
Hiemann |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Deutsche
Grammophon | 413 893-1 | LC 0173
| 3 LPs - 35' 57", 41' 31" &
45' 16" | (p) 1984 | Digital |
|
|
Prima Edizione
CD |
|
Deutsche
Grammophon | 413 893-2 | LC 0173
| 2 CDs - 59' 42" & 62' 59"
| (p) 1984 | DDD
Deutsche
Grammophon | 445 466-2 | LC 0173
| 1 CD - 66' 15" | (p) 1984 |
DDD | Highlights *
|
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Con passione
disperata"
Sulla genesi della "Manon
Lescaut" di Puccini
"La preghiera di Des Grieux
dev’essere un liebig
di insistenza e di commozione
comunicativa.”
(Puccini al suo
librettista Illica, il 25
aprile 1892)
Quando il primo febbraio 1893 fu
rappresentata per la prima volta
al Teatro Regio di Torino “Manon
Lescaut”, terza opera di
Puccini, alla Scala di Milano
avevano luogo le ultime prove
per la prima del “Falstaff”
verdiano: l’opera italiana del
secolo XIX si trovava ad una
significativa svolta della sua
storia. All’incirca dal 1865 il
melodramma di tipo verdiano era
stato oggetto di ripetute
critiche da parte degli
‘scapigliati’ capeggiati da
Arrigo Boito. In tali critiche
era viva l’aspirazione a
trasformare - sotto
l’impressione esercitata dai
drammi musicali wagneriani - le
strutture fondamentali del
teatro d’opera; rna alle
esigenze teoriche non seguirono
delle opere che potessero tenere
il confronto e costituire
un’alternativa ai melodrammi
verdiani. Con l’insorgere del
Verismo - di per sé una corrente
in primo luogo letteraria, che
va vista innanzi tutto come il
tentativo compiuto da una
giovane generazione di poeti di
dare un’adeguata espressione
artistica alla realtà del
Mezzogiorno italiana - si videro
agire congiuntamente nel teatro
d’opera l’aspirazione ad una più
realistica organizzazione
temporale degli eventi
rappresentati e soprattutto la
tendenza alla scelta d’argomenti
più vicini alla vita reale. I
successi conseguiti dalle due
brevi opere di Pietro Mascagni e
Ruggero Leoncavallo -
“Cavalleria rusticana” nel 1890
e “Pagliacci” nel 1892, e cioè
poco prima che fosse
rappresentata “Manon Lescaut” -
sembravano indicare una
possibilità di realizzazione del
Verismo in musica. Ma la
schematizzazione di questo
periodo dell’opera italiana
sotto il comune denominatore del
Verismo rimane insufficiente ed
inadeguata: ciò diviene chiaro
se si considera non solo il
fatto che Puccini scelse per
soggetto della sua opera la
vicenda d’un romanzo apparso nel
1731, ma ancheche lo stesso
Leoncavallo, ancor prima di
comporre “I Pagliacci”, si provò
a scrivere un libretto di
“Manon” per Puccini. Più
importante della scelta
dell’argomento, che in special
modo nelle opere pucciniane non
rimase mai limitato al ristretto
ambito veristico, era invece la
possibilità di riprodurre
sviluppi psicologici in tutte le
loro ramificazioni; tale
possibilità risultava del resto
dal progressivo dissolversi
delle strutture musicali
tradizionali.
La
scelta pucciniana di far
trasformare in un libretto
d’opera il romanzo dell’Abate
Prévost “Histoire du Chevalier
des Grieux et de Manon Lescaut”
(Amsterdam 1731) può essere solo
spiegata tenendo conto del ruolo
predominante che nelle
situazioni conflittuali del
romanzo l’assunto della verità
psicologica veniva ad assumere
nei confronti del loro legame
con l’epoca della sua
composizione. Dopo le sue prime
opere “Le Villi” (1884) e
“Edgar” (1889), Puccini perviene
per la prima volta in “Manon
Lescaut” non solo a dispiegare
il suo linguaggio musicale ad un
compiuto grado di maestria, ma
anche a mostrare tutti i tratti
caratteristici della sua
specifica concezione teatrale.
La decisione di Puccini per il
romanzo di Prévost significava
un grande rischio: “Manon”,
l’opéra comique di Jules
Massenet rappresentata per la
prima volta nel 1884 a Parigi
con grande successo, cominciava
ad imporsi dappertutto, sì da
distogliere un compositore più
scaltrito dallo scriverne un
'doppione'. Anche se Puccini non
aveva visto l'opera di Massenet
prima di terminare la sua “Manon
Lescaut”, pure l’impianto
globale del suo libretto offre
una chiara prova di come egli si
sforzasse di evitare una
divisione in atti della vicenda
del romanzo che presentasse
delle analog1e con quella
adottata da Massenet.
Fallita
la collaborazione con
Leoncavallo, Puccini si rivolse
ad una coppia di librettisti; la
doppia paternità d’un libretto
rappresentava per l’opera
italiana un’innovazione, mentre
era quasi la regola nella
produzione librettistica
francese a partire da Eugène
Scribe. Contemporaneamente alla
realizzazione della originale
concezione pucciniana del teatro
musicale, cominciarono ad
insorgere dei contrasti tra il
compositore e i suoi
librettisti, e tale circostanza
accompagnerà come una costante
biografica la genesi delle sue
opere. Ma nessuna di queste
divenne per i librettisti un
calvario così sofferto come
“Manon Lescaut”! A Leoncavallo
seguì la coppia Marco
Praga/Domenico Oliva, che
presentò a Puccini uno schema
della trama in gran parte
analogo alla divisione in atti
dell’opera di Massenet:
Atto I: Amiens, incontro
Manon-Des Grieux, rapimento di
Manon.
Atto II: Parigi, Manon vive con
Des Grieux.
Atto III: Manon vive con il suo
ricco amante Geronte di Ravoir;
Manon riannoda il suo legame con
Des Grieux; arresto di Manon.
Atto IV: Morte di Manon nella
Luisiana.
Per
eliminare tali analogie Puccini
propose numerose modifiche; ciò
indusse Marco Praga a troncare
la sua collaborazione nella
stesura del libretto. Alcuni
mesi dopo Puccini inviò il
manoscritto di Oliva al suo
editore e amico paterno Giulio
Ricordi, insieme ad una lettera
che fornisce una eloquente
testimonianza delle precise idee
drammaturgiche del compositore:
Vacallo, settembre
1890
Gentilissimo
Sig. Giulio,
ho creduto bene inviarle il
manoscritto di Oliva acciooché
lo legga e si faccia un'idea
esatta dei difetti e delle
contorsioni che raochiude. Ci
sono delle buone cose, ma, per
esempio, il quartetto è
brutto. Non capisco perché
l'Oliva abbia abbandonato la
traccia che era così chiara. È
buona la prima scena fra
Geronte e Lescaut, e così la
seconda con Manon, salvo
qualche accorciatura quando
Lescaut va a prendere il
vecchio nascosto. Ci sono
quelli a parte che mi
sembrano troppo lunghi. Poi
veda il manoscritto e troverà
delle osservazioni quando
Lescaut parla con Des Grieux.
La traccia è chiara: “Eh| caro
mio, ci sono tanti mezzi per
far denaro quando si è
intelligenti ecc.: il gioco,
le belle donnine più o meno
giovani, ecc. ecc.”. Invece,
come vedrà dal libretto, tutto
ciò è incerto, contorto, lungo
... Poi, veda le osservazioni.
Non mi piace, perché Renato fa
una parte odiosa, quella
scomparsa per preparare i
rinfreschi di Lescaut e
Renato. Come Renato arriva al
punto di lasciare Manon a
disposizione del vecchio?! Si
ricorda quanto lottammo con
Leoncavallo per evitar ciò?
Veniamo, dopo molti
altri difetti, al quartetto.
Come era grazioso, logico,
interessante quello della
traccia! Quella entrata mitologica
di Geronte, poi quella guerra
in Polonia di Lescaut, per
distrarre Des Grieux. Quello
scoppiettìo di Geronte e
Manon! Poi era meglio che si
sedessero a tavola come s’era
deciso! Dov’è andato a finire
quel piccolo brindisi a
quattro, così bene a
proposito? ... Insomma tutta
quella scena in luogo del
quartettino a tavola, che era
rapida e succosa, è sostituita
da un'altra versione
eternamente lunga e
retoricamente loquace, a danno
della chiarezza e rapidità
dello svolgersi della
commedia. Va bene, dopo, la
partenza di Geronte, cioè
l’ultima scena. Insomrna io
non sono contento affatto
affatto, e credo che Lei sarà
del mio parere. L’essersi
scostato dalla traccia, in
qualche punto è stato di
miglioramento, ma, in molti
altri, di peggioramento.
Io all’Oliva
scriverò che il manoscritto
con alcune osservazioni è
presso di Lei. Ella a voce, la
prego, la scongiuro esponga il
contenuto di questa mia, e
tutto ciò che crederà logico
anche da parte sua.
Mi raccomando a Lei.
G.
Puccini
Dopo
che anche Oliva aveva rinunciato
all’incarico affidatogli da
Puccini, fu la volta di un’altra
coppia di librettisti: Luigi
Illica e Giuseppe Giaoosa, che
sarebbero poi divenuti famosi
con i libretti della “Bohème”,
“Tosca” e “Madama Butterfly”,
tentarono di soddisfare i
desideri del compositore che
insisteva per un cambiamento
delle linee fondamentali
dell’assunto drammaturgico,
mentre il testo di quelle
sezioni giaà messe in musica era
da mantenere parola per parola.
Una chiara idea delle esigenze
poste da Puccini ad Illica - cui
si deve gran parte dell’attuale
libretto di “Manon Lescaut” - ci
è offerta dalla seguente lettera
della prirnavera 1891; qui
Puccini faceva proposte perché
l’atto II - il cui profilo
psicologico presentava analogie
con Massenet - ricevesse una
fisionomia autonoma tramite una
modificazione d’ambiente:
Caro Illica,
t’ho spedito libretto Manon.
Ci ho ripensato e sempre più
persisto nell’idea di
incastrarci l’atto 2° nuovo.
Dovrebbe esser un quadro tutto
amore, primavera, gioventù. La
scena in un orto-giardiuo,
tutto pieno di piccoli alberi
in fiore sino quasi alla
ribalta - col suolo di pelouse
verde (erba), con vialetti e
qualche sedile. Scena lunga
perché gli alberi fioriti
dovrebbero perdersi
all’infinito: una visione
dunque di freschezza,
di fioritura eccessiva.
Manon e Des Grieux - felici
amanti - prodigantisi continue
carezze: giocando come due
ragazzi innamorati. Lescaut è
il loro deus ex machina,
etc. etc. Ma il finale è il
difficile. Bisogna
assolutamente evitare
Massenet. Lì ti voglio! Lì ci
occorre la trovala illichiana.
Non rapimento perchè c’è quasi
al 1° atto ... non so proprio
cosa si potrebbe trovare ...
so che ci vuole una trovata,
una fine d’atto efficace,
convincente e sopratutto
originalmente scenica, perché
sarebbe inutile aggiungere un
atto se quest’atto non è di
grande vantaggio e di
efficacia. Per il 4° è facile
il taglio: accetterei anche
qualche cambiamento verso la
fine ... un po’ più di
diagnosi delle anime ... Per
il 2° vecchio, lo sfrondamento
non è difficile, specie al
principio: nel duo
Manon e Lescaut.
Dunque, caro Illica,
pensaci e trova, ma presto,
prima che io possa mettermi al
lavoro grande di opera nuova.
Puccini
Per
distanziarsi dall’impostazione
in senso psicologico dell’opera
di Massenet, l’atto dell’idillio
di Des Grieux e Manon fu infine
soppresso completamente.
Diversamente dall’opera di
Massenet, la “Manon Lescaut” di
Puccini sottolinea la tragicità
di questa storia d’amore, senza
peraltro aver mai mostrato i due
amanti felicemente uniti. Una
forte incongruenza del libretto,
messa in luce da Illica, fu
eliminata solo un anno dopo la
prima di “Manon Lescaut”, ciò
per la resistenza opposta da
Puccini ad ogni modifica di
quelle parti dell’opera che
erano già state composte. Si
trattava della raffigurazione
psicologicamente incoerente di
Lescaut, che nell’atto I
accompagna Manon in convento e
che poi nell’atto II diviene
amico del seduttore della
sorella; tale incongruenza fu
attenuata dall’inserimento di un
duetto tra Lescaut e Geronte
alla fine dell’atto I. Nello
stesso tempo fu soppresso un
finale affidato al coro, che per
il suo carattere si sarebbe più
adattato ad un grand opéra. I
consigli di Lescaut sul modo con
cui Geronte potrà guadagnarsi i
favori di Manon nonostante Des
Grieux l’abbia rapita,
contengono in nuce l’argomento
del secondo atto poi omesso e
preparano l’ascoltatore
all’ambiguità di Manon, quale si
rivela del definitivo atto II.
Discussioni tra compositore e
librettisti si ebbero pure a
proposito dell’episodio della
partenza da Le Havre, per cui
Illica aveva immaginato sulla
una vera e propria nave che
prende il largo, e su cui i
marinai e le cortigiane
deportate intonavano un coro che
si perdeva sempre più in
lontananza. Anche il precedente
appello delle cortigiane, che fu
infine ampliato da Puccini sì da
costituire il finale dell’atto
III, ricevette la sua
configurazione definitiva solo
dopo innumerevoli dispute tra
tutti gli interessati. Le parole
pronunciate dal comandante della
nave quando consente infine a
Des Grieux di seguire Manon
nell’esilio, sono un contributo
dell’editore Giulio Ricordi.
Ulteriori modifiche al libretto
di “Manon Lescaut” furono
compiute qualche decennio dopo
la prima; dopo aver dato il suo
consenso nel 1910 ad alcune
proposte di correzioni fattegli
da Arturo Toscanini che
coinvolgevano la struttura
musicale dell’opera, Puccini nel
1922, quando era cioè intento
alla composizione di “Turandot”,
pregò il librettista Giuseppe
Adami di scrivere un nuovo verso
per l’aria di Manon dell’atto
IV. Proprio per la sua genesi
eterogenea, cui corrisponde
nell’ambito della struttura
musicale una costruzione ‘a
mosaico’, “Manon Lescaut”
consente una visione più ampia
nel ‘laboratorio musicale’
pucciniano, più di quanto non
avvenga per le sue opere
successive, dalla struttura
priva di fratture e più riuscite
sotto il punto di vista della
tecnica compositiva.
Diversamente da quelle opere, in
cui la vicenda si svolge
nell’arco di un solo giorno
(“Tosca”, “Turandot”) o che
almeno rappresentano anche
visivamente tutto ciò che è
essenziale per gli sviluppi
psicologici dei personaggi
(“Madama Butterfly”, “La
fanciulla del West”), all’inizio
della parabola creativa di
Puccini troviamo diversi
libretti, in cui una parte
dell’azione è affidata al
semplice racconto. In “Le Villi”
e “Manon Lescaut” questo schema
librettistico si congiunge con
il proposito del compositore di
elaborare una parte degli
sviluppi nascosti della vicenda
in un “Intermezzo sinfonico”.
Anche nella “Bohème” le varie
scene sono disposte in
successione ‘aperta’, ma mentre
qui tale disposizione ‘aperta’
sembra essere già tracciata
nella struttura del modello
letterario, in “Manon Lescaut”
essa va invece interpretata come
la conseguenza di una tattica
consapevolmente seguita dagli
autori al fine di evitare
un’eccessiva analogia con lo
schema librettistico dell’opera
di Massenet. Al tempo stesso c’è
da tener presente che Puccini
desiderava per gli sviluppi
della vicenda della sua opera
una grande varietà di luoghi.
Mentre la “Manon” di Massenet si
spegne sulla strada che porta a
Le Havre, Puccini e i suoi
librettisti invece, creando la
scena dell’imbarco delle
cortigiane (atto III),
riuscirono senza dubbio a
realizzare un pezzo magistrale,
anche dal punto di vista
musicale. Ma nell’atto IV, che
consiste di fatto in un unico
duetto in cui è intercalata
l’aria del soprano, oltre
all’illogicità drammaturgica, si
vede l'immaginazione scenica del
compositore capitolare davanti
alla convenzione musicale. Mai
il Puccini degli anni maturi
avrebbe potuto concepire un atto
in cui la protagonista, spossata
dalla sete e dalla febbre, muore
in una landa deserta
dell’America (presso New
Orleans!), dopo che il tenore si
è allontanato brevemente per
andare a cercar l’acqua ... e
per dare al soprano la
possibilità di cantar da sola
un’aria.
La questione dell’elemento
integratore ed unificante si
pone però non solamente per il
testo, ma ancor più per la
musica; nessun’altra opera di
Puccini contiene infatti tanto
materiale tematico ripreso da
sue precedenti composizioni.
Così già il motivo iniziale
deriva dai “Tre Minuetti per
quartetto d’archi”, pubblicati
da Puccini nel 1892 e scritti
certamente quali esercizi di
composizione per la resa del
colorito locale dell’opera. Il
medesimo fine, e cioè la
creazione dell’atmosfera
musicale di questa vicenda
ambientata nella seconda metà
del secolo XVIII, ha poi la
citazione dell"‘Agnus Dei” dalla
“Messa di gloria” nel Madrigale
dell’atto II di “Manon Lescaut”.
L’accompagnamento pulsante in
crome regolari, che alla
composizione sacra conferisce il
carattere di un canto
processionale, suggeriscenella
mutata cornice della situazione
scenica piuttosto l’idea di un
accompagnamento con strumenti
pizzicati. I piccoli
abbellimenti nelle voci dei
cantanti sottolineano la
frivolezza del nuovo testo,
mentre le figurazioni dei
ritardi - nei modi dello ‘stile
antico’ - ne sottolineano il
distacco estetico dal più
autentico linguaggio musicale
pucciniano. Il colorito storico
che qui è già così
magistralmente realizzato, è
però ancora giustapposto
all’espressività del canto dei
protagonisti, in cui viene a
riflettersi la vicenda vera e
propria. Solo a partire da
“Madama Butterfly” espressività
vocale dei singoli personaggi e
colorito locale si fonderanno in
maniera totale. Nella partitura
di “Manon Lescaut” l’impiego di
materiale preesistente si può
trovare non solo in quelle parti
dell’opera che stanno ad
illustrare la cornice storica e
locale della vicenda, ma anche
in passi di altissima
espressività, nei veri e propri
‘pezzi forti’ dell’opera. Un
loro esame può favorire una
migliore comprensione della
costruzione melodica di Puccini;
la melodia, per tradizione la
categoria suprema nell’opera
italiana, è nei melodrammi
pucciniani la risultante d’un
principio costruttivo di tipo
quasi tematico e realizzato
sulla base di piccole unità
motiviche, che si connettono
quasi organicamente per dar
luogo a più ampi archi melodici.
 Quest’esempio
musicale riporta l’inizio
dell’aria “È la notte che mi
reca”, che insieme con il
recitativo che la precedeva “Mentìa
l'avviso” aveva costituito la
prova dell'esame finale di
Puccini al Conservatorio
di Milano (1883).
Dall’esempio
musicale n. 2 si può rilevare
come questa prova d'esame si sia
trasformata nell'aria di Dex
Grieux “Donna non vidi
mai”. Poiché il testo
originario (di Felice Romani)
era in ottonari regolari, mentre
il testo cantato da Des Grieux
era composto di endecasillabi e
settenari, le note della melodia
non corrispondono sempre alle
sillabe del testo. La chiara
divisione funzionale tra melodia
cantata e accompagnamento
orchestrale nella prova d’esame
viene abbandonata nella
partitura di “Manon Lescaut” in
favore d’una più variabile
divisione funzionale tra voce e
orchestra: solo l’orchestra
presenta integralmente la
melodia, mentre il canto del
solista ne riprende delle linee
melodiche più brevi, dove i
tempi forti vengono ad avere un
particolare lustro e rilievo per
la coincidenza delle due linee
melodiche. Con questa tecnica
della distribuzione di una
melodia enfaticamente inarcata
tra voce solista e orchestra
Puccini poteva dispiegare in una
grande varietà di gradazioni
l’intensità espressiva del suo
melodismo. I motivi più
importanti di questa partitura
così ricca di temi si
ripresentano secondo il modulo
d’una tecnica leitmotivica di
tipo associativo e dopo la loro
prima comparsa ricoprono la
partitura d’una trama di
reminiscenze d’episodi
trascorsi. Se a volte si può
rilevare come il tessuto di
relazioni motiviche si conformi
più all’impeto della
raffigurazione affettiva che non
ad una disposizione consapevole
del materiale, pur tuttavia gli
episodi centrali dell’opera,
come il gran duetto d’amore
dell’atto II, la scena
dell’imbarco nell’atto III e
gran parte dell’atto IV,
traggono quell’immediatezza
d’effetto emozionale che
esercitano sull’ascoltatore
anche da quella certa noncuranza
con cui il compositore
giustappone materiale eterogeneo
là dove la raffigurazione di
situazioni psichiche anomale
glielo richiedeva. Così la fonte
più importante del materiale
musicale per degli atti III e IV
- il quartetto per archi
“Crisantemi”, composto da
Puccini nel 1890 per la morte
del duca Amedeo di Savoia - non
viene preparato tematicamente
nei primi due atti. Il
capovolgimento di atmosfera così
prodotto ha un effetto tanto più
incisivo in quanto penetrano nel
tessuto orchestrale anche
elementi tipici della scrittura
quartettistica.
Con
tutta la straordinaria maestria
nel trattamento dell’orchestra
che contraddistingue la
partitura di “Manon Lescaut”,
come del resto tutte le altre di
Puccini, pure si possono
ravvisare in quest’opera quegli
svariati influssi da cui ben
presto - a cominciare dalla
“Bohème” - sarebbe nata una
scrittura orchestrale pienamente
e ininterrottamente compiuta.
Quanto agli influssi esercitati
su Puccini dall’ambiente
musicale a lui contemporaneo,
bisogna citare innanzi tutto le
opere di successo composte dai
suoi amici Mascagni e
Leoncavallo. Specialmente
nell"‘Intermezzo” si trovano
reminiscenze della tecnica
compositiva di Mascagni (cfr.
l’Intermezzo di “Cavalleria
rusticana”). Oltre ad un
trattamento dei legni che
ricorda Massenet, o più in
generale il Drame lyrique
dell’epoca, l’orchestrazione
pucciniana tradisce soprattutto
l’influsso delle opere
romantiche wagneriane. Oltre a
costituire sempre un
orientamento per ciò che
riguarda la tecnica
dell’istrumentazione, le
conquiste delle tarde opere
wagneriane hanno nella partitura
di “Manon Lescaut” una vita per
così dire subcutanea. La grande
distanza che separava le
posizioni estetiche dei due
autori impedì che il mondo
sonoro wagneriano - a parte
alcune reminiscenze nell’atto II
- divenisse norma estetica per
il timbro orchestrale
pucciniano. Ad ogni modo, anche
se la versione pucciniana di
“Manon Lescaut” ha rappresentato
a confronto con l’opéra comique
di Massenet una perdita di
leggerezza nell’impostazione
della trama, pure vi è congiunto
un alto grado d’intensificazione
della passione umana. In una
lettera a Marco Praga lo stesso
Puccini espresse tale differenza
in un’immagine: “Lui (Massenet)
la sentirà alla francese, con la
cipria e i minuetti. Io la
sentirò all’italiana, con
passione disperata.”
Jürgen Maehder
(Traduzione:
Gabriele Cervone)
|
|
|