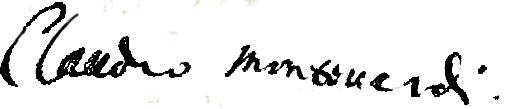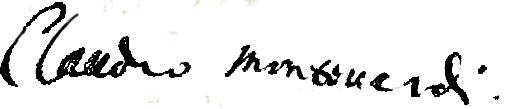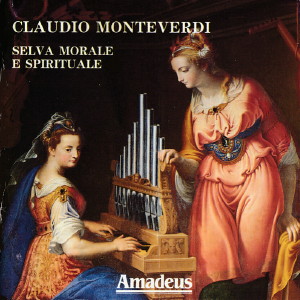 |
|
4 CD's
- AMS 009-12 - (p) 1993
|
|
Claudio MONTEVERDI
(1567-1643)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SELVA
MORALE E SPIRITUALE, Venezia 1640
e 1641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compact disc 1
|
|
|
|
|
| Vespro |
|
|
62' 09" |
CD 1/1-10
|
| -
Dixit Secondo - (a 8 voci
concertato con gli stessi istromenti
del primo et nel medesimo modo) |
n.13 |
7' 36" |
|
|
| -
Confitebor Secondo - (a 3
voci concertato con due Violini) |
n.15 |
5' 48" |
|
|
| -
Beatus Primo - (a 6 voci
concertato con due Violini et 3
Viole da brazzo ovvero 3 Tromboni
quali anco si ponno lasciare) |
n.17 |
7' 34" |
|
|
| -
Laudate pueri Secondo - (a 5
voci) |
n.20 |
7' 11" |
|
|
| -
Laudate Dominum omnes gente -
(a 5 concertato con due Violini et
un coro a quattro voci qual potrassi
e cantare e sonare con quattro Viole
o Tromboni...) |
n.21 |
4' 06" |
|
|
| -
Credidi - (a 8 voci da
Capella) |
n.24 |
4' 10" |
|
|
| -
Ut queant laxis |
n.31 |
3' 08" |
|
|
| - Sanctorum
meritis Secondo -
(concertato a voce sola con due
Violini sopra a la qual aria si
può cantare anco altri Inni dello
stesso metro) |
n.27 |
2' 43"
|
|
|
| -
Magnificat Primo - (a 8 voci
et due Violini et quattro Viole
overo quattro Tromboni quali in
acidente si ponno lasciare) |
n.33 |
13' 07" |
|
|
| - Salve Regina
Primo - (a tre voci Alto
Basso et Tenore o Soprano) |
n.35 |
6' 46" |
|
|
| Compact
disc 2 |
|
|
|
|
Messa a 4
voci da Capella
|
n.6 |
|
16' 31" |
CD 2/1-8 |
| - Kyrie |
|
2'
27" |
|
|
| - Gloria |
|
3' 31" |
|
|
| - Credo |
|
2' 09" |
|
|
| - Crucifixus |
|
1' 16" |
|
|
| - Et in
Spiritum Sanctum |
|
2' 12" |
|
|
| - Sanctus |
|
2' 00" |
|
|
| - Benedictus |
|
1' 28" |
|
|
| - Agnus Dei |
|
1' 28" |
|
|
Altri brani vari
|
|
|
|
|
| Gloria - (a
7 voci concertata con due Violini
et quattro Viole da brazzo overo 4
Tromboni quali anco si ponno
lasciare se occoresse l'acidente) |
n.7 |
|
12' 45" |
CD 2/9 |
| Crucifixus
- (a quattro voci Basso Tenore
Quinto et Alto. Concertato con
Tromboni o Viole da brazzo quali
si ponno anco lasciare...) |
n.8 |
|
2' 46" |
CD 2/10 |
| Et resurrexit
- (a due Soprani o Tenori con due
Violini) |
n.9 |
|
1' 44" |
CD 2/11 |
| Et iterum -
(a 3 voci, Basso et due Contralti) |
n.10 |
|
1' 53" |
CD 2/12 |
| Jubilet -
(a voce sola in Dialogo) |
n.38 |
|
4' 55" |
CD 2/13 |
| Madrigali |
|
|
|
|
| - O ciechi
- (a 5 voci et doi Violini) - (F.
Petrarca) |
n.1 |
|
4' 10" |
CD 2/14 |
| - Voi
ch'ascoltate - (a 5 voci et
doi Violini) - (F. Petrarca) |
n.2 |
|
5' 06" |
CD 2/15 |
| - É questa
vita un lampo - (a 5 voci) -
(A. Grillo) |
n.3 |
|
2' 35" |
CD 2/16 |
| - Spontava il
dì - (Canzonetta morale a 3
voci) - (A. Grillo) |
n.4 |
|
6' 03" |
CD 2/17 |
| - Chi vul che
m'innamori - (a 3 voci et
due Violini) - (A. Grillo) |
n.5 |
|
7' 22" |
CD 2/18 |
Compact disc 3
|
|
|
|
|
| Vespro |
|
|
62' 32" |
CD 3/1-10 |
| -
Dixit Primo - (a 8 voci
concertato con due Violini et
quattro Viole o Tromboni quali se
portasse l'accidente anco si ponno
lasciare) |
n.12 |
10' 52" |
|
|
| -
Confitebor Primo - (a 3 voci
con cinque altre voci ne ripieni) |
n.14 |
7' 14" |
|
|
| -
Beatus Secondo - (a 5 voci
qual si può cantare ridoppiato et
forte o come piacerà) |
n.18 |
5' 16" |
|
|
| -
Laudate pueri Primo - (a 5
voci concertato con due Violini) |
n.19 |
6' 52" |
|
|
| -
Memento - (a 8 voci da
Capella) |
n.25 |
7' 23" |
|
|
| -
Laudate Dominum Terzo - (a 8
voci) |
n.23 |
4' 04" |
|
|
| -
Iste confessor - (Himnus
sopra ad una medesima aria [di
Sanctorum meritis Secondo]) |
n.29 |
2' 37" |
|
|
| -
Deus tuorum militum |
n.32 |
2' 17" |
|
|
| -
Magnificat Secondo - (a 4
voci in genere da Capella) |
n.34 |
7' 40" |
|
|
| - Salve Regina
- (a 2 voci, due Tenori o due
Soprani) |
n.36 |
6' 17" |
|
|
| Compact disc 4 |
|
|
|
|
| Altri brani vari |
|
|
|
|
| - Ab aeterno
- (mottetto a voce sola in basso) |
n.11 |
|
6' 53" |
CD 4/1 |
| -
Confitebor Terzo alla francese
- (a 5 voci quali si può concertare
se piacerà con quattro Viole da
brazzo lasciando la parte del
soprano alla voce sola) |
n.16 |
|
6' 34" |
CD 4/2 |
| -
Laudate Dominum Secondo - (a
8 voci et due Violini) |
n.22 |
|
2' 54" |
CD 4/3 |
| - Sanctorum
meritis Primo - (a voce sola
et due Violini sopra alla qual
aria si potranno cantare anche
altri Hinni peò che siino dello
stesso Metro) |
n.26 |
|
5' 10" |
CD 4/4 |
| - Deus tuorum
militum - (Himnus sopra ad
una medesima aria [di Sanctorum
meritis Secondo]) |
n.28 |
|
2' 14" |
CD 4/5 |
| -
Iste confessor - (voce sola
et et due Violini sopra alla qual
Aria si può cantare parimenti Ut
queant laxis di S. Gio. Batt. et
simili) |
n.30 |
|
3' 17" |
CD 4/6 |
| - Salve Regina
- (con dentro un Ecco voce sola
risposta d'ecco et due Violini) |
n.35 |
|
9' 50" |
CD 4/7 |
| -
Laudate Dominum in sanctis eius
- (voce sola Soprano o Tenore) |
n.39 |
|
4' 54" |
CD 4/8 |
| -
Pianto della Madonna (Jam moriar,
mi fili) - (a voce sola sopra
il Lamento d'Arianna) |
n.40 |
|
10' 57" |
CD 4/9 |
|
|
|
|
|
| Ensemble 'CONCERTO' |
Choro Favorito |
| - Fabio Missaggia, Violino
primo |
Marinella Pennicchi,
Jill Feldman, Soprani |
| - Rosario Di Meglio,
Violino secondo |
James Bowman,
Roberto Balconi, Alti |
| - Massimo Cialfi, Trombone
primo |
Vincenzo Manno,
Emanuele De Checci, Tenori |
| - Ole Kristian
Andersen, Trombone secondo |
Antonio Abete, Marco
Ricagno, Bassi
|
| - Mauro Morini, Trombone
terzo |
|
| - Gerhard Lubenow, Trombone
quarto |
Choro de putti:
Coro di voci bianche del Teatro alla
Scala di Milano / Nicola Conci, direttore |
| - François De
Rudder, Fagotto |
Capella:
Almagesto vocale / Bruno Raffaele
Foti, direttore |
| - Sabina Colonna
Preti, Viola da gamba, Viola
bastarda |
Choro Favorito
Secondo: Gruppo
madrigalistico dell'As.Li.Co. |
| - Claudio Frigerio,
Violoncello |
|
| - Giorgio Sanvito, Violone |
Bruno Raffaele
Foti, Vice Maestro di
Cappella |
- Mara Galassi, Arpa
doppia
|
|
| - Paul Beier, Arciliuto
primo |
Roberto GINI,
Direttore e Maestro di Cappella |
| - Franco Pavan, Arciliuto
secondo |
|
| - Maurizio Martelli,
Chitarrone |
|
| - Giovanni Togni, Organo,
Clavicembalo |
|
| - Roberto Gini, Clavicembalo,
Organo, Viola bastarda |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Chiesa
di San Sigismondo, Cremona
(Italia) - 17-22 & 20/30
maggio 1993 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Produttore |
|
Gaetano
Santangelo |
|
|
Art director /
Grafica
|
|
Carlo
Steiner / Ivana Tortella
|
|
|
Supervisione
artistica
|
|
Roberto
Gini
|
|
|
Riprese audio
|
|
Ernesto
Esposivto
|
|
|
Assistente
musicale
|
|
Jorge
Alberto Guerrero
|
|
|
Assistente in
regia
|
|
Chiara
Esposito
|
|
|
Editing |
|
Gennaro
Carone
|
|
|
Prima Edizione CD |
|
AMADEUS
- AMS 009-10 - (2 CD's - durata
62' 14" & 65' 58") - (p) 1993
- DDD
AMADEUS - AMS 0010-11 - (2 CD's -
durata 60' 37" & 52' 38") -
(p) 1993 - DDD
|
|
|
Note |
|
In
copertina: Bartolomeo Campi -
Santa Cecilia e Caterina |
|
|
|
|
|
GUIDA
ALL'ASCOLTO
L'eterogeneità
degli stili e delle forme, la
varietà dei mezzi e delle scelte
linguistiche, il contrasto dei
generi e delle tecniche
compositive, sono fra le
caratteristiche che più
colpiscono all'ascolto della Selva
morale e spirituale. La
vasta raccolta monteverdiana (40
brani), che comprende musica
scritta per la Cappella di San
Marco ma anche per le funzioni
di altre chiese veneziane,
produce l'impressione di una
certa discontinuità, anzi di un
marcato divario di stili e
generi: vi si trovano riunite,
infatti, musiche composte in un
arco di tempo molto ampio (la Selva
raccoglie una produzione più che
trentennale), per un organico
quantomai vario e dalla
destinazione liturgica
disparata. Alle composizioni a
cappella nello stile polifonico
della tradizione, destinate al
servizio ordinario dal quale gli
strumenti erano di norma
esclusi, si affiancano brani
concertanti dall'apparato vocale
e strumentale più fastoso, che
si avvalgono spesso della
tecnica, tipicamente veneziana,
dei cori battenti; né mancano
brani impostati nel moderno e
teatrale stile monodico. La Selva
morale e spirituale si
configura, dunque, come un vero
e proprio compendio delle
tendenze stilistiche dell’epoca.
La presenza di stili così
eterogenei in ambito sacro si
spiega anche con l’autonomia
della tradizione musicale
veneziana, gelosamente difesa
dal patriarcato della città. A
Venezia, ancora al tempo di
Monteverdi, v’era una certa
tolleranza per ciò che concerne
i testi della liturgia (tra i
salrni d’uso comune era ammessa,
per esempio, l’inserzione di
mottetti su testi latini non
biblici, frutto di parafrasi o
compilazione moderna) ; simile
tolleranza si esercitava anche
in campo musicale: nella musica
sacra, perciò, avevano pieno
diritto di cittadinanza stili
originariamente legati al mondo
teatrale o cameristico.
Accogliendo le innovazioni
stilistiche e le tecniche
compositive della "seconda
pratica", che rompono
decisamente col mondo della
polifonia classica
cinquecentesca, la Selva
morale attua una
convergenza col profano:
Monteverdi assimila
perfettamente al genere sacro i
processi già sperimentati in
campo madrigalistico e teatrale.
Nell’ambito sacro come in quello
profano, il compositore trae
spunto dai suggerinienti
affettivi del testo verbale,
ricercando la loro
manifestazione in musica; tende,
in definitiva, a
un'interpretazione personale del
testo, interpretazione che è
sovente di natura drammatica. La
novità del linguaggio sacro
monteverdiano, allora, non andrà
ricercata tanto nelle
innovazioni armoniche o
contrappuntistiche, quanto
nell'articolazione declamatoria
del discorso musicale,
nell’articolazione originale
della forma (organizzata in
sezioni ben individuate, legate
da rapporti di corrispondenza,
simmetria, alternanza), che
poggia sul testo verbale ed è di
natura eminentemente retorica.
Oltre che per la varietà
stilistica, la Selva
s’impone per la varietà dei
mezzi vocali e strumentali di
cui fa sfoggio. L’esibizione di
un apparato più o meno opulento
è legata alla solennità della
festa, dunque alla disponibilità
di un organico di cantori e
strumentisti più o meno ampio;
in alcuni casi, come avviene per
la Messa a cappella,
sono previsti brani alternativi,
in stile concertante,
sostituibili ai brani ordinari
in occasione di riti solenni.
Varia è anche la destinazione
liturgica dei brani contenuti
nella raccolta. Il materiale può
essere suddiviso in alcuni
nuclei principali: cinque
composizioni su testo
d’argomento genericamente
spirituale, in volgare, poste
all’inizio della Selva
con funzione di proemio; una
messa a quattro voci a cappella,
provvista di brani alternativi;
salmi e inni per la liturgia del
Vespro; composizioni mariane.
Come l’inizio, anche la fine
della raccolta è riservata a un
brano devozionale non liturgico,
il Pianto della Madonna.
La messa, i salmi e gli inni
costituiscono la parte liturgica
della Selva: la
possibilità d’inserimento
dipende, per certi brani, dalla
solennità della festa e
dall’organico disponibile; altri
mottetti sono invece privi di
una precisa destinazione
liturgica, ma in certe occasioni
possono venire ad arricchire la
liturgia ufficiale.
Claudio
Toscani
|
Compact discs 1 &
2
|
|
Compact discs 3 &
4 |
|
Vespro
I brani del prime cd
sono idealmente raccolti a formare
la musica liturgica de1Vespro, la
parte dell’Officio che si celebra
quando il giorno volge al termine.
La liturgia vespertina comprende
un certo numero di salmi (Dixit
Dominus, Confitebor,
Beatus vir, Laudate
pueri) che vengono recitati
tutte le domeniche dell’anno;
altri (Laudate Dominum, Credidi,
Memento) sono destinati a
festività particolari.
Fanno parte della liturgia
vespertina anche alcuni inni, il Magnificat
e il Salve regina. Vario è
lo stile col quale i salmi della Selva
morale vengono posti in
musica: si va dal semplice stile
vocale a cappella, a quello
monodico, a quello concertante,
che vede le voci - spesso
sostenute da strumenti di ripieno
- dividersi in più cori o
dialogare coi violini. I brani
sono presenti, in genere, in più
d’una versione, in modo da
consentire una scelta che tenga
conto della solennità della festa
e dell’organico disponibile.
Dixit Secondo (n.13)
Il brano d’esordio del Vespro,
Dixit secondo, è costituito
da un’ampia successione di episodi
contrastanti per stile, scrittura
e organico, corrispondenti ad
altrettante sezioni del testo
posto in musica (la didascalia
avverte che il brano è "a 8
voci concertato con due violini
et quattro viole o tromboni";
poiché le parti delle viole e dei
tromboni mancano, si presuppone
che tali strumenti raddoppiassero
le voci nel "tutti", come
perlopiù fanno i due violini).
Tranne che in pochi luoghi, il
brano procede tutto per
articolazioni sillabiche, sia
nelle sezioni solistiche che in
quelle corali, così da
configurarsi come un grande
declamato: ne risulta acuito quel
senso di potenza, di perentorietà,
nel quale è facile scorgere il
riflesso della solennità del verbo
divino. La fissità armonica,
l’iterazione delle cadenze che
caratterizzano l’apertura,
rimandano alla ieraticità delle
parole del testo; ma basta
l’accenno a un concetto bellico ("inimicos
tuos") per dividere le voci
in due cori contrapposti, come
eserciti che si fronteggino, e per
scatenare richiami di tromba e
fragore di battaglia, per dar
sfogo, cioè, all'armamentario
sonoro che Monteverdi aveva già
ampiamente sperimentato nei Madrigali
guerrieri. É musica
altamente drammatica, che
predilige lo stile vocale
"parlante", la sillabazione sulle
note ribattute; musica nella quale
l'immaginazione è costantemente
mobilitata dai suggerimenti
testuali: così alle parole "confregit
in die irae suae reges"
compare il tema dell’antica
sequenza del Dies irae; un
accenno guerresco ("conquassabit")
scatena di nuovo i segnali di
battaglia; e le parole di tripudio
("exaltabit") sono il
pretesto per lunghi passi
melismatici, nei quali rivive la
tradizione gregoriana dello jubilus
alleluiatico.
Confitebor Secondo (n.15)
Una diversa organizzazione formale
mostra il Confitebor a tre
voci concertate con due violini,
che ha costruzione strofica.
Ciascuna delle cinque sezioni
mantiene inalterato il basso;
sopra di esso cantano le voci sole
o a tre, coi violini che
intevengono in eco o con vere e
proprie parti concertanti. Il
salmo è poi chiuso dal "tutti"
del Gloria Patri, che
procede con un maestoso andamento
accordale.
Beatus Primo (n.17)
Un principio spiccatamente
concertante ispira il Beatus
primo a sei voci con due
violini. Il brano è fondato sul
ritorno periodico di due elementi
ricorrenti: il motto iniziale (Beatus
vir, ripetuto cinque volte
nel corso dei primi quattro
versetti, poi di nuovo subito
prima e subito dopo il nono; e un
ritornello strumentale eseguito
dai due violini, che Monteverdi
riprende pari pari dalla
canzonetta Chiome d'oro
nel Settimo Libro de'
Madrigali. I due elementi,
ricorrenti a mo' di refrain,
danno unità all’intera
composizione, evitando
l'impressione d’un affastellamento
di episodi separati; ma un forte
senso di unità scaturisce anche
dalla tecnica dell'iterazione del
basso seguente (che proviene
anch'esso dalla canzonetta Chiome
d'oro).
Laudate pueri secondo
(n.20)
Il Laudate pueri secondo a
cinque voci è invece strettamente
imparentato alla tecnica
polifonica antica. Tutta la prima
parte del brano, costituita da una
suceessione di episodi imitativi -
ciascuno su un soggetto proprio -
che si incastrano l'uno
nell'altro, è informata allo stile
della più classica polifonia
vocale cinquecentesca. Né mancano
immagini sonore imitative, come lo
sprofondare delle voci nel
registro grave alle parole "et
humilia respicit", o la
progressione ascendente sulle
parole "in caelo". Più
oltre, comunque, il brano apre
brevemente allo stile monodico,
affidando una melodia riccamente
fiorita ai tenori sulle parole di
giubilo "laetatum".
Caratteristica è anche la tecnica
di riprendere nella sezione
conclusiva ("Sicut erat"),
su nuove parole, i vecchi soggetti
già ascoltati nella prima parte
del brano.
Laudate Dominum omnes gentes
(n.21)
Nuovamente ispirato al più puro
Spirito concertante è il Laudate
Dominum a cinque voci, con
un coro a quattro voci e due
violini, che vive del contrasto
tra sezioni di leggera tessitura,
dove le cinque voci soliste - sole
o a coppie - concertano coi
violini, e sezioni più sonoramente
massicce, dove il coro procede in
omoritmia. Assai pregnante è il
tema associato alle parole "misericordia
ejus", che si insinua nella
parte centrale del brano: si
tratta d’una discesa cromatica
dalle forti implicazioni
patetiche, ispirata a un "affetto"
che contrasta vivamente con
l’atmosfera generale del salmo.
Credidi (n.24)
Il Credidi a otto voci è
un’ampia pagina policorale,
scritta per due cori spezzati,
secondo la caratteristica prassi
delle feste solenni celebrate
nella basilica marciana
(l'organizzazione delle voci e
degli strumenti in due cori
distinti poggia sulla possibilità
di disporre, in San Marco, di due
organi e due cantorie che si
fronteggiano). Lo stile polifonico
è vetusto, e rimanda al linguaggio
tardo-rinascimentale; antica è
anche la tecnica che fonda la
composizione su una melodia
gregoriana, presente sia
nell’intonazione in cantus
planus ("Credidi propter
quad locutus sum"), sia
nella sezione polifonica, dove
essa è posta a fondamento della
melodia dei soprani.
Ut queant laxis (n.31) - Sanctorum
meritis secondo (n.27)
Nella liturgia vespertina si
inseriscono, a questo punto, due
inni: Ut queant laxis, che
fa parte del Vespro per la festa
di San Giovanni, e Sanctorum
meritis, che è parte dei
Vespri per più martiri. Poiché il
testo verbale degli inni ha un
assetto metrico ben definito
(equiparabile agli schemi
accentuativi moderni), la loro
struttura è strofica, con un’unica
melodia che si ripete per ogni
strofa. Non solo: la sillabazione
pressoché totale delle parole
facilita l'intercambiabilità dei
testi, così che ogni inno può
essere adattato per nuove
festività, mediante la semplice
sostituzione del testo con un
altro dello stesso metro. É lo
stesso Monteverdi a fornire una
doppia o una tripla versione degli
inni: in un caso al testo
dell’inno Ut queant laxis
sostituisce quello di Iste
confessor, in un altro al
testo di Sanctorum meritis
sostituisce Deus tuorum
militum e, di nuovo, Iste
confessor. Comune è la
struttura formale: le strofe,
intonate a volte col concorso di
violini concertanti, sono
introdotte e separate da
ritornelli strumentali.
Magnificat primo (n.33)
Il Magnificat a otto voci,
che nella Selva morale
inaugura la serie di testi della
liturgia mariana, è uno splendido
esernpio del più moderno stile
concertante, che vive del
contrasto chiaroscurale di sezioni
nelle quali si alternano organici
sempre diversi. Ampio e
articolato, il brano sfoggia
grande dovizia di mezzi (ai due
cori vocali se ne aggiunge un
terzo strumentale), e indulge a un
fulgore sonoro nel quale si
riconosce la peculiare tradizione
musicale della Serenissima. Più
che per strutture polifoniche
orizzontali, il brano procede per
contrapposizione di masse sonore.
All'episodio iniziale, che sfrutta
la tecnica dei cori spezzati,
succede un episodio a due soprani
concertati con due violini,
fondato su un basso ostinato; di
nuovo un "tutti"
policorale, poi prende il via un
episodio imitativo dominato da un
caratteristico soggetto cha
ascende cromaticamente, sulle
parole "et misericordia ejus".
Ancora una volta, al cromatismo è
demandata l`espressione di un
frammento testuale affettivamente
significativo. Il "tutti"
successivo porta con sé un
contrasto vivissimo: le parole del
teato ("Fecit potentiam")
danno il via a una serie
concitatissima di segnali di
tromba, che richiamano il suono
della battaglia. Questa sezione
"marziale" torna, some un refrain,
a separare gli episodi successivi,
solistici, nel quali primai due
soprani con lunghi melismi ("dispersit"),
poi i due bassi, infine i due
tenori, intonano i seguenti
versetti del salmo. Il brano si
avvia alla conclusione con un
ampio episodio imitativo, fondato
su due distinti soggetti (uno dei
quali, sulle parole "misericordiae
suae", e caratterizzato da
ritardi e tensioni armoniche), cui
succedono un ultimo episodio
solistico a due tenori e la
sfarzosa polifonia dell’episodio
finale.
Salve Regina Primo (n.35)
Il Vespro si conclude, infine, col
Salve Regina a tre voci, un
brano che era già apparso nel
1629, nella Quarta raccolta
de’ sacri canti compilata da
Lorenzo Calvi. Di stile moderno,
vibrante e fortemente patetico, il
brano è tutto proteso a
raccogliere le sollecitazioni del
testo: valgano per tutti gli
esempi della discesa cromatica,
rotta da penosi "sospiri", sulle
parole "suspiramus gementes et
flentes", o della lunga
ascesa per gradi cromatici,
anch'essa densa di significato
gestuale, su "o dulcis Virgo".
····················
Messa
a quattro voci da cappella (n.6)
Il secondo
CD è aperto dalla serie dei brani
che costituiscono l'ordinarium
di una messa a quattro voci a
cappella, e da alcuni brani
alternativi, con diverso organico,
da impiegarsi all’eventualità in
occasioni particolari. Le cinque
parti dell’ordinarium (le
parti della messa che presentano
sempre lo stesso testo,
indipendentemente dal giorno in
cui la funzione è celebrata,
opposte al proprium de tempore,
cioè l’insieme delle parti il cui
testo varia secondo le festività
dell’anno liturgico) sono
impostate nello stile polifonico
tradizionale, a quattro voci con
basso seguente (che raddoppia la
voce più grave); le loro
dimensioni, non molto ampie, e
l’assenza di strumenti
concertanti, rivelano che la messa
è destinata alle festività
ordinarie. Monteverdi vi adotta la
tecnica del tema circolare: uno
spunto melodico attraversa,
immutato o variamente trasformato,
tutte le parti della messa,
dandole unità e coerenza.
Kyrie
Il tema circolare è presentato
subito all’attacco del Kyrie
eleison, la prima parte
dell'ordinarium, tripartita
(la tripartizione musicale è
implicita nel testo) e realizzata
- come vuole la tradizione - in
polifonia imitativa. Anche il Christe
eleison e il secondo Kyrie
presentano temi che saranno
ripresi, più tardi, nel corso
delle altre parti della messa.
Gloria
Il Gloria è la seconda parte dell'ordinarium;
il testo, alquanto lungo, e
suddiviso in più sezioni
caratterizzate ciascuna da
un’ampia chiusura cadenzale. L’incipit
testuale, che veniva di norma
intonato dal celebrante, è
realizzato in cantus planus;
la scrittura polifonica inizia
dunque a partire dall’Et in
terra. Quasi tutte le
sezioni imitative si basano sul
tema circolare della messa,
assunto per moto retto o per moto
contrario.
Credo
Anche il Credo è
formalmente organizzato sul
principio del Gloria; qui
il testo, ancora più ampio, è
all’origine di una spiccata
varietà d'atteggiamento. Dopo
l'intonazione in cantus planus,
inizia la parte polifonica con una
successione d’episodi imitati,
ciascuno dei quali si fonda sul
tema circolare della messa,
variato a volte in modo sottile.
Il flusso continuo della polifonia
imitativa è interrotto dall’Et
incarnatus, un momento
meditativo realizzato in
prevalente omoritmia e in valori
ritmici piu larghi.
Crucifixus - Et
in Spiritum Sanctum
Il successivo Crucifixus
asseconda la tensione emotiva del
testo verbale rarefacendo il
suono, mentre l’Et resurrexit
esprime il tripudio della
resurrezione con un gioioso
andamento accordale in ritmo
ternario. L’episodio seguente (Et
iterum) è uno sfoggio di
bravura contrappuntistica:
Monteverdi pone al basso, a
reggere l’edificio polifonico, un
cantus firmus (in valori
lunghi) che consiste nel tema
circolare per moto contrario,
mentre al di sopra le altre voci
si imitano vicendevolmente
enunciando il tema per moto retto.
Le parti conclusive del Credo,
nelle quali le imitazioni si fanno
sempre più strette e la scrittura
polifonica risplende in tutta la
sua magnificenza, aggiungono alla
messa un ulteriore elemento di
ciclicità: vengono infatti ripresi
il soggetto del Christe
eleison e quello dell’ultimo
Kyrie.
Sanctus - Benedictus
- Agnus Dei
Il Sanctus, interamente
scritto in polifonia imitativa,
assume anch’esso il tema ciclico
della messa; il Benedictus
riprende invece il soggetto di una
sezione (Qui tollis) del Gloria,
prima di concludere con la
tradizionale ripetizione dell’Hosanna.
Nell’Agnus Dei, infne,
l’ultima parte dell'ordinarium
missae, le imitazioni
canoniche si fanno ancor più
rigorose. Un primo episodio è
fondato su un soggetto che è una
libera parafrasi del tema
circolare, mentre un secondo
ripropone il tema nella sua
integrità; la parte conclusiva
riprende il soggetto del Christe
eleison.
Brani
alternativi
Inizia ora una serie
di brani, in stile concertante,
che Monteverdi inserì nella Selva
morale con l’intento di
fornire pezzi alternativi a brani
o sezioni dell'ordinarium
missae. In tutti questi
brani, destinati a festività
solenni, quando nelle chiese
veneziane l'organico normalmente
disponibile veniva accresciuto,
l'apparato sonoro è sfarzoso, e la
scrittura richiede prestazioni più
alte ai solisti.
Gloria (n.7)
Il primo di questi brani è un Gloria
a sette voci, nel quale la
pluralità delle tecniche impiegate
è funzione dell’interpretazione
del testo e delle situazioni
affettive da esso suggerite.
Impressionante lo splendore sonoro
dell’episodio d’esordio; la
vocalità melismatica e altamente
virtuosistica dei solisti è
punteggiata da interiezioni
corali, accordali, che fanno da
ritornello. Totalmente diverso il
tono dell’episodio successivo: una
coralità possente, che procede con
andamento grave, per valori
larghi, esplorando gli estremi
registri gravi. La scrittura
concertante del Laudamus te,
dove alle coppie dei soprani e dei
tenori rispondono in eco i
violini, comporta un
alleggerimento del peso sonoro;
intervengono poi di nuovo le
figurazioni virtuosistiche
dell’episodio iniziale, anche
questa volta scandite da
interventi corali. Per tre volte
risuonano ora le invocazioni dei
due soprani (Domine Deus),
cui risponde il ritmo martellante
di due blocchi corali
contrapposti. I versetti seguenti,
che invocano la misericordia
divina, sono organizzati in tre
strofe, introdotte e separate da
ritornelli strumentali: tocca
prima ai due soprani e al basso,
poi ai due tenori, infine ai due
bassi. Un nuovo episodio
concertante è chiuso da una breve
sezione omoritmica, che dà lo
slancio per l’episodio concertante
finale, nel quale sono di nuovo
riprese la scrittura e le figure
dell’esordio.
Crucifixus (n.8) - Et
resurrexit (n.9) - Et
iterum (n.10)
Gli altri brani alternativi per la
messa a cappella della Selva
morale sostituiscono alcuni
versetti del Credo. Il
primo di essi è un Crucifixus
a quattro voci (alternativo,
dunque, alla sezione del Credo),
un brano asciutto, dalla severità
ascetica, impostato su un soggetto
cromatico discendente che rende in
modo quanto mai efficace l’idea
della sofferenza. Il secondo, Et
resurrexit a due voci con
due violini concertanti, è invece
informato a un’espressione
oltremodo gioiosa (vi si notino le
linee melodiche ascendenti su "et
ascendit", la massima
espansione al registro acuto
coincidente con "in coelum",
il saldo gesto melodico
discendente su "sedet". Il
terzo brano, infine, Et iterum
a tre voci, concede largo spazio a
ricchi e suggestivi melismi.
Jubilet (n.38)
Nella Selva morale trovano
spazio alcuni mottetti privi d’una
precisa destinazione liturgica:
fra di essi v’è Jubilet,
canto di giubilo per una voce di
soprano in dialogo con un secondo
soprano. La configurazione
dialogica è in larga misura
implicita già nel testo, che può
essere letto come una serie di
domande e risposte; Monteverdi
traduce l’affetto dominante per
mezzo di un gioioso ritmo ternario
di danza, che sostiene il brano
quasi per intero, in un’accorta
alternanza di passi melismatici e
passi in stile recitativo.
Madrigali
Un gruppo di cinque
madrigali spirituali, su testo
genericamente morale ma non
liturgico, è posto da Monteverdi
in apertura della Selva morale,
con la funzione di un proemio.
Sono composizioni nello stile
moderno più avanzato, che
prediligono la declamazione
rapida, la sillabazione su note
ripetute caratteristica dello
stile madrigalistico profano,
piuttosto che il classico
andamento polifonico in valori
distesi.
O ciechi (n.1)
La prima di esse, O ciechi
a cinque voci e due violini, trae
il testo da una serie di terzine
del Trionfo della morte
del Petrarca. Costituisce l’avvio
della raccolta monteverdiana, ed
ha infatti l'andamento di un
grande recitativo corale, nel
quale il testo è declamato con
accordi ribattuti. Il madrigale
procede poi, con una tecnica
tipica dello stile profano per
brevissime sezioni omoritmiche o
imitative, solistiche o
collettive, creando un suggestivo
effetto di frammentazione
caleidoscopica.
Non mancano momenti ispirati a
quella concitazione guerresca che
costituisce una delle più note
peculiarità stilistiche del tardo
Monteverdi.
Voi ch'ascoltate (n.2)
Il secondo madrigale, Voi
ch'ascoltate a cinque voci e
due violini, mette in musica
l’avvio del Canzoniere
petrarchesco. La ripartizione
formale è chiara, poiché è dettata
dal testo poetico (un sonetto):
nell’intonazione della prima
quartina tre voci,
coi violini in eco, si muovono con
rapide fioriture, imitando i
"sospiri" suggeriti dal testo
poetico; subentra poi una sezione
omoritmica, con un inserto
solistico in stile "parlante"; le
due terzine conclusive, infine,
sono poste in musica
rispettivamente con un episodio
imitativo di tutte le cinque voci
e con un nuovo "tutti"
omoritmico, in tempo ternario.
È questa vita un lampo
(n.3)
Nel madiigale È questa vita un
lampo, su testo di Angelo
Grillo, l’alternanza della
scrittura (accordale o imitativa)
e dei pesi sonori è ancora più
rapida: avviene all'interno del
singolo verso, quando non
addirittura tra parola e parola.
Questa tecnica è perfettamente
funzionale al concetto espresso
dal testo poetico, che tratta la
fugacità delle cose terrene.
Spontava il dì (n.4)
Spontava il dì, "canzonetta
morale" a tre voci, presenta il
testo poetico e musicale diviso in
cinque parti, chiuse ciascuna da
un refrain comune. Le
prime quattro stanze sono
realizzate in polifonia con
andamento sillabico, con
imitazioni elementari, con una
condotta melodica quanto mai
semplice: seguono, insomma, i
dettami dello stile "popolaresco".
La quinta stanza, invece, è
realizzata monodicamente: è
infatti un patetico "lamento" del
basso solo, che - indugiando in
cromatismi caratteristici -
declama in uno stile prettamente
teatrale.
Chi vol che m'innamori
(n.5)
Chi col che m'innamori,
infine, "canzon morale" a tre voci
e due violini, si struttura in tre
strofe, introdotte e separate da
un ritornello strumentale; un
ritornello più ampio è previsto
per la conclusione. La scrittura è
semplice, prevalentemente
accordale, e si giova del
contrasto tra spiccati ritmi di
danza ("hoggi si ride") e
rotture patetiche del verso e
della linea melodica ("e poi
diman si piange").
Cludio
Toscani
|
|
Vespro
Come il primo,
anche il terzo CD della Selva
morale e spirituale
dispone i brani in modo da
ricostituire idealmente la
musica per la liturgia del
Vespro, la parte dell’Officio
celebrata verso il termine della
giornata. Ai salmi che fanno
parte stabilmente della liturgia
vespertina (Dixit Dominus,
Confitebor, Beatus
vir, Laudate pueri)
vengono intercalati inni e salmi
destinati a festività
particolari (Memento, Laudate
Dominum, Iste
confessor, Deus tuorum
militum); la successione è
chiusa dal cantico del Magnificat
e dal Salve Regina.
Dixit Primo (n.12)
L'imponente salmo d’apertura, Dixit
Dominus a otto voci,
presenta una serie di sezioni
varie e contrastanti, alternate
secondo un piano che avvicenda i
pieni e i vuoti sonori, la
scrittura imitativa e
l’omoritmia, i toni concitati e
un andamento melodico fluido e
disteso; sezioni che, pur nel
contrasto, sono legate fra di
loro da un motivo ricorrente,
una discesa melodica di quarta.
Monteverdi intona tutta la prima
parte del salmo osservando il
principio retorico
dell’amplificatio: ad ogni
sezione ne fa seguito un’altra,
costruita essenzialmente sullo
stesso materiale musicale ma
amplificata nel peso sonoro,
nelle dimensioni e nella
complessità di scrittura. Così
il primo versetto (Dixit
Dominus), intonato con una
prima frase sillabata su
un’unica corda e con una seconda
frase melodica del soprano solo,
e subito replicato: la prima
frase è amplificata dalla
sillabazione corale delle otto
voci su un accordo fermo, la
seconda dal trattamento
polifonico cui è sottoposta la
frase melodica prima intonata
dal soprano. Anche il secondo
versetto (Sede a dextris meis)
è posto in musica secondo lo
stesso principio: intonato
dapprima dal soprano solo, è
replicato coralmente, all’inizio
con un maestoso andamento
omoritmico, poi con un elaborato
intreccio imitativo.
Quest’ultimo si svolge su incisi
melodici sincopati, così che ne
nasce una polifonia
frastagliata, ritmicamente
rotta, che restituisce alla
perfezione l'immagine guerresca
suggerita dal testo (inimicos
tuos). Il terzo versetto (Virgam
virtutis) è costruito
anch’esso in base allo stesso
principio retorico: il materiale
melodico affidato dapprima ai
due tenori è amplificato poi dal
trattamento corale, che alterna
scrittura accordale e imitativa,
in un gioco chiaroscurale quanto
mai calibrato. Anche qui
suggestioni testuali di natura
bellica (in medio inimicorum)
scatenano una concitazione nella
quale s’odono il rincorrersi dei
segnali militari e il cozzare
delle armi. I suggerimenti
testuali, d’altra parte,
determinano il trattamento
musicale di più d’una sezione:
basterà osservare gli accordi
martellanti coi quali vengono
scolpite le parole che
testimoniano la potenza divina (confregit
in die irae suae reges), o
l'andamento melismatico, memore
dello jubilus alleluiatico,
sulla parola exaltabit.
Confitebor Primo (n.14)
Il secondo salmo della liturgia
vespertina, il Confitebor,
è costruito sul principio
concertante dell'alternanza
soli/tutti. Le sezioni
solistiche, in stile polifonico
imitato, sono affidate a tre
voci (contralto, tenore e basso)
sostenute dal basso continuo;
nelle sezioni del ‘tutti’,
in omoritmia, le tre voci
vengono raddoppiate, e ad esse
si aggiungono due soprani, così
da dare origine a una scrittura
a cinque parti reali. Il ‘tutti’
funziona come un vero e proprio
ritornello di concerto: infatti
è costituito sempre dalla stessa
successione accordale, variata
unicamente nella sua componente
ritmica.
Beatus Secondo (n.18)
Anche il Beatus vir a
cinque voci è informato al
principio del concerto barocco:
v’è infatti la ripresa periodica
d’un ritornello (Beatus vir)
che fa regolarmente ritorno -
identico nel testo e nella
musica - dopo ogni coppia di
versetti, l’ultima volta con
andamento accordale e in
aumentazione. Ritornello ed
episodi non sono però separati
da nette cesure, tendono anzi
alla compenetrazione reciproca:
il flusso della polifonia,
perciò, non si arresta che verso
la fine del salmo, per dar luogo
ai più enfatici episodi
conclusivi. Il testo verbale
fornisce talvolta lo spunto per
procedimenti musicali imitativi:
sulle parole "confirmatum"
e "non commovebiur" il
concetto della saldezza è
espresso dalla fissità ritmica e
melodica dei soprani e dei
bassi, che procedono per note
lunghe a mo' di tenor; alla
parola "fremet" l’ordito
polifonico è vivacizzato dalle
figure in ritmo puntato estese a
tutte le parti.
Laudate pueri Primo
(n.19)
Un principio formale diverso
segue invece il Laudate
pueri a cinque voci
concertate con due violini. La
prima parte del salmo consta di
tre grandi strofe, ciascuna
delle quali è divisa in una
prima sezione (sempre sullo
stesso testo, Laudate pueri)
intonata da due tenori, e in una
seconda in tempo ternario,
caratterizzata da uno spirito
più marcatamente concertante. Il
testo di questa seconda sezione
varia di strofa in strofa, ma è
intonato sfruttando il medesimo
materiale musicale, con le parti
disposte ogni volta
diversamente. Terminate le tre
strofe, e con esse la prima
parte del salmo, interviene una
sezione nella quale tutte le
voci, per la prima volta,
procedono omoritmicamente (Suscitans).
Con questo segno di forte
articolazione formale ha inizio
la seconda parte del salmo, che
comprende un episodio a due
soprani e basso con due violini
concertati, un duetto riccamente
fiorito dei tenori e un episodio
concertante conclusivo.
Memento (n.25)
Il Memento a otto voci,
destinato ai Vespri di festività
particolari, è un ampio brano
policorale, nel quale le voci si
dividono in due cori
contrapposti, secondo la tipica
prassi veneziana della basilica
di S. Marco. La scrittura è
prevalentemente accordale, lo
stile declamatorio e possente,
teso a valorizzare i blocchi
sonori, il gioco delle masse che
assottigliano e rafforzano di
continuo il loro peso fonico.
Laudate Dominum Terzo
(n.23)
Nel Laudate Dominum a
otto voci il gusto per il colore
è ancor più spiccato: il brano
si alimenta da cima a fondo del
contrasto tra "soli" e "tutti",
tra sonorità contenute e ripieni
energici e sontuosi. Un lungo e
vario duetto dei soprani (Laudate
Dominum) è interrotto con
regolarità da una serie di
interiezioni corali, che
scandiscono la parola Quoniam;
poi (Confirmata est) si
avvicendano i due soprani e le
rimanenti sei voci, finché un
‘tutti’ omoritmico (Laudate
Dominum) riprende testo e
musica della parte iniziale;
infine un episodio a due cori
contrapposti (Quoniam
confirmata est) contrasta
vivamente col Gloria Patri
conclusivo, nel quale si fa
ritorno all’esile sonorità dei
due soprani soli.
Iste confessor (n.29) - Deus
tuorum militum (n.32)
I due inni inseriti a questo
punto fra le musiche per la
liturgia vespertina, Iste
confessor e Deus
tuorum militum, hanno in
comune la struttura strofica;
ogni strofa del testo poetico
viene intonata dalle voci,
concertate con due violini, ed è
chiusa da un ritornello
strumentale. Il primo inno è
ottenuto, per semplice
sostituzione del testo verbale,
dall’inno Sanctorum meritis:
come abbiamo già ricordato, in
questo genere di composizioni
l'intercambiabilità dei testi è
consentita dallo schema metrico
ben definito, così che
Monteverdi può fornire più
versioni dello stesso inno - per
adattarlo a festività differenti
- cambiandone semplicemente le
parole. Il secondo inno,
impostato in uno spigliato ritmo
ternario, è a tre voci e si
serve di una scrittura più
spiccatamente concertante.
Magnificat Secondo (n.34)
Col cantico del Magnificat,
"a quattro voci in genere da
capella", Monteverdi ci
riporta nel mondo della
polifonia classica
cinquecentesca. Il brano
comprende la realizzazione
polifonica dei soli versetti
dispari: la mancanza dei
versetti pari (Et exultavit,
Quia fecit, Fecit
potentiam, Esurieutes,
Sicut locutus) è
probabilmente da attribuire alla
prassi dell’alternatim,
secondo la quale ai versetti
intonati in polifonia ne
venivano intercalati altri in cantus
planus. La scrittura
contrappuntistica, sorvegliata e
armoniosa, ricorre a tecniche
compositive arcaizzanti: tutto
il brano, infatti è basato sulla
parafrasi della melodia
gregoriana del Magnificat,
sfruttata anche a più riprese
come tenor.
Salve Regina (n.36)
Le musiche per la liturgia
vespertina giungono al termine
con l'intonazione del Salve
Regina a due voci. Una
prima sezione del testo è
realizzata nella forma di un
canone all’unisono dei due
tenori; una seconda (Ad te
clamamus) si apre ad
immagini sonore imitative,
rompendo la melodia con una
sequenza di pause sulle parole
patetiche "ad te suspiramus".
Altri spunti naturalistici
emergono nella sezione
conclusiva, dove alle pause
‘sospiranti’ si aggiunge la
penetrante ascesa cromatica
dell'invocazione "o dulcis
Virgo".
····················
Altri
brani vari
Ab aeterno
(n.11)
Il mottetto Ab aeterno
ordinata sum a voce sola,
che apre il quarto CD, trae il
testo dai Proverbia ed è
destinato al proprium di
qualche festività non precisata.
Impostato nello stile moderno
della monodia accompagnata, ha
carattere di eccezionalità per
le alte doti vocali richieste.
Il testo è particolarmente ricco
di spunti imitativi: è perciò
naturale che la monodia mostri
una netta propensione
all’illustrazione sonora della
singola parola e del singolo
concetto. Parole quali ‘abyssi’,
‘gravi mole’, ‘fundamenta
terrae’ si
associano ad uno spostamento
nell’estremo registro grave,
mentre altre quali ‘montes’
o ‘praeparabat caelos’
vedono la melodia salire
all’acuto; la mobilità degli
elementi, in corrispondenza di
parole quali ‘flumina’,
‘mari’,
‘aquarum’, è resa con
floridi passaggi e ampie tirate.
Il canto procede per grandi
sbalzi, la linea vocale è molto
frazionata.
Confitebor Terzo alla
francese (n.16)
Il Confitebor ‘alla fmncese’
a cinque voci riprende il
materiale musicale da due
composizioni monteverdiane
precedenti, Chi vuol haver
felice e Dolcissimo
usignolo, che fanno parte
dei Madrigali amorosi
dell’Ottavo Libro. La
didascalia posta da Monteverdi
all’inizio del brano dà la
possibilità di sostituire le
parti vocali con quattro viole
da braccio, lasciando alla voce
sola la parte del soprano: su
questa prassi si fonda la
dicitura "alla francese".
In base al principio
dell'alternanza soli/tutti, il
primo versetto è enunciato dal
soprano e subito ripetuto dalle
cinque voci; seguono una serie
di episodi che alternano il ‘tutti’
a sezioni solistiche (con
momenti di particolare
concitazione ‘guerresca’
alle parole ‘et terribile
nomen ejus’, finché col Gloria
Patri il soprano sfoggia
una monodia oltremodo fiorita;
il salmo giunge poi al termine
con la ripresa integrale della
prima sezione, su nuovo testo
verbale (Sicut erat), ed
una cadenza conclusiva.
Laudate Dominum Secondo
(n.22)
Il salmo seguente, Laudate
Dominum a otto voci e due
violini concertati, è
caratterizzato da uno schema
circolare nel quale si alternano
un refrain (il Laudate
Dominum iniziale, intonato
dai due soprani che si imitano a
breve distanza) ed episodi
variamente costruiti: ora tocca
ai tenori coi violini concertati
(Quoniam confirmata est),
ora alle otto voci con andamento
omoritmico o suddivise in due
cori contrapposti.
Sanctorum meritis Primo
(n.26) - Deus tuorum militum
(n.28) - Iste confessor
(n.30)
L’inno Sanctorum meritis,
appartenente alla liturgia dei
Vespri per le feste di più
martiri, è costituito, come i
suoi omologhi, da una serie di
strofe - musicalmente identiche
- intonate a voce sola, separate
da ritornelli strumentali e
chiuse da un Amen
finale. I due inni seguenti, Deus
tuorum militum e Iste
Confessor, forniscono una
nuova versione di inni già
incontrati: infatti si limitano
a sostituire il testo verbale,
rispettivamente, degli inni Sanctorum
meritis Secondo e Ut
queant laxis.
Salve Regina (n.35)
Una forte teatralità
contraddistingue il Salve
Regina, il cui testo
verbale è frutto
dell'interpolazione di un altro
testo, Audi coelum, fra
le parole consuete del Salve
Regina. L’elemento
teatrale è già implicito nel
testo interpolato, che contiene
effetti d’eco, puntualmente
sfruttati dalla musica di
Monteverdi; ma l’aderenza della
musica al testo va ben oltre: è
la provenienza delle parole,
infatti, a suggerire
l'articolazione formale del
brano. Le sezioni col testo
nuovo, cantate da un tenore con
un secondo tenore in eco, sono
realizzate nel più moderno stile
della monodia accompagnata;
mentre le sezioni col testo
originale del Salve Regina,
stilisticamente differenti,
vengono intonate dal tenore coi
due violini concertati.
Laudate Dominum (n.39)
Il salmo Laudate Dominum
a voce sola riprende il
materiale musicale di due
precedenti composizioni
monteverdiane apparse negli Scherzi
musicali del 1632, Zefiro
torna e Armato il cor
(quest’ultimo è inserito anche
fra i Madrigali guerrieri
dell’Ottavo Libro). Il
brano, dall'andamento sciolto e
gioioso, fa propri i numerosi
suggerimenti testuali indulgendo
all'imitazione degli strumenti
musicali sulle parole ‘in
sono tubae’,
‘in psalterio et cithara’,
‘in tympano et choro’, ‘in
cymbalis benesonantibus’:
di volta in volta si avvertono
dunque squilli di tromba, note
lungamente ripercosse, tremoli,
passaggi melismatici. Nella
parte finale le parole ‘laudet’
e ‘alleluja’
sono accompagnate da un lungo
vocalizzo, uno jubilus
altamente virtuosistico.
Pianto della Madonna
(n.40)
A chiusura della Selva
morale e spirituale
Monteverdi pone il Pianto
della Madonna,
travestimento spirituale di quel
Lamento d'Arianna che a
suo tempo aveva commosso
l’uditorio fino alle lacrime.
Universalmente riconosciuta come
la miglior pagina di musica
teatrale dell’epoca, il Lamento
d'Arianna era in assoluto
la composizione monteverdiana
più nota. È perciò comprensibile
il desiderio di riutilizzare il
brano e di porlo a suggello
della vasta raccolta della Selva
morale, ricorrendo
all’antica pratica della
contrafactio: così le parole
originali vennero sostituite da
un testo latino - del quale è
ignoto l’autore - che si adatta
perfettamente al ritmo del
vecchio testo in volgare. I due
testi traducono,
concettualmente, la stessa sfera
affettiva: sono il lamento per
la perdita della persona amata;
nel Pianto della Madonna
a Teseo si sostituisce Cristo,
ad Arianna, Maria ai piedi della
croce. La musica, del tutto
priva di efflorescenze vocali,
segue fedelmente il ritmo
declamatorio del testo: segna il
trionfo dell’eloquenza di tipo
teatrale e raggiunge un livello
d’intensità espressiva
straordinario.
|
|
|
|
|