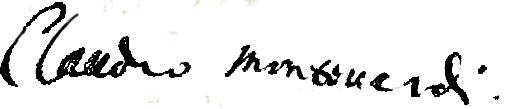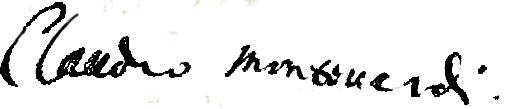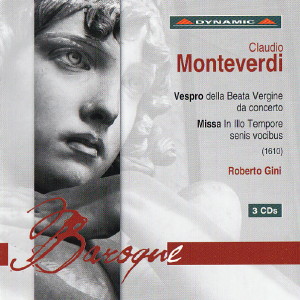 |
|
3 CD's -
CDS 656 - (c) 2010
|
|
Claudio MONTEVERDI
(1567-1643)
|
|
|
|
|
|
|
| Compact
disc 1 |
|
|
VESPRO
DELLA BEATA VERGINE DA CONCERTO
composto sopra canti fermi
(1610)
|
|
|
-
Deus in adiutorium (cantus planus)
- Domine ad adiuvandum me
festina sex vocibus & sex
instrumentis *
|
Coro
DSG |
2' 17"
|
|
| -
Assumpta est (intonatio tantum,
solus cantor) - Dixit Dominus
a 6 voci & 6 Instrumenti - Assumpta
est Maria (cantus planus) |
AG,
LB, RP, MC, VDD, SV |
10'
44" |
|
- Nigra
sum, Motetto ad una voce ***
|
MS |
4' 19" |
|
| -
Maria virgo (intonatio tantum, solus
cantor) - Laudate pueri a
8 voci sole nel Organo - Maria virgo
assumpta est (cantus planus) |
LB,
CC, MS, SL - AG, AC, MC, SV |
8'
12" |
|
- Pulchra
es, a due voci ***
|
LB,
AG |
4' 51" |
|
| -
Exaltata est (intonatio tantum,
solus cantor) - Laetatus sum,
a sei voci - Exaltata est Sancta (cantus
planus) |
LB,
AG, RP, MS, VDD, SV |
9' 43" |
|
| - Duo
Seraphim, a due & a tre voci |
MS, VDD;
MC |
5' 50" |
|
| -
Post partum (intonatio tantum, solus
cantor) - Nisi Dominus, a
dieci voci - Post partum Virgo inviolata
(cantus planus) |
Coro DSG |
5' 42" |
|
| - Audi
coelum, prima ad una voce sola,
poi nella fine a sei voci |
AG,
LB, AC, VDD (solo), MC (eco), SV |
9' 44" |
|
| -
Paradisi (intonatio tantum, solus
cantor) - Lauda Ierusalem
a Sette voci - Paradisi porte (cantus
planus) |
Coro
DSG |
5' 49" |
|
| Compact
disc 2 |
|
|
| - Sonata
sopra Santa Maria Ora pro nobis |
AG,
LB, CC, AC (A. Kukuchi, D.
Beltraminelli) |
8' 10" |
|
| - Capitulum
In omnibus requiem quaesivi |
- |
0' 28" |
|
| - Hinno
Ave maris stella, a 8 (con
ritornelli) |
CC,
RP, VDD, SL - AC, MS, MC, SV |
10' 16" |
|
| -
Paradisi portae per te hodie apertae
sunt |
- |
0' 28" |
|
| Magnificat
I a Sette voci & sei
instrumenti: |
CC,
AC, MS, VDD, MC, SL, SV |
|
|
| - Anima
mea. Soprano solo |
- |
0' 51" |
|
| - Et
exultavit; va sonato tardo perché li
doi Tenori cantano di semicrome |
- |
1' 28" |
|
| - Quia
respexit, ad una voce sola & sei
instrumenti li quali si soneranno con
più forza che si può |
- |
2' 23" |
|
| - Quia
fecit, si suona adaggio perché le
parti cantano & sonano di Croma
& Semicroma |
- |
1' 15" |
|
| - Et
misericordia, a 6 voci sole in Dialogo |
- |
2' 12" |
|
| - Fecit
potentiam, ad una voce & tre
instrumenti |
- |
1' 15" |
|
| - Deposuit,
(due Cornetti e due violini in Echo) |
- |
2' 27" |
|
| - Esurientes,
a due voci & quattro Istromenti |
- |
1' 52" |
|
| - Suscepit
Israel a tre voci, si suona adaggio
perché li duoi soprani cantano in Echo |
- |
1' 40" |
|
| - Sicut
locutus ad una voce & sei
instrumenti in dialogo |
- |
1' 12" |
|
| - Gloria
Patri, a tre voci due de le quali
cantano in Echo |
- |
2' 37" |
|
| - Sicut
erat, tutti li instrumenti & voci,
& va cantato & sonato forte. |
- |
1' 50" |
|
| - Oratio
Famulorum tuorum - Benedicamus Domino;
Deo gratias (cantus planus) |
- |
1' 48" |
|
| Magnificat
II a 6 voci */**: |
CC,
AC, RP, MS, MC, SL, SV |
|
|
| - Anima
mea a due voci |
- |
1' 08" |
|
| - Et
exultavit a 3 voci |
- |
1' 16" |
|
| - Quia
respexit a una voce sola |
- |
1' 38" |
|
| - Quia
fecit, a 6, in Dialogo |
- |
1' 52" |
|
| - Et
misericordia, a 3 voci, & si suona
adaggio perché li Soprani cantano di
Croma |
- |
1' 24" |
|
| - Fecit
potentiam, a 3 voci |
- |
1' 01" |
|
| - Deposuit,
a 3 voci, & cantano doi Soprani in
Echo |
- |
2' 31" |
|
| -
Esurientes, a due voci |
- |
1' 42" |
|
| - Suscepit,
a due voci |
- |
1' 28" |
|
| - Sicut
locutus est, a 5 voci in dialogo |
- |
1' 24" |
|
| - Gloria
Patri, a 6 voci |
- |
1' 58" |
|
| - Sicut
erat, a 6 voci |
- |
1' 27" |
|
|
|
|
|
** Organ tablatures:
Roberto Gini
|
|
| ENSEMBLE
CONCERTO |
| - Lavinia
Bertotti, Antonella Gianese,
Sopranos |
| - Christophe
Carré, Alessandro Carmignani,
Falsettos |
| - Raimundo
Pereira, Alto & Tenor |
| - Makoto
Sakurada, Vincenzo Di Donato,
Mario Cecchetti, Tenors |
| - Salvo
Vitale, Sergio Ladu, Basses |
| -
Claudia Combs, Stéphanie Erös,
Daniela Beltraminelli, Massimo
Percivaldi, Viole da braccio |
| -
Marco Angilella, Basso da braccio,
Violone & Viola da gamba |
| -
Perikli Pite, Basso da braccio &
Viola da gamba |
| -
Patxi Montero*, Contrabasso da gamba |
| -
Dario Lo Cicero, Piero Cartosio, Recorders
and Fifare |
| -
Cecilia Knudtsen, Marco Angilella**, Violone |
| -
Maurizio Martelli, Chitarrone |
| -
Elena Spotti, Double harp |
| -
Mario Martinoli, Giovanni Togni, Sara
Dieci*, Roberto Gini***, Organs |
|
| ENSEMBLE
LA PIFARESCHA |
| Cornetti: |
William Dongois,
Frithjof Smith, Josuè Melendez |
| Trombones: |
Ermes Giussani, Mauro
Morini, Bernard Fourtet |
|
CONCERTO
PALATINO
|
| Cornetti: |
Bruce Dickey, Gwain
Glenton |
| Trombones: |
Charles Toet, Henning
Wiegräbe, Simen van Mechelen, Bernhard
Rainer |
|
| CORO
D.S.G. / Michele Vannelli, Chorus
Master |
| Sopranos: |
Elena Bernardi,
Valentina Betti, Chiara Molinari, Miriam
Montero, Lucia Napoli, Sara Pretto,
Francesca Santi, Sonia Tedla, Martina
Zaccarin |
| Altos: |
Jacopo Facchini,
Francesco Giusti, Milena Pericoli,
Germana Schiassi, Bianca Simone |
| Tenors: |
Alberto Allegrezza,
Nicola Bonazzi, Gregorio Carraro,
Michele Concato, Sergio Martella, Matteo
Mezzaro, Michele Morassut, Nicolò
Pasello, Giacomo Schiavo, Daniel
Schostok, Michele Vannelli |
| Basses: |
Guglielmo Buonsanti,
Gianni Grimandi, Francesco Lora,
Riccardo Parmeggiani, Paolo Ramacciotti,
Alberto Salarelli, Michelangelo Stanzani
Maserati, Alessandro Tabarroni, Luca
Terzi |
|
GRUPPO
VOCALE LAURENCE FEININGER / Roberto
Gianotti, conductor and soloist
|
Fabio
Bonatti, Salvatore De Salvo Fattor, Ervino
Gonzo, Marco Gozzi, Walter Marchi, Franco
Pocher, Roberto Gianotti
|
|
| Roberto
GINI, Conductor |

| Compact
disc 3 |
|
|
| SANCTISSIMAE
VIRGINIS MISSA SENIS
VOCIBUS AD ECCLESIARUM
CHORUS fatta sopra il
motetto "In Illo Tempore"
del Gomberti
(1610) |
|
|
| - Introito
Gaudeamus omnes (cantus
planus)
|
|
4' 52"
|
|
| - Kyrie |
|
4' 32"
|
|
| - Gloria |
|
6' 08"
|
|
| - Graduale
Propter veritatem |
|
3' 24"
|
|
| - Alleluia
Veni ad me Barbara (cantus
planus) |
|
2' 09"
|
|
| - Sequenza
Mater alma perge trino (cantus
planus) |
|
5' 08" |
|
| - Credo |
|
3' 45" |
|
| - Et
incarnatus |
|
0' 58"
|
|
| - Crucifixus
(quatuor vocibus) |
|
2' 58"
|
|
| - Et
iterum |
|
4' 13" |
|
| - Offertorium
Gloriosam mortem (cantus
planus) |
|
1' 51" |
|
| - Sanctus |
|
2' 50" |
|
| - Benedictus |
|
1' 56" |
|
| - Agnus
Dei (sex vocibus -
cantus planus - septem
vocibus) |
|
6' 08" |
|
| - Ite missa
est Barbarino (cantus
planus) |
|
0' 59" |
|
|
|
|
|
Sources:
Sanctissimae Virgini
Missa Senis Vocibus, ac
Vesperae pluribus
decantandae, cum nonnulis
Sacris Concentibus
[...], Venezia, Ricciardo
Amadino, 1610
Mantova, Archivio Storico
Diocesano, Fondo Santa
Barbara, Codice XI, Antiphonale
(29 giugno-26 agosto), cc.
82v - 84v.
Mantova,
Archivio Storico Diocesano,
Fondo Santa Barbara, Codice
IV, Proprium sanctorum.
Festum Sanctae Barbarae
virginis et martyris ad
Missam, cc. I-VIII. |
|
|
|
CORO
D.S.G. / Michele Vannelli, Chorus
Master - (* soli in Crucifixus)
|
| Cantus:
|
Chiara Molinari,
Arianna Rinaldi, Francesca Santi* |
| Sextus:
|
Valentina
Betti*, Valeria Casali, Germana
Schiassi |
| Altus:
|
Francesco Giusti,
Huub Va Der Linden* |
| Tenors: |
Michele Concato,
Yasuharu Fukushima, Simone
Scanzaroli |
| Quintus:
|
Nicola
Bonazzi, Renato Dolcini,
Michele Vannelli* |
| Bassus: |
Guglielmo
Buonsanti, Marco Spongano,
Riccardo Parmeggiani |
|
| GRUPPO
VOCALE LAURENCE FEININGER / Roberto
Gianotti, conductor and soloist |
| Fabio
Bonatti, Salvatore De Salvo Fattor, Ervino
Gonzo, Marco Gozzi, Walter Marchi, Franco
Pocher, Roberto Gianotti |
|
| Sara
Dieci, Organ |
|
| Roberto
GINI, Conductor |
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Chiesa di San Giuliano, Catania
(Italia) - agosto 2006
Chiesa di Santa Barbara, Mantova (Italia) -
ottobre 2007
Chiesa di San Giovanni in Monte, Bologna
(Italia) - ottobre 2009 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Produced by |
|
DYNAMIC S.r.l., Genova, Italy |
|
|
Artistic
supervision |
|
Danilo Prefumo |
|
|
Computer
Graphics
|
|
Stefano Ferrajoli |
|
|
Sound engineer
|
|
Silvano Landonio |
|
|
Editing
|
|
Roberto Gini |
|
|
Mastering |
|
Rino Trasi |
|
|
Prima Edizione
CD |
|
DYNAMIC - CDS 656 - (3 CD's -
durata 67' 11" - 61' 33" & 52' 52) - (c)
2010 - DDD |
|
|
Cover photo
|
|
© Stefano Ferrajoli, 2010 |
|
|
Note |
|
Dedicato all'amica Valentina
Cortese. |
|
|
|
|
Durante
l'estate del 1610, mentre era al servizio dei
Gonzaga, Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 -
Venezia, 1643) diede alle stampe quella che
sarebbe divenuta una delle più celebri
raccolte di musica liturgica e sacra di tutti
i tempi: Sanctissimae Virgini Missa senis
vocibus ad ecclesiarum Choros ac Vespere
pluribus decantandae cum nonnullis sacris
concentibus ad sacella sive Principum
cubicula accomodata (Venezia, Amadino),
comunemente nota come Messa e vespri della
Beata Vergine. Dedicata a papa Paolo V,
essa fu progettata verosimilmente per
obiettivi professionali e personali.
Giunto a Mantova (1560 ca.) come suonatore di
viola, dal 1602 Monteverdi ricopriva
l'impegnativo ruolo di "maestro della musica
del duca" e come tale doveva provvedere sia
alle musiche profane, quotidiane e
straordinarie (da camera, da teatri, feste,
balli), sia a quelle sacre e liturgiche per le
cappelle di Corte o, occasionalmente, anche
per altre chiese cittadine. Il palazzo ducale
comprendeva al proprio interno una piccola
chiesa gotica (S. Croce), varie cappelle per
uso privato e la grande basilica palatina di
S. Barbara che, in quanto collegiata, godeva
di una gestione a sé e di un maestro di
cappella proprio (Besutti, 2007). In passato
solo Giaches Wert (1535-l596) aveva ricoperto
contemporaneamente i ruoli di maestro di corte
e di maestro di S. Barbara. La distinzione fra
le due cappelle ha ingenerato in passato il
persistente equivoco, ora corretto (Bowers,
2007), che la composizione di musiche
liturgiche e sacre di corte fosse esclusa
dalle mansioni di Monteverdi: un`errata
valutazione discendente dalla non accurata
analisi dei dati storici, ma soprattutto dal
mancato confronto con il suo diretto
predecessore, il cremonese Benedetto
Pallavicino (1551-1601).
Date queste premesse, e date le frequenti
lagnanze del maestro circa la gravosità del
proprio impiego, pare verosimile che con la
stampa e la dedica di questo libro, Monteverdi
mirasse a ottenere un ruolo meno impegnativo,
come quello della sola direzione della
cappella di S. Barbara, rimasta vacante per la
morte di Giovanni Giacomo Gastoldi
(1555-1609). Con la dedica papale egli cercava
inoltre di favorire l’ammissione gratuita del
figlio primogenito Francesco al seminario
romano. Nonostante il viaggio a Roma, compiuto
in gran segreto per perorare le proprie cause,
gli obiettivi non furono raggiunti. L'incarico
in S. Barbara, fu affidato transitoriamente
all'oscuro Antonio Taroni e poi a Stefano
Nascimbeni. Francesco sarà avviato dal padre
agli studi di giurisprudenza. Il quadro
biografico così ricomposto chiarisce l'impegno
di Monteverdi anche in campo sacro e
giustifica l'esistenza, altrimenti
inspiegabile, di una produzione tanto vasta ed
eccelsa alla data del 1610.
Si rafforza dunque l’opinione che la raccolta,
pur essendo organizzata in una sequenza
liturgica mariana solo in parte deviata
dallintromissione di parti non liturgiche, non
raffiguri una sola grande celebrazione, ma
raduni antologicamente brani composti durante
il ventennio mantovano. Le musiche composte
per le funzioni ordinarie non sono
distinguibili, ma in alcuni casi è possibile
identificare la destinazione dei brani: come
l'inno Ave maris stella, composto sul
canto piano riformato per la basilica di S.
Barbara e quindi probabilmente a essa
destinato (Besutti, 1998); o come il mottetto
trinitario Duo Seraphim, forse
composto nel 1605 per celebrare la
collocazione della pala della Trinità
di Pietro Paolo Rubens nella chiesa della Ss.
Trinità (Kurtzman, 2007).
Questa registrazione integrale della Messa
e vespri della Beata Vergine è stata
progettata alla luce delle conoscenze più
recenti. Fra le innumerevoli suggestioni che
questa straordinaria antologia di musica
sacra, ‘da capella’ e `da concerto`, potrebbe
ispirare, ne sono state privilegiate due:
anzitutto il contesto liturgico e devoto per
il quale sicuramente queste musiche furono
composte, in secondo luogo il legame
dell'opera Con Mantova e con la sua corte.
Alla base di questa registrazione c'è una
celebrazione liturgica di vespri mariani per
la Festa dell`Assunzione (15 agosto 2006) e
una messa solenne dedicata a S. Barbara, in
questo caso non celebrata, ma eseguita in
cornice liturgica (7 ottobre 2007). In
entrambi i casi le composizioni di Monteverdi
hanno dialogato con passi liturgici in canto
piano: antifone (vespri), brani del Proprio
(messa). In entrambi i casi queste parti sono
state tratte dal repertorio monodico che il
duca Guglielmo Gonzaga (1538-1587) fece
appositamente modificare per la collegiata di
Corte di S. Barbara (Mantova, Archivio
Diocesano). Onde fugare possibili
fraintendimenti, con ciò non si è voluto
asserire che tutti i brani contenuti nella Messa
e vespri della Beata Vergine siano stati
composti per questa chiesa. Restando infatti
ben ferma la consapevolezza della illimitata
possibilità di ricontestualizzazione liturgica
dei brani contenuti nelle sillogi sacre
monteverdiane (C. Monteverdi, Vesperae de
Confessore, Dynamic CDS 543, 2006), si è
voluto porre l'accento sul contesto storico e
liturgico nel quale Monteverdi si muoveva nel
1610.
Non era possibile consegnare alla
registrazione discografica tutto quanto è
stato realizzato dal vivo. La gestualità,
l’avvicendarsi di pieni e di vuoti, di suoni e
di silenzi, che sono il codice del rito nella
sua dimensione spirituale, non si adattano
alla logica discografica. I principali passi
in canto piano sono stati tuttavia conservati.
Questi, oltre a richiamare la cornice nella
quale le composizioni monteverdiane si
inserivano, danno la possibilità di ascoltare
alcune rare monodie liturgiche di ambito
'barbarino'. Rispetto alla tradizione romana,
esse lurono "purgate da barbarismi et mali
suoni" (Giovanni Pierluigi da Palestrina,
lettera a Guglielmo Gonzaga) secondo la
sensibilità musicale cinquecentesca (1564-1585
ca.) e in alcuni casi composte ex novo,
come la sequenza Mater alma perge trino
e gli altri brani del Proprio della messa per
la festa di S. Barbara (4 dicembre). Nel caso
dei vespri, rispetto all’attuale tradizione
liturgica per la festa dell'Assunzione, si
segnala la differenza delle antifone terza (Exaltata
est in luogo di In odorem),
quarta (Post partum in luogo di Benedicta
filia) e quinta (Paradisi portae
in luogo di Pulchra es). A ciò si
aggiunga che, riguardo ai Vespri
monteverdiani, l'attenzione al canto piano è
più che mai appropriata: tutti i cinque salmi
sono scritti sulle intonazioni gregoriane:
l’inno propone in bella evidenza la melodia
liturgica ‘barbarina' nella parte del Cantus;
e la Sonata sopra Sancta Maria ricalca
il tono litanico. Lesecuzione dei brani in
canto piano da parte del Gruppo vocale
Laurence Feininger tiene conto delle più
aggiornate ricerche sulla prassi esecutiva di
questi repertori in epoca tarda (Il canto
fratto).
L'organizzazione dei CD è frutto dunque di un
compromesso alto fra il rispetto dei tempi
dell'ascolto discografico e quanto è stato
realmente celebrato. Come il titolo
monteverdiano dichiara, la silloge è bipartita
e contiene una messa corale a sei voci "da
Capella" ovvero in stile polifonico ‘antico',
e vespri concertanti, modernamente giocati sul
dialogo fra voci sole, strumenti e diversi
spessori sonori. Dalla realtà liturgica, che
prevede la celebrazione dei vespri prima della
messa, discende la decisione di sovvertire
nella presentazione discografica l’ordine
della raccolta monteverdiana, riservando
l’esordio ai vespri. I mottetti 'da concerto'
composti su testi non liturgici (CD 1, nn. 3,
5, 7, 9), che nella celebrazione erano stati
raggruppati alla fine del vespro a mo' di
epilogo devozionale, qui invece sono stati
alternati ai salmi, rispettando con ciò
l`ordine dell’edizione del 1610. La seconda
versione monteverdiana del Magnificat
(a 6 voci), presentata dopo la benedizione
vespertina (CD 2, nn. 19-30), completa infine
la registrazione realmente integrale della
raccolta.
Paola
Besutti
····················
I Tempi
Già dalla fine del ‘400 la pulsazione
metronomica (Tactus) si stabilisce su un
battito del polso che non ha avuto nella
fisiologia umana variazioni di rilievo. E’ su
questa pulsazione che viene organizzato il
sistema delle mensure e delle
proporzioni (prolazioni) i cui segni
vanno intesi - per l'epoca di Monteverdi -
come valori di scansione precisi, impiegati
dagli autori in correlazione all'affetto,
all'espressione e alla solennità proprie del
brano.
A partire approssimativamente da metà ‘600 le
indicazioni di tempo si codificano sempre più
nei nomi delle danze o si identificano nelle
più flessibili diciture di Allegro Andante
Adagio ecc.; sono meno soggette ai soli
segni di prolazione e lasciano all'interprete
una certa elasticità nella scelta del Tempo.
Se nel repertorio più comunemente conosciuto è
quindi facile avvedersi di un`incongruenza
qualora un Andante venisse eseguito
come un Presto o un Allegro
come un Adagio, nella musica
dell’epoca di Monteverdi ciò è meno evidente,
poiché sia il pubblico sia gli stessi
interpreti sono tutt’ora influenzati da
esecuzioni che, a causa di nostra ingenuità,
di convenienza o di errori di trascrizione,
sono, per prassi generalizzata, diventata
ormai tradizione, irriguardose delle
proporzioni indicate. Il risultato, pur
distante dall’idea del compositore, appare
spesso all'ascoltatore di oggi ugualmente
plausibile e accattivante magari
nell'evocazione frequente di suggestioni
popolaresche o etniche, più vicine al nostro
gusto moderno che all'autentico significato
della composizione. Ciò si nota maggiormente
nei tempi ternari ma si riscontra talvolta
anche nei ritmi binari, dove accade che si
aggiungano cambi di tempi non indicati
dall’autore, alterando il testo originale.
L'andamento del Tempo della musica del XVI e
XVII secolo può apparirci oggi come troppo
lento perché contrasta fortemente col generico
senso di frenesia tipico della nostra epoca,
che ci seduce a riconoscere in ogni tempo
ternario un brillante ritmo di danza.
Questa premessa è necessaria nella
presentazione di questa registrazione poiché
il Vespro della Beata Vergine, ancorché
appartenente al repertorio antico, è un'opera
molto eseguita: l'attenersi alle proporzioni
indicate da Monteverdi presenta molte
sorprese. Queste differenze potrebbero
apparire come una personale rilettura o
suscitare la stessa perplessità che si prova
quando i restauri di molti capolavori
pittorici del passato, rimosse le
incrostazioni che alteravano i colori
originali, svelano talvolta un'opera d'arte
affatto diversa da quella che, basandosi su
un'estetica sfalsata e distante da ciò che
l'artista voleva esprimere, è stata fino a
quel momento interpretata e spiegata. Si
aggiunga l'annosa questione delle chiavette
acute che, se non risolta
dall'interprete, porta a esecuzioni fuori tono
di gran parte del repertorio antico, cioè in
una diversa tonalità: tutto il brano viene
eseguito una quarta o una quinta sopra il tono
previsto dall'autore, i soprani cantano in
coloratura, i tenori diventano contralti e i
bassi tenori, La Messa In illo tempore,
il Lauda Jerusalem e i due Magnificat
vogliono infatti essere trasportati una quarta
sotto rispetto al tono indicato in partitura,
secondo una pratica ben codificata da tutti i
trattati dell'epoca.
Gli Ornamenti
La musica contenuta nei trattati di
ornamentazione rappresenta il loro vero
patrimonio. Ornamenti fantasiosi, disegni
melodici, vere e proprie composizioni create
per ornare i frammenti melodici standard,
i soggetti riconoscibili nei brani che
eseguiamo e riscontrabili, identici, in quei
trattati; come avviene nei testi di
architettura, dove i fregi e le decorazioni
sono modelli destinati a decorare, ad esempio,
le porte e le finestre degli edifici: soggetti,
queste, che senza ornamenti sono semplici e
funzionali varchi aperti nelle pareti.
Le porte e le finestre nella musica sono le
frasi a note lunghe che da sole non ambiscono
a esprimere il sentimento delle parole ma
attendono, per acquistare significato, che
l’interprete apponga loro i necessari
ornamenti: ad esempio Audi, ascolta; Coelum,
il cielo contemplato da chi canta; Verba
mea, le mie parole, il mio canto.
Le ornamentazioni presenti nei mottetti di
questa raccolta sono opera di musicisti a
Monteverdi contemporanei (Richardo e Francesco
Rognoni, Bovicelli, Barbarino, Brunelli),
musica scritta per ornare soggetti identici a
quelli che si trovano nel Vespro.
Roberto
Gini
|
|
|