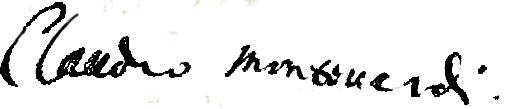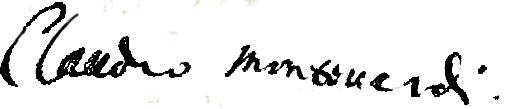|
|
1 CD -
TC 561304 - (p) 1991
|
|
Claudio MONTEVERDI
(1567-1643)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Varie
Musiche Sacre a una e due voci del
Signor CLAUDIO MONTEVERDE
(1567-1643) |
|
|
|
|
|
|
|
-
Intonazione del Settimo Tono
*
|
|
0'
31"
|
|
| -
Ecce sacrum paratum convivium
- (à Tenore solo, cantato dal Sig:
Vincenzo Manno) |
(Leonardo
Simonetti) Ghirlanda Sacra...,
Venetia 1625 |
5' 42" |
|
| -
Salve, o Regina - (à Tenore
solo, cantato dal Sig: Emanuele De
Checchi) |
(Lorenzo Calvi)
Seconda raccolta de' sacri
canti..., Venetia 1624 |
5' 31" |
|
-
Intonazione del Nono Tono *
|
|
0' 38" |
|
| -
Ergo dormio, et cor meum vigilat
- (à due voci, Canto e Basso) |
(Francesco
Sammaruco) Sacri Affetti...,
Roma 1625 |
3' 19" |
|
| -
O quam pulchra es, amica mea
- (à Tenore solo, cantato dal Sig:
Vincenzo Manno) |
(Leonardo
Simonetti) Ghirlanda Sacra...,
Venetia 1625 |
5' 42" |
|
| -
Ego flos campi - (Alto solo) |
(Lorenzo
Calvi) Seconda
raccolta de' sacri
canti..., Venetia 1624
|
3' 54" |
|
| -
Intonazione del Primo Tono ** |
|
|
|
| -
Laudate Dominum omnes gentes
- (à Basso solo) |
(Gaspare
Casati) Raccolta di
Mottetti..., Venetia
1651 |
3' 02" |
|
| -
Salve, Regina - (à Tenore
solo, cantato dal Sig: Vincenzo
Manno) |
(Leonardo
Simonetti) Ghirlanda Sacra...,
Venetia 1625 |
5' 40" |
|
| -
Intonazione del Settimo Tono
** |
|
1' 21" |
|
| -
Currite populi, psallite tympanis
- (à Tenore solo, cantato dal Sig:
Emanuele De Checchi) |
(Leonardo
Simonetti) Ghirlanda Sacra...,
Venetia 1625 |
3' 41" |
|
| -
Venite, videte - (à Canto
solo) |
Motetti a voce
sola de diversi eccellentissimi
autori, Venetia 1645 |
7' 01" |
|
| -
Intonazione dell'Ottavo Tono
* |
|
0' 31" |
|
| -
Exulta, filia Sion - (à voce
sola, cantato dal Sig: Emanuele De
Checchi) |
(Lorenzo Calvi)
Quarta raccolta dè sacri
canti..., Venetia 1629 |
6' 16" |
|
| -
Intonazione del Secondo Tono
* |
|
1' 25" |
|
| -
Cantate Domino canticum novum
- (à due Canti o Tenori) |
(Gio. Battista
Bonometti) Parnassus musicus
ferdinandeus, Venetia 1615 |
5' 48" |
|
|
|
|
|
| Le
Intonazioni d'organo sono tratte da:
Intonazioni d'organo di Andrea
(**) Gabrieli et di Giovanni (*)
suo Nepote. Venetia, Stampa del
Gardano, 1593 |
|
|
|
|
|
|
|
| Cristina MIATELLO,
Soprano |
| Caterina CALVI,
Alto |
| Vincenzo MANNI,
Emanuele DE CECCHI, Tenori |
| Giovanni FAVERIO,
Basso |
|
| Ensemble 'CONCERTO' |
| - Mara Galassi, Arpa
doppia |
| - Maurizio Martelli,
Tiziano Bagnati, Tiorba |
| - Marco Fodella, Arciliuto |
| - Massimo Cialfi, Trombone
basso |
| - Sabina Colonna
Preti, Viola da gamba,
Violoncello |
| - Roberto Gini, Organo |
|
| Roberto GINI,
Direzione
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Basilica
di S. Michele, Pavia (Italia) -
8/12 febbraio 1990 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Direttore
artistico |
|
Sigrid
Lee |
|
|
Grafica
|
|
Gloria
Moretti |
|
|
Presa del suono
|
|
Roberto
Meo |
|
|
Tecnica
|
|
Sound
Events, Castel S. Pietro, Bologna
· DAT Technics SV 360, microfoni
Neumann KM 84 (2), Schoeps CMC 541
(2) |
|
|
Prima Edizione CD |
|
TACTUS
- TC 56031101 - (1 CD - durata 56'
42") - (p) 1987 - DDD |
|
|
Note |
|
In
copertina: Caravaggio "S. Giovanni
Battista" Roma, Pinacoteca
Capitolina. |
|
|
|
|
La
meticolosa cura con cui Claudio
Monteverdi vagliava la
pubblicazione a stampa delle sue
musiche fu, probabilmente, la
causa primaria del fatto che, di
mezzo secolo di attività
compositiva, relativamente
scarse siano le opere
sopravvissute ai nostri giorni.
Ma la fama (sia pur talora
discussa) conseguita dal
musicista bastò a preservare
dall'oblìo un certo numero di
pagine, capitate in maniera
talvolta clandestina fra le
provvide mani di contemporanei
antologisti; i quali
assicuravano maggior prestigio
alle loro raccolte inserendovi
musiche inedite dei principali
compositori dell'epoca (ed è, in
effetti, grazie alla presenza di
pagine monteverdiane che le
pubblicazioni di Bonometti,
Calvi, Simonetti etc. sono ancor
oggi ricordate).
Data la singolare circostanza
che ha consentito la
preservazione di questi brani, è
difficile risalire alla loro
data (a parte il terminus
ante quem per quelli
pubblicati in vita dall'autore)
e destinazione; essi presentano
tuttavia, proprio per il loro
aspetto frammentario ed isolato,
e per la possibilità di un
confronto con l'analoga
produzione di colleghi di
Monteverdi, un'esauriente
panoramica sulla musica sacra
nella prima metà del XVII
secolo.
Gli undici brani inclusi in
questa registrazione,
caratterizzati dalla
ristrettezza dell'organico (una
o due voci a basso continuo),
mostrano tre atteggiamenti
diversi nei confronti del sacro:
la solennità dell'Inno, il tono
festoso dell'Antifona, l'intima
espressione del Mottetto (i
termini qui usati non vanno
intesi con rigore musicologico e
liturgico; servono piuttosto a
determinare il particolare
ambito stilistico in cui si
muove l'ispirazione del
compositore).
L'accento declamatorio è comune
ai tre Inni qui registrati: in Cantate
Domino a due tenori, il
ritmo ternario usato come refrain
si alterna a momenti in cui il
trattamento delle voci si frange
in virtuosistiche imitazioni,
secondo una prassi che, sia nel
Madrigale che nella musica
sacra, destinava a tale
combinazione vocale un
caratteristico trattamento
allusivo ad una sorta di
alternanza solo-tutti.
In Ecce sacrum paratum
le lunghe note ferme iniziali
del solista risuonano con
l'impeto entusiastico di un
trionfale annuncio. In Laudate
Dominum, infine, la
scrittura è improntata ad un
solenne dialogare tra la voce di
basso ed il continuo (nella
letteratura da chiesa
generalmente realizzato dal
trombone, in questo caso, in
particolare, trattato come una
seconda voce concertante).
In tipo dell'Antifonaè presente
con altri tre brani,
caratteristici per
un'ispirazione melodica più
delicata e a tratti quasi
popolaresca: in Currite
populi per tenore
l'irruenza dell'incipit
ternario si stempera in un Alleluia
di tono quasi da "canzonetta".
La voluta omissione, nella
partitura, del nome del santo da
festeggiare (prassi ricorrente
che permetteva di adattare il
brano ad ogni occasione) è stata
qui integrata con Johannes, in
considerazione del fatto che il
Battista è, tra i santi, quello
di più ricorrente uso liturgico
(giugno, settembre, inizio della
quaresima, riti battesimali). Exulta
filia, antifona natalizia,
esordisce con un ritmo marziale,
quasi uno squillo di tromba, che
si ripete come ritornello, anche
in questo caso con un'intenzione
allusiva dell'alternanza solo-tutti.
Venite et videte per
soprano, infine, è tutta giocata
su festosi ritmi ternari, che si
allentano nel più discorsivo 4/4
solamente laddove il testo
richiede un trattamento più
meditativo.
Un discorso più approfondito si
rivela necessario a proposito
dei Mottetti, di cui tre basati
sul Cantico dei Cantici,
e due sulla preghiera mariana
del Salve Regina.
Numerose sono le meditazioni
culturali attraverso le quali il
messaggio di tenero, quanto
esplicito erotismo del Cantico
è stato convertito, dal suo
originale contesto letterario,
all'utilizzazione sacra (sposa =
Chiesa, sposo = Cristo);
Monteverdi, a differenza di
altri compositori coevi, sembra
intenzionato a mantenere vivo
l'intimo afflato psicologico di
queste pagine, senza nulla
sacrificarne alle formali
esigenze liturgiche. Ai nostri
orecchi queste tre composizioni
(Ego flos campi per
contralto; O quam pulchra
per tenore; Ego dormio
per soprano e basso) risuonano
cariche di quel misticismo in
cui l'estasi dello spiritoè
mediata dall'esperienza dei
sensi. A veri e propri, per
quanto sublimati, travestimenti
di visioni carnali assistiamo
sovente nell'arte sacra del XVII
secolo: all'esempio clamoroso
della S. Teresa del
Bernini si può affiancare la
vasta produzione pittorica di
soggetti efebici (giovani santi,
angeli e arcangeli); e lo stesso
ricorrente motivo simbolico di Amor
sacro e Amor profano
conduce talora ad un'ambigua
confusione di ruoli. Se l'area
figurativa agiva in un ambito
controverso, ove era comunque
necessario salvare le apparenze
dell'incorrubilità, la musica
sacra nondimeno, mentre parlava
il linguaggio della spiritualità
o del fasto temporale, poteva
tuttavia insinuare, in certi
orecchi particolarmente
sensibili, arcane allusioni ad
antiche consuetudini pagane. E
qualcosa di simile, con le loro
umbratili fioriture e con le
armonie piane e trascoloranti,
sembrano evocare ancora oggi
questi tre meravigliosi
mottetti.
Similmente i due Salve
Regina per tenore, il
primo con l'iterazione, ad ogni
frase, dell'appassionata
invocazione "O Regina, o
mater..."; il secondo con
l'estrema libertà di
declamazione e con la scrittura
altamente virtuosistica (che
richiama quella del Possente
spirto dall'Orfeo),
senza nulla perdere di mistico,
trapassano tuttavia l'ambito
sacro per battere, piuttosto, i
sentieri più consoni del Genere
Rappresentativo.
In questa registrazione, le
Intonazioni d'organo di Andrea e
Giovanni Gabrieli vengono
restituite alla loro autentica
funzione; trattandosi di musiche
d'ambito veneziano, non è
ingiustificato accostarle a
musiche di Monteverdi, che per
trent'anni fu direttore della
Cappella di S. Marco. Nei brani
di tipo solenne e declamatorio,
il continuo all'organo è stato
realizzato con alcuni registri
di ripieno anziché col solo
principale: in tal modo esse
amplifica e sostiene la voce
che, anche per la posizione
remota delle cantorie nelle
grandi chiese, doveva essere
"gridata" per poter giungere ai
fedeli con il "volume"
necessario a rendere il clima di
annuncio e di esortazione voluto
dal testo e dal momento
liturgico.
Il luogo prescelto per la
registrazione, la Basilica di S.
Michele Maggiore in Pavia, se
pur estraneo alla vita ed alla
produzione di Monteverdi,
costituisce, dal punto di vista
acustico, un tipico (e
splendido) esempio di grande
tempio non addobbato, ove la
pietra viva delle strutture
murarie restituisce una sonorità
ricca e corposa, non
esageratamente riverberante. La
presa del suono ha voluto
cogliere le condizioni di
rapporto fra testo, voci e
strumenti, senza enfatizzarne
colori o dettagli timbrici, ma
riproducendo nel modo il più
fedele possibile l'ambiente
d'ascolto della massa sonora,
quale alla navata giunge
dalla cantoria.
Cristiano
Gianese - Roberto
Gini
|
|
|