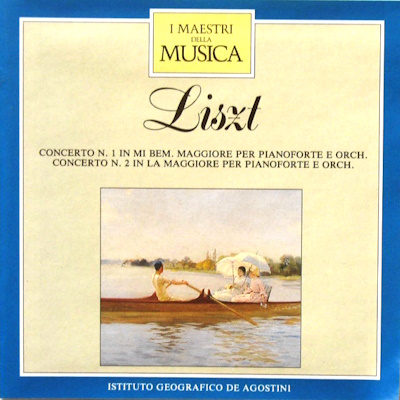 |
|
1 CD -
GMD 2/26 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franz LISZT
(1811-1886)
|
Concerto
N. 1 per Pianoforte e Orchestra in
Mi bemolle maggiore
|
|
18' 30" |
|
|
|
-
Allegro maestoso
|
5' 12" |
|
|
1 |
|
-
Quasi adagio
|
4' 38" |
|
|
2 |
|
-
Allegretto vivace · Allegro animato
|
4' 22" |
|
|
3 |
|
-
Allegro marziale animato
|
4' 18" |
|
|
4 |
|
Concerto N. 2
per Pianoforte e Orchestra in La
maggiore
|
|
20' 45" |
|
|
|
-
Adagio sostenuto assai · Allegro
agitato assai
|
7' 08" |
|
|
5 |
|
-
Allegro moderato
|
5' 15" |
|
|
6 |
|
-
Allegro deciso · Marziale, un poco
meno allegro
|
6' 26" |
|
|
7 |
|
-
Allegro animato
|
1' 46" |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
| Orchestra
Sinfonica della Radio di Zurigo /
Nikita Magaloff, Pianoforte / Serge
Baudo, Direttore |
Juni 1966
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Concert
Hall | SMS 2488 | (p) 1968
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD
2/26 | 1 CD - durata 39'
15" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|

Liszt
|
CONCÉRTO
N. 1 PER PIANOFORTE E
ORCHESTRA
Liszt fu un
musicista dalla grande
personalità, affascinante e
geniale. Quando sedeva al
pianoforte, travolgeva il
pubblico trasmettendo un
entusiasmo e una
passionalità che, anche
nella sua musica,
difficilmente potevano
accordarsi con la simmetria
formale o con le regole
accademiche. Di qui alcuni
eccessi, come, ad esempio,
un esagerato amore per le
ridondanze o per i discorsi
un po' troppo lunghi e
artifíciosi, tuttavia in
perfetta sintonia con l'uomo
e il pensatore.
Commentando la musica di
Schumann, egli avvertiva che
la sua bellezza è talvolta
«nascosta sotto la
regolarità simmetrica» e che
questa regolarità «non è in
armonia con l'entusiasmo
ardente, intimamente
divoratore, del sentimento
rivelato». Queste parole
sono una specie di credo
artistico di Liszt. Il Concerto
n. 1 si iscrive
pienamente in questa logica
e si apre dinanzi a noi come
una rappresentazione
teatrale in cui i colpi di
scena si susseguono e i
diversi temi non sono più
relegati nell'uno o
nell'altro movimento, ma
circolano lungo tutta la
composizione dandoci
l'impressione di un continuum
in evoluzione. Scritto nel
1849, fu rivisto nel 1853
con la collaborazione di
Raff ed eseguito per la
prima volta a Weimar nel
1855.
Ricondotto da molti studiosi
a una riflessione operata
dall'autore sulla Wandererfantasie
di Schubert, il Concerto
n. 1 attacca deciso e
fortissimo con il primo
tema, energico e virile,
costituito sull'intervallo
di semitono discendente.
L'ingresso del pianoforte è
volutamente grandioso e
subito compare una cadenza
in cui troviamo anche una
citazione del tema a. Di
nuovo entra l'orchestra, e
in questa sapiente
alternanza solo-tutti, o in
una sovrapposizione di
entrambe le parti, si dipana
il primo movimento,
arricchito dalla presenza di
altri tre nuclei tematici
che si alternano e si
mescolano, secondo una
logica dettata dall'intima
effusione dei sentimenti e
non certamente da un rigore
costruttivo di tipo
brahmsiano. Il primo
movimento si conclude quindi
con un dialogo tra
pianoforte e orchestra, in
cui si alternano i temi a e
b.
Il secondo movimento è
costituito da tre sezioni
molto diverse tra loro:
Quasi adagio, Allegretto
vivace e Allegro animato,
che fanno pensare alla
fusione fra Andante e
Scherzo, solitamente secondo
e terzo movimento di un
concerto. Nella prima
sezione vengono presentati
tre nuovi nuclei tematici,
mentre nella seconda e nella
terza sezione, oltre ad
altri due nuovi temi,
ricompare il tema a, che
rende ancora più profondo il
legame tra le diverse parti
della composizione.
L'Allegretto vivace attacca
con un divertentissimo
motivo, in cui pianoforte e
triangolo dialogano creando
suggestioni che ricordano le
melodie dei carillons.
Ritorna qua e là il ricordo
del tema iniziale, che
diventa protagonista
nell'Allegro animato, in cui
vi è una vera e propria
ripresa del primo movimento;
con le note del primo
passaggio con cui il
pianoforte ha esordito
nell'Allegro maestoso si
conclude questo movimento.
Il terzo movimento, Allegro
marziale animato, ci propone
una rielaborazione
fantasiosa di quei motivi
che abbiamo ascoltato nelle
pagine precedenti. Al
pianoforte sono affidati i
momenti di maggior effetto,
ricchi di spunti sempre
nuovi e brillanti. Una
tensione crescente, con un
infittimento progressivo
della narrazione, culmina
con il Presto finale in cui
di nuovo il tema a, vigoroso
e travolgente, pronuncia la
parola conclusiva.
Maria
Luisa Merlo
CONCERTO
N. 2 PER PIANOFORTE E
ORCHESTRA
La produzione
per pianoforte e orchestra
di Liszt evidenzia un
processo creativo del tutto
sofferto e colorato da
un'incolmabile
insoddisfazione. Le date lo
stanno a testimoniare:
ventisei anni per dare una
versione definitiva al Concerto
n. 1, venticinque per
la Totentanz e
ventidue per il Concerto
n. 2. Per
quest'ultimo, Liszt iniziò a
stendere i primi abbozzi nel
1839 e soltanto nel 1861
elaborò la quarta e
definitiva versione. Questo
critico itinerario
compositivo fu il frutto di
un'accesa volontà decisa a
risolvere una fondamentale
questione musicale
dell'Ottocento europeo: la
definizione di un nuovo
modello di composizione per
pianoforte e orchestra.
L'autore, sulla traccia
delle proposte lanciate da
Mendelssohn col suo Concerto
op. 25, aspirava a un
brano non più scandito
nettamente in movimenti, ma
caratterizzato da un flusso
musicale continuo, nel quale
ciclicamente regnasse una
totale unificazione
tematica. E infatti, il Concerto
n. 2 è percorso,
dall'inizio alla fine, da
una sola idea importante in
continua trasformazione
formale e caratteriale.
Sempre secondo le
anticipazioni di
Mendelssohn, Liszt spinse
ancor più avanti la fusione
sonora tra la scrittura del
pianoforte e quella
dell'orchestra, cosicché
questo brano si presenta più
come opera sinfonica che
solistica con
accompagnamento. Eppure il
musicista, nel realizzare un
nuovo tipo di concerto per
pianoforte, fece ancora
appello ad affermati canoni
compositivi. Il segreto è
nel come li utilizzò. In
pratica, Liszt, nella sua
ricerca formale di un'unità
ciclica assoluta, finì per
ampliare a tutta la
composizione la solida
struttura di un unico primo
tempo di concerto in
forma-sonata, dando assoluta
preponderanza al solo primo
tema. Pur nella continuità
del discorso musicale, si
possono così individuare in
trasparenza le sezioni
tipiche dell'esposizione,
sviluppo, ripresa, cadenza e
coda.
Le opere di Liszt
acquistarono spesso la fama
di una certa faciloneria, di
un vertiginoso quanto
superficiale virtuosismo. In
realtà, il musicista, pur
trattando problemi
compositivi non
indifferenti, non perse mai
di vista l'uso spettacolare
a cui i pezzi erano
destinati; le soluzioni
musicali vennero quindi
esposte al pubblico in
maniera sempre semplice e
comunicativa, anche se a
volte retorica. Il Concerto
n. 2, in particolare,
è un punto fermo nello
sviluppo musicale
dell'Ottocento. Opera di
un'entusiasmante bellezza
compositiva, ha dovuto
tuttavia pagare lo scotto
dei pregiudizi musicali di
critici ed esecutori,
rimanendo a lungo relegata
ai bordi del repertorio
concertistico corrente.
Il Concerto inizia
con un Adagio sostenuto
assai, che presenta subito
il tema fondamentale: un
disegno musicale di profonda
bellezza, armonicamente
inquieto. Sarà questa
l'"idea fissa" che
attraverserà incessantemente
la composizione, mutando in
continuazione,
metamorficamente, il proprio
carattere spirituale. Sono i
legni a esporlo per la prima
volta, imprimendogli un
aspetto mistico e
meditativo. In questa
situazione risaltano gli
interventi dell'oboe e,
soprattutto, del clarinetto,
che, dopo suggestivi
tremolii, scende in zone
molto oscure della sua
timbrica, incupendo
l'atmosfera. La frase
musicale è quindi ripetuta
con l'ausilio del
pianoforte, che prima
propone in 'piano' sospesi
arpeggi, che spezzano la
linea musicale originaria,
per poi precipitare
anch'esso vorticosamente su
registri profondissimi,
creando una transizione
emotiva al successivo
Allegro agitato assai. È
questo un acceso episodio
che sviluppa la materia
tematica precedentemente
introdotta e che procede con
un irresistibile crescendo
di pathos in un
alternarsi d'interventi
dell'orchestra (che con gli
archi percuote un
martellante motivo) e del
solista (che cresce sempre
più virtuoso ed emozionato
inuna sezione molto
impegnativa per
l'esecutore). Questo
sviluppo si spezza
all'improvviso su una serie
di arpeggi d'attesa del
pianoforte, che caricano
l'atmosfera di pensierosa
tensione e ci introducono a
un Allegro moderato. Gli
archi si aprono per primi
lentamente in un bruno
intervento, seguito da
brevi, veloci e sempre più
acuti arpeggi del solista;
questo dà presto spazio a
una sentitissima frase del
primo violoncello che
ripropone l'idea base. Dopo
che il pianoforte si è
abbandonato a un più lungo
periodo, intensamente
lirico, sarà l'oboe a
emergere. Al termine di
alcune battute che donano
rilievo solistico a singoli
strumenti dell'orchestra,
ancora il pianoforte, con
una lunga linea musicale,
prepara all'Allegro deciso,
che continua, sempre in un
clima di fuoco, il
precedente sviluppo rimasto
interrotto. L'orchestra,
agitatissima, procede
facendo leva sul tono eroico
degli ottoni; i legni
propongono momenti più
cantabili e il solista si
confronta con fluttuanti
sali-scendi sulle note alte.
Segue un crescendo, che
introduce al Marziale, un
poco meno allegro. Questo
ripete trionfalmente, con
potenti accordi ritmati
dall'intervento dei piatti,
il tema fondamentale, che
assume toni quasi di fanfara
guerresca. Sopravviene poi
inattesa una sezione,
iniziata dal pianoforte, che
prende le movenze di una
grande cadenza con
orchestra. Vi è qui una
reminiscenza delle luci
elegiache dell'Allegro
moderato. Col suo
progredire, la presenza
della compagine orchestrale
si fa via via più corposa e
vivace; ancora una volta
emergono sospesi interventi
di singoli strumenti sul
divagare del pianoforte, che
raggiunge note assai acute
e, sul finire, prende un
piglio più estemporaneo e
virtuosistico, avviando la
feroce coda conclusiva
(Allegro animato) intessuta
anch'essa sul primo tema. Il
pianoforte è affiancato
dall'accompagnamento
orchestrale, che si esprime
con vigorose sonorità
rinforzate da ottoni e
piatti, mentre il solista
scivola sulla tastiera con
rapidi glissando. Il pezzo
assume velocemente toni più
accesi; mentre i corni
espongono epicamente e i
legni fremono, il pianoforte
si esibisce in velocissimi e
arditi passaggi ricchi di
accordi ribattuti, finché
l'orchestra chiude
entusiasticamente il Concerto.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|