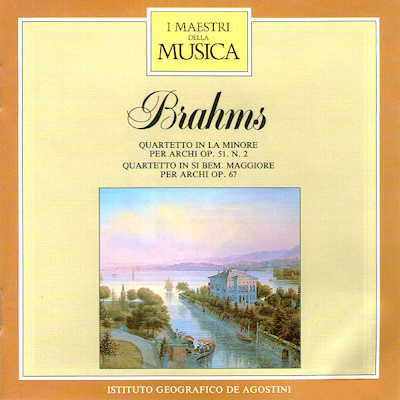 |
|
1 CD -
GMD 2/23 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Johannes
BRAHMS (1833-1897)
|
Quartetto
per Archi in La minore, Op. 51 N.
2
|
|
31' 37" |
|
|
|
- Allegro non
troppo
|
9' 31" |
|
|
1 |
|
- Andante moderato
|
10' 29" |
|
|
2 |
|
- Quasi minuetto
moderato
|
4' 46" |
|
|
3 |
|
- Finale. Allegro
non assai
|
6' 51" |
|
|
4 |
|
Quartetto per
Archi in Si bemolle maggiore,
Op. 67
|
|
33' 04" |
|
|
|
- Vivace |
7' 38" |
|
|
5 |
|
- Andante |
7' 30" |
|
|
6 |
|
- Agitato |
7' 52" |
|
|
7 |
|
- Poco allegretto
con variazioni
|
10' 04" |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
| Quartetto Janacek
|
Studio
Domovina, Prague: Juny 1966 (1-4) |
December 1965 (5-8)
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| SMS 2986 | (p) 1967
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 2/23
| 1 CD - durata 64' 41" | (c) 1989
| ADD |
|
|
Note |
|
-
|
|
|
|
|
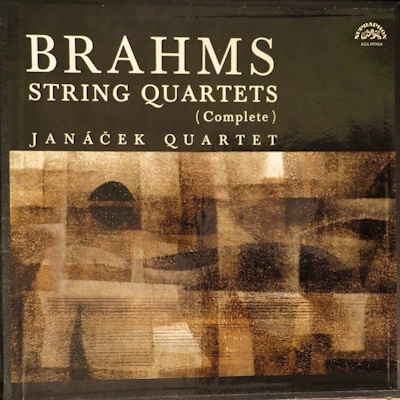
Brahms
|
QUARTETTO
PER ARCHI OP. 51 N. 2
Lo studioso
Massimo Mila ha osservato
come il punto nevralgico
della musica di Brahms sia
sempre la forma: «Apprezzato
da molti come un maestro
dell'architettura formale
per le quattro monumentali Sinfonie,
i Concerti (due per
pianoforte, uno per violino,
uno per violino e
violoncello) e la numerosa
musica da camera, egli è un
romantico, felice, come
Schumann, nell'espressione
immediata dell'intuizione in
forme libere, volta per
volta inventate, ma si
misura in una lotta
disperata col grande ideale
della forma classica,
cercando di piegarvi, con
ostinata perseveranza, un
linguaggio musicale che da
un pezzo ha perduto la
concisa geometricità
beethoveniana e la sua
simmetria di rispondenze
tonali, che ha diluito la
logicità dell'armonia con il
copioso cromatismo, con le
caratteristiche sue frasi
spezzate, ma di lunghissimo
respiro, intessute l'una
all'altra con paziente
lavoro contrappuntistico in
un ininterrotto monologo, e
con il frequente impiego di
modi antichi. Questo sforzo
richiese sempre a Brahms
tanta meticolosa accuratezza
nella composizione che gli
faceva dichiarare: “Non c'è
vera creazione senza lavoro
accanito; ciò che chiamate
invenzione non è che
un'ispirazione dall'alto, di
cui non sono responsabile e
per cui non ho alcun
merito”. Perciò l'elogio
convenzionale che gli si
tributa, d'aver unito i
principi classici di
chiarezza e non solidità
formali all'ardore e alla
spontaneità della scuola
romantica, va piuttosto
mutato nell'opposta
constatazione che Brahms fu
un romantico prigioniero
della forma».
Brahms si avvicinò a mete
tecnico-stilistiche
complesse, a forme
“importanti” della
tradizione musicale solo con
la maturità. È infatti a
quarant'anni che il
musicista compose e
“riconobbe” i suoi primi
quartetti per archi;
“riconobbe”, in quanto,
negli anni giovanili,
caratterizzati da dubbi e
ripensamenti, aveva
distrutto numerose sue
composizioni, fra le quali è
certo vi fossero anche dei
quartetti per archi.
Brahms si accostò alle varie
forme musicali lentamente,
con metodo e caparbietà, ma
anche con la ferma
intenzione di assimilarne
ogni piccola sfumatura
tecnica. Partito dalle
composizioni per pianoforte
e dai Lieder, si
misurò poi, con l'aiuto
dell'amico violinista Joseph
Joachim, con esercizi di
contrappunto sempre più
ardui e complessi;
contemporaneamente si
avvicinò alle tecniche degli
strumenti in orchestra,
allargando in maniera
sensibile il suo orizzonte
formale. Passò così
attraverso anni fecondi in
cui compose molti brani per
coro e per organo; si
cimentò anche con due
quartetti con pianoforte, lo
strumento che così ben
conosceva e che gli permise,
in questo caso, di risolvere
problemi di sonorità che gli
archi non riuscivano a
rendere piena come era nei
suoi desideri. Ma Brahms non
aveva fretta, intendeva
misurare bene le sue forze;
voleva essere sicuro che,
quando avrebbe affrontato
forme quali la sinfonia e il
quartetto per archi, avrebbe
avuto la totale padronanza
dei mezzi tecnici, formali
ed espressivi.
Prima di terminare nel 1873
i Due quartetti op. 51
, Brahms aveva messo mano ad
almeno una ventina di
quartetti per archi: li
abbozzava, ne parlava con
gli amici nelle lettere,
faceva loro ascoltare alcuni
frammenti, ma poi,
insoddisfatto, li metteva da
parte e li distruggeva. Era
continuamente roso dal tarlo
del dubbio, scontento di un
lavoro che riteneva sempre
lontano dal suo ideale di
perfezione.
«È ben facile comporre»,
diceva sovente, «ciò che è
invece tremendamente
difficile è scartare le note
superflue». Forse, in queste
parole si può scorgere anche
un'accusa alla 'nuova
musica' di Wagner e di
Bruckner che, per molto
tempo e a torto, fu
considerata l'antitesi del
modello brahmsiano. A parte
queste rivalità, più volute
dai contemporanei che dai
compositori stessi, resta il
fatto che il musicista
amburghese impiego parecchi
anni di gestazione per
completare l'Op. 51.
La prima notizia precisa
riguardante i due quartetti
si ha nel 1866, quando Clara
Schumann, l'amica di sempre
di Brahms, annotò nel suo
diario che Johannes le aveva
suonato alcune magnifiche
parti del Requiem
tedesco, nonché di un
Quartetto d'archi in do
minore. Più tardi
Brahms fece sentirele
versioni non definitive di
questo e di un altro Quartetto
in la minore ad amici
di Bonn.
Si dovette tuttavia
aspettare l'estate del 1873
perché il musicista
completasse le due
composizioni da camera. Nel
maggio di quell'anno, Brahms
si era stabilito a Tutzing,
una località nei pressi di
Monaco e sulle rive del lago
Starnberg. Per quel
soggiorno, aveva scelto
l'albergo Seerose (Rosa
delLago), dove poté disporre
di un pianoforte vecchio e
scassatissimo che, tuttavia,
servì ottimamente all'uso.
Proprio su questo infelice
strumento Brahms riuscì a
concludere, nel corso
dell'estate, tre opere che
da tempo aveva progettato:
le Variazioni su un tema
di J. Haydn op. 56 e i
Due quartetti per archi
op. 51, che fece
ascoltare a Clara Schumann
durante il breve soggiorno
successivo a Lichtental.
Anche al termine di una così
lunga e sofferta gestazione,
Brahms non si ritenne
soddisfatto dei risultati.
Consegnando gli spartiti
all'editore Simrock,
confessò che, pur avendo
voluto creare delle opere di
un certo impegno, i
risultati, purtroppo, erano
stati solo modesti e che la
ricompensa avrebbe dovuto
andare non a lui, bensì al
paziente albergatore di
Tutzing.
I Due quartetti op. 51,
che vennero dedicati
all'amico Theodor Billroth,
un chirurgo viennese
appassionato di musica e
violinista dilettante,
furono eseguiti per la prima
volta a Vienna, nel corso
dell'autunno, dal famoso
quartetto Hellmesberger.
Il Quartetto n. 2,
che qui ascoltiamo, pur
essendo in tonalità minore
(la minore) come il
precedente (do minore),
presenta caratteristiche
assai differenti. È infatti
romantico e vicino allo
stile poetico di Schumann,
mentre il Quartetto n. 1
appare più austero e
drammatico. Diviso in
quattro tempi, il Quartetto
n. 2 ha il tema
principale del primo
movimento (Allegro non
troppo) costruito sulle
lettere iniziali del motto Frei
aber Einsam (Libero ma
solo), che, nella notazione
tedesca, corrispondono alle
note fa-la-mi. Quel motto
era tra l'altro il
prediletto dell'amico
Joachim e sintetizzava uno
dei grandi ideali romantici.
Se l'inizio della
composizione è tenero,
delicato e intriso di
atmosfere sognanti, il
secondo tema, più struggente
e accorato, ricorda certe
atmosfere danzanti della
Vienna dell'epoca. Anche il
secondo tempo (Andante
moderato) rivela lo stesso
spirito delicato, dolce e
lirico come solo certe
pagine schumanniane sanno
essere. Il terzo tempo
(Quasi minuetto moderato) è
suddiviso in due parti: la
prima richiama alla memoria
una ballata, mentre la
seconda ha il brio e il
piglio ritmico dello
scherzo. Il movimento finale
(Allegro non assai) ha la
scansione ritmica, gli
accenti e la forza delle
danze popolari, che qui
ricordano assai quelle
zigane; in alcuni tratti sa
tuttavia spogliarsi della
veemenza ritmico-sonora per
divenire caldo e
malinconico, come un
paesaggio visto in
lontananza, che suscita
emozioni, ricordi
fanciulleschi e nostalgie.
QUARTETTO
PER ARCHI OP. 67
Nel 1875,
quando si apprestò a
comporre il Quartetto in
si bemolle maggiore per
archi op. 67, Brahms
aveva già compiuto, come
abbiamo visto, un lungo
lavoro di ricerca. La
realizzazione del brano
risultò perciò assai meno
difficoltosa rispetto ai Due
quartetti op. 51. Il
musicista scrisse il pezzo
durante il soggiorno estivo
a Ziegelhausen, nelle
vicinanze di Heidelberg, e
lo dedicò a T.W. Engelmann,
un medico di Utrech che si
dilettava di suonare il
violoncello e che era stato
suo ospite durante una
tournée in Olanda.
Il Quartetto è diviso in
quattro movimenti. Il primo
(Vivace) gioca sui contrasti
ritmici fra il tempo in 6/8
e quello in 3/4, spostando
sovente gli accenti sui
tempi deboli. Mentre il
primo violino gioca un ruolo
preminente, nel secondo
movimento (Andante) la
struttura risulta assai più
compatta. Il terzo movimento
(Agitato) è caratterizzato
dall'espressivo disegno
melodico della viola in
ritmo puntato, che passa poi
agli altri strumenti mutando
il contorno ritmico. La
composizione termina con un
Poco allegretto con
variazioni basato su un tema
dal sapore popolaresco che,
via via, si arricchisce in
complesse elaborazioni, fino
all'imprevedibile ricomparsa
del primo tema del movimento
iniziale.
Mariangela
Mianiti
|
|
|
|
|
|