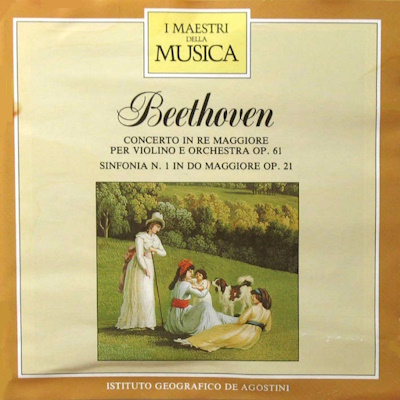 |
|
1 CD -
GMD 2/3 - (c) 1988
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ludwig van
BEETHOVEN (1770-1827)
|
Concerto
per Violino e Orchestra in Re
maggiore, Op. 77
|
|
36' 45" |
|
|
|
-
Allegro ma non troppo
|
21' 29" |
|
|
1 |
|
-
Larghetto
|
8' 51" |
|
|
2
|
|
- Rondò. Allegro
|
6' 25" |
|
|
3
|
|
Sinfonia
N. 1 in Do maggiore, Op. 21
|
|
20' 49" |
|
|
|
- Adagio
molto. Allegro con brio
|
6' 31" |
|
|
4 |
|
- Andante
cantabile con moto
|
6' 07" |
|
|
5 |
|
- Minuetto:
Allegro molto e vivace
|
3' 50" |
|
|
6 |
|
- Finale: Adagio.
Allegro molto e vivace
|
4' 21" |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
| New York
Philharmonic Orchestra / Jascha
Heifetz, Violino / Dimitri
Mitropoulos, Direttore |
New York - 12 Febryary 1956
|
| New York
Philharmonic Orchestra / Dimitri
Mitropoulos, Direttore |
New York - 25 November 1951 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Movimento
Musica | 01.005 | (p) 1981
Melodram | Mel 233 | (p) 1985 ?
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 2/3 | 1 CD - durata
57' 58" | (c) 1988 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|

Beethoven (1-3)
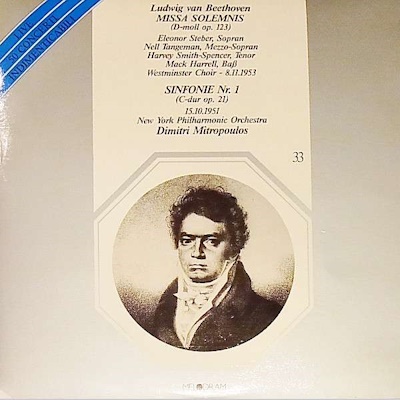
Beethoven (4-7) ?
|
CONCERTO
IN RE MAGGIORE
PER
VIOLINO E ORCHESTRA OP.
61
Questo
concerto, nato nel 1806 e
dedicato a Stephan Breuning,
allievo di Beethoven, era
destinato all'esecuzione del
noto violinista Franz
Clement, che vi si cimentò
per la prima volta il 13
dicembre 1806 al teatro An
der Wien.
Nel primo movimento,
Beethoven raggiunge la
completa conciliazione tra i
principi del concerto e
quelli della forma-sonata.
L'inizio fa presagire un
seguito ricco di
avvenimenti. Cinque note
sommessamente ribattute dai
timpani: sembrano nulla più
che un segnale d'apertura,
una formula convenzionale
per mettere in moto il
discorso; invece la
ritroveremo lungo tutto il
pezzo come elemento
essenziale, come idea
ricorrente, che Beethoven
rivestirà di varie forme
cantabili. Il tema
principale (tema a)
s'innesta subito sull'ultima
nota dei timpani, eseguito
dai legni, oboi, clarinetti
e fagotti. Tacciono gli
archi, che nella musica
dell'età classica avevano il
ruolo di protagonista,
assumendo di norma la
realizzazione dei temi
principali. Proprio il
silenzio degli archi e, in
loro vece, la sonorità per
così dire sussidiaria dei
legni ci dicono che siamo
ancora ai preamboli del
discorso vero e proprio.
Agli archi Beethoven lascia
il compito provvisorio di
riprendere il motivo dei
timpani, e di concludere il
tema. Questo modello si
ripete fino alla fine della
prima esposizione: ai legni
il compito di esporre
un'idea nuova, agli archi
quello di concluderla. Ciò
avviene sia nella zona di
ponte tra il tema a
e il tema b, sia
nella presentazione dello
stesso tema b. Il
ponte interrompe la
compostezza del canto con
un'agitazione sottolineata
dall'intensità ff (fortissimo)
e dagli inquieti ribattuti
degli archi. Se l'espansivo
tema b sembra
ripristinare il pur vibrante
ordine iniziale,
l'equilibrio ormai è stato
spezzato, e ce ne accorgiamo
alla conclusione di b,
di competenza, s'è visto,
degli archi. Questi non
svolgono (come facevano con
a) il tema,
semplicemente lo ripetono;
ma con una variante
decisiva: non più nel solare
modo maggiore dell'inizio,
bensì nel più introverso
modo minore. Il segnale
delle cinque note (ora
ribattute dagli archi) avvia
la coda dell'esposizione,
una coda che la fantasia di
Beethoven sottrae allo
stereotipo con l'imprevista
pennellata di un motivo
nuovo, completamente
giocato, proprio alle ultime
battute, tra violoncelli e
contrabbassi da una parte,
legni e violini dall'altra.
In questi primi minuti di
musica è già in nuce
la vicenda che occuperà
l'intero primo movimento e
che può riassumersi
nell'alternanza del modo
maggiore con il modo minore
e nell'associazione del modo
con la scelta di certi
timbri dell'orchestra: i
fiati annunciano il tema in
maggiore e gli archi o il
solo violino lo ripetono in
minore. La struttura tipica
del concerto vuole che
l'esposizione sia ripetuta
dal solista, e così avviene.
Il violino si presenta sulla
scena con una singolare
gestualità da istrione.
Balza dal suono più grave al
sol acuto, ridiscende con un
rotolio di morbide terzine,
per guizzare infine nella
regione sovracuta. E proprio
lì, in una zona sonora così
spiazzata rispetto a quella
più rassicurante della
regione centrale (la regione
della voce umana, per
intenderci), il violino
ripropone il tema a.
Il ruolo indiscusso di
protagonista è mostrato
dalla libertà con cui
fiorisce il tema, sopra la
ripetizione fedele che
invece ne fanno i legni. Il
dialogo tra il violino e
l'orchestra continua con una
stupefacente varietà di
soluzioni lungo tutto il
primo movimento: nella coda,
che Beethoven ampiamente
dilata a concludere la
riesposizione; nello
sviluppo, in cui l'orchestra
accetta il ruolo umile di
comprimaria alle esuberanti
effusioni del solista; nella
ripresa, dominata da una
vigorosa riorchestrazione
dei temi e da un dialogo
fitto e ininterrotto tra i
due interlocutori.
Il secondo movimento,
Andante, è incentrato sul
canto melodioso del violino
che, dopo le quattro
ripetizioni del tema da
parte dell'orchestra, si
effonde, sempre più esaltato
dal progressivo diradarsi
delle altre voci. Il Rondò
conclusivo interrompe
bruscamente l'incanto
dell'Andante con l'irruzione
di una danza energica e
nello stesso tempo dolce e
graziosa. Da qui il solista
riparte come rinato ad una
nuova vita e conclude il
concerto in perfetta
comunione con l'orchestra.
Maria
Luisa Merlo
SINFONIA
N. 1 IN DO MAGGIORE
La Sinfonia
n. 1, dedicata al
barone Gottfried van
Swieten, fu presentata al
pubblico in un concerto al
Teatro Imperiale di Vienna
il 2 aprile 1800. La
composizione, che concludeva
il concerto, non fu accolta
con particolare favore dagli
ascoltatori, che invece
nella stessa serata
manifestarono, e con
vivacità, la loro
predilezione per il Settimino
op. 20 (un lavoro del
quale Beethoven stesso disse
poi al suo favorito allievo
Carl Czerny: «Non so
spiegarmi perché piaccia
tanto»).
Dei sette pezzi in programma
due erano di Franz Joseph
Haydn e uno di Wolfgang
Amadeus Mozart. Dunque il
nuovo arrivato,
introducendosi cautamente
nel regno della sinfonia,
riservato allora ai due
sunnominati monarchi, con
sagace preveggenza aveva
posto il suo audace
tentativo sotto l'augusta
protezione di Haydn e di
Mozart. Non gli furono però
risparmiate le critiche: la
“Gazzetta di Lipsia” trovò
che «nella Prima
Sinfonia di Beethoven
vi era Haydn spinto alla
bizzarria fino alla
caricatura», e il maestro,
irritato, definì quei
giornalisti «i buoi di
Lipsia».
Alexander Oulybycheff
affermava: «Sarebbe una
meraviglia se Haydn e Mozart
non fossero vissuti prima di
lui».
Hippolyte Barbedette vedeva
il lavoro «sotto l'impero di
Mozart». Infine Hector
Berlioz menava giù dei gran
fendenti scrivendo: «L'idea
poetica, così grande e così
ricca nella maggior parte
delle opere seguenti di
Beethoven, qui manca
affatto. È musica
mirabilmente combinata,
chiara, viva, ma poco
espressiva, fredda e
talvolta meschina, come, ad
esempio, nel rondò finale,
vera puerilità musicale. In
una parola: qui Beethoven
non c'è».
A quel tempo per tutti era
articolo di fede che il
vertice della forma
sinfonica era stato
raggiunto da Mozart nella Sinfonia
n. 41 K. 551 'Jupiter'
e da Haydn nella Sinfonia
n. 104 'London'. Dopo
questi capolavori assoluti
non avrebbero potuto
esserci, per i fedeli dell'ancien
régime, che un
silenzio ammirato e una
devota contemplazione. A
questo punto va rilevato che
se la Prima di
Beethoven nella disposizione
e nel rapporto delle parti
presenta certe modalità che
furono effettivamente
inventate e codificate da
Haydn e da Mozart, essa però
contiene in più tutto quello
che vi ha messo Beethoven:
un quid che ha
modificato idealmente il
valore di quanto era di
derivazione haydniana e
mozartiana e lo ha
trasformato facendolo
diventare di pura pertinenza
dello spirito beethoveniano.
Scrive Guido Pannain: «È
giusto dire che Beethoven è
Beethoven anche nella Prima
Sinfonia. Un Beethoven
che riflette l'uomo nuovo
del Romanticismo, il quale
impegna nell'arte la sua
intiera personalità». Se
proprio si vuol conoscere un
lavoro beethoveniano di
stretta obbedienza haydniana
bisogna rifarsi a quella Sinfonia
di Jena che deve il
suo nome al fatto di essere
stata rinvenuta nel 1911
negli archivi del Collegio
Musico di Jena. Beethoven
l'aveva scritta a Bonn,
ancora ventiduenne, ma non
1'aveva poi mai inserita nel
catalogo delle sue opere.
Per quanto riguarda la Prima
Sinfonia, va detto
comunque che il suoaspetto
meno originale si individua
nel quarto tempo, Allegro
molto e vivace, che si
mantiene scrupolosamente
entro i confini tracciati da
Haydn all'espressione e
perciò diventa anche banale,
come giustamente osservò
Berlioz. La parte più nuova
e personale è invece
costituita dal terzo tempo,
un Minuetto che presenta già
il carattere di uno di
quegli scherzi
prodigiosamente animati da
giovanile impazienza e da
impetuoso entusiasmo che
saranno le sigle trionfali
delle future sinfonie del
maestro. Una corsa
vertiginosa verso la
conclusione, un vortice di
vitalità che ha un'unica
breve pausa nel Trio, basato
sul contrasto timbrico dei
fiati (oboi, clarinetti,
fagotti, corni) con gli
archi. Esso, secondo Massimo
Mila, è «un purissimogioco
di volumi orchestrali e di
geometrie sonore».
In definitiva, se il tono
generale di questa sinfonia
può far pensare - come ha
sottolineato Eduardo
Rescigno - al Mozart della Sinfonia
in sol minore n. 40 K.
550 o a un Haydn 'minore' -
e ciò soprattutto nel primo
e nel secondo tempo - c'è
però in tutta la
composizione «qualcosa di
assolutamente nuovo ed è la
diversa funzione che in
questo discorso orchestrale
assume il ritmo. Un ritmo
sempre definito e scattante
che sembra voler costringere
la musica entro le sue leggi
implacabili».
Una radiosa anticipazione
dei futuri capolavori.
Silvestro
Severgnini
|
|
|
|
|
|