 |
|
1 CD -
GMD 1/25 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wolfgang
Amadeus MOZART (1756-1791)
|
Divertimento
per Orchestra d'Archi in Sol
maggiore "Eine Kleine Nachtmusik",
K. 525
|
|
18' 33" |
|
|
|
-
Allegro
|
6' 12" |
|
|
1 |
|
-
Romanza. Andante
|
6' 24" |
|
|
2
|
|
- Minuetto.
Allegretto
|
2' 15" |
|
|
3
|
|
- Rondò. Allegro
|
3' 42" |
|
|
4
|
|
Divertimento
per 2 Clarinetti e Fagotto in Si
bemolle maggiore, K. Anh. 229 |
|
16' 09" |
|
|
|
- Allegro
|
5' 09" |
|
|
5 |
|
- Minuetto.
Allegretto
|
2' 57" |
|
|
6 |
|
- Adagio
|
2' 54" |
|
|
7 |
|
- Minuetto |
2' 44" |
|
|
8 |
|
- Rondò. Allegro |
2' 25" |
|
|
9 |
|
Divertimento
per Orchestra d'Archi in Re
maggiore, K. 136
|
|
14' 17" |
|
|
|
- Allegro |
6' 15" |
|
|
10 |
|
- Andante |
4' 15" |
|
|
11 |
|
- Presto |
3' 47" |
|
|
12 |
|
Adagio
e Fuga per Orchestra d'Archi in Do
minore, K. 546
|
|
9' 16" |
|
13 |
|
|
|
|
|
Czech Chamber
Orchestra / Josef Vlach, Direttore
- (1-4,10-13)
|
Studio Domovina, Prague - 1960
|
Czech
Philharmonic Wind Ensemble - (5-9)
|
Studio Domovina, Prague - April /
November 1973 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| SUA ST 50190 | (p) 1968 -
(1-4,10-13)
Supraphon | 1 11 1671/2 | (p)
1974 - (5-9)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/25 | 1 CD -
durata 59' 20" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
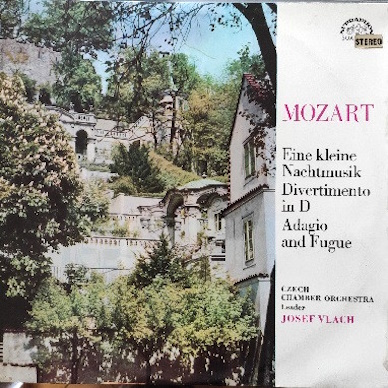
Mozart
(1-4,10-13)
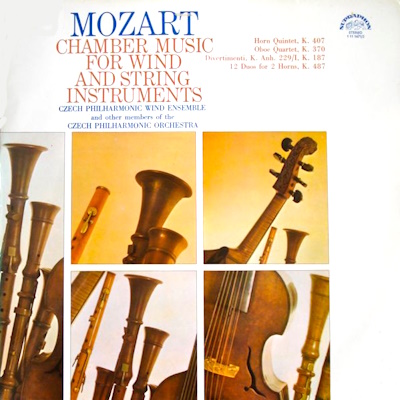
Mozart
(5-9) |
SERENATA
IN SOL MAGGIORE K.525
"EINE KLEINE NACHTMUSIK"
Soprattutto
durante il suo soggiorno
salisburghese Mozart compose
un gran numero di serenate,
divertimenti, cassazioni.
Sono, per lo più, lavori
occasionali che il musicista
stese sotto incarico e nella
maggior parte destinati alle
feste degli aristocratici.
Di conseguenza lo spirito
che li permea e normalmente
leggero, scorrevole e
sereno; mentre lo stile
spesso fa capo ai principi
dell”estetica galante e
all'antica forma della Suite
di danze, senza mai
tralasciare, però, una buona
dose di facile cantabilità
popolare. A Vienna
nell'agosto del 1787, un
anno di grande impegno (è
completato il Don
Giovanni) e di grandi
dolori (muore papà Leopold),
stranamente Mozart compie un
ritorno al genere della
Serenata, che aveva
praticamente abbandonato sin
dal 1782 circa. La stesura
della Eine Kleíne
Nachtmusík (Piccola
musica notturna) in sol
maggiore K.525 per orchestra
d'archi si propone come un
nostalgico ripiegamento su
antiche forme e antichi
ricordi, rivíssuti però
attraverso i mezzi di una
piena maturità artistica. Da
alcuni autografi del
musicista apprendiamo che
originariamente la Serenata
era regolarmente suddivisa
in cinque tempi e che il
Minuetto con Trio che
seguiva il primo movimento è
andato invece perso.
L'Allegro di apertura mostra
subito l'elegante e
trasparente concisione con
cui procede Mozart che qui
adotta, in dimensioni
ridotte, la forma-sonata,
narrata mediante un discorso
scorrevole, melodico ed
esuberante che propone idee
sempre nuove. L'esposizione
presenta, e poi ripete, due
temi entrambi composti da
due sezioni. Il primo
contrappone a un inizio
forte e ben scandito una
seconda parte più leggera ed
elegante mentre, dopo un
crescendo, il secondo
presenta un motivo cantabile
e aggraziato a cui ne segue
un altro leziosamente
decorato da alcuni trilli.
Dopo un breve Sviluppo
compare la Ripresa che
riutilizza interamente il
materiale proposto
nell'Esposizione. La Romanza
(Andante) è, nella sua
levità, il movimento che
appare più aderente a una
situazione di affettuoso
notturnismo, mentre il
Minuetto (Allegretto),
curioso nell'alternanza di
robustezza e di amabilità,
presenta nella sua parte
mediana un Trio di rara
fluidità musicale. Un Rondò
(Allegro) ha il compito di
chiudere gioiosamente la
Serenata con una
calibratissima mistura di
scatto, .vigore e grazia.
DIVERTIMENTO
K. ANH. 229 -
DIVERTIMENTO K. 136
Nel 1783
Mozart ebbe l'occasione di
conoscere il virtuoso di
clarinetto Anton Paul
Stadler, un impegnato
ricercatore di nuove
possibilità musicali nella
famiglia del proprio
strumento che allora
risultava molto più
variegata di quella di oggi
comprendendo, per esempio,
anche il clarinetto di
bassetto e il corno di
bassetto. Per l'interprete,
che presto divenne amico del
compositore, Mozart ebbe
modo, più avanti, di
scrivere tra l'altro il Quintetto
K .581 e il celebre Concerto
K.622, opere che sono
il frutto di una lunga
collaborazione musicale.
Soprattutto dal 1783 fino al
1785 Mozart prese in
considerazione la
possibilità di proporre
inediti impasti timbrici di
strumenti a fiato e uno dei
concreti risultati di questo
progetto è il Divertimento
K. Anh.229, che è da
datare a poco dopo
l'incontro che Mozart ebbe
con Stadler. La composizione
è tra l'altro da mettere
probabilmente in relazione
con i rapporti che Mozart
tenne con la famiglia del
botanico barone von Jacquin,
alle cui serate contribuiva
presentando alcuni suoi
brevi pezzi, tra cui
vorremmo ricordare alcuni
terzetti vocali tripartiti
(su testi del Metastasio)
che, guarda caso,
richiedevano come
accompagnamento proprio tre
corni di bassetto. Pur
avendo le caratteristiche
del lavoro di ricerca, il Divertimento
K. Anh. 229 si colloca
nell'atmosfera di questi
incontri serali a cui ben
aderisce il suo delicato
intimismo e la scorrevolezza
della sua melodia. Il lavoro
si suddivide in cinque
movimenti, posizionati con
sagacia formale. Quasi come
in un gioco di scatole
cinesi un Allegro e un
Minuetto (Allegretto)
iniziali e un Minuetto e un
Rondò (Allegro) finali
racchiudono, nel cuore della
composizione, un Adagio che
si presenta come il tempo
più carico emotivamente e
dove Mozart, ancora una
volta, riesce a esprimere il
registro di malinconico
pathos del clarinetto.
Il Divertimento in re
maggiore K. 136 per
orchestra d'archi fu
composto da Mozart a
Salisburgo nei primi mesi
del 1772, nel periodo che
intercorre tra il secondo e
il terzo viaggio in Italia.
La classificazione di questo
lavoro non appare molto
semplice, anche se sul
manoscritto la composizione
è denominata 'Divertimento'
e allo spirito di questo
genere si attiene. Infatti
il brano non è canonicamente
tagliato in cinque
movimenti, di cui due
dovrebbero essere minuetti,
e presenta, al contrario,
una tripartizione, con un
tempo lento in posizione
mediana. Del resto il brano
non è neppure un quartetto,
anche se le parti sono
effettivamente quattro,
proprio perché è privo del
caratteristico linguaggio
cameristico. Semmai può
essere avvicinato alla forma
tripartita della sinfonia
d'opera italiana per soli
archi, mancando in partitura
le sezioni degli oboi e dei
corni. Alla fine la
composizione si può
considerare come un prodotto
nel quale lo stile sinfonico
diventa il medium di un
originale assemblaggio di
diverse componenti musicali
del linguaggio strumentale
del secondo '700. Benché
Mozart avesse nel 1772
soltanto 16 anni il
risultato compositivo del
presente lavoro lo pone già
al di là di ogni modello e
di ogni scuola. Il Divertimento
K. 136 fa ancora perno
sul tipico fraseggiare dello
stile galante, ma questo
viene rifondato su nuove e
individuali concezioni
musicali, che lo
rivitalizzano all'interno di
una generale freschezza dei
tratti compositivi. Così nel
primo movimento (Allegro)
incontriamo un travolgente
impulso ritmico che vive, in
perfetta simbiosi, con la
grazia delle luminose
fioriture melodiche.
L'accentuato virtuosismo
orchestrale (interessanti
sono, in tal senso, i giochi
di proposta e risposta
spesso risolti con
accattivanti effetti
dinamici), è sempre
stemperato in un discorso
musicale sciolto e smussato.
Il secondo tempo (Andante)
si abbandona dolcemente a
una situazione più
introspettiva, sempre
comunque regolata da una
trasparenza formale
impeccabile. Il terzo e
conclusivo movimento
(Presto) si apre
sommessamente, ma subito
l'invenzione musicale
mozartiana sfocia in una
elaborazione semplice e
vitalistica, che riesce però
a dare spazio, senza
conflitti interni, a
incisivi interventi di
carattere contrappuntistico.
ADAGIO E
FUGA IN DO MINORE K. 546
Dal 1782
Mozart iniziò uno studio
serrato e approfondito delle
opere di Haendel, di Johann
Sebastian Bach e dei due
figli di quest'ultimo
Philipp Emanuel e
Friedemann. L'occasione gli
fu offerta dal barone
Gottfried van Swieten, un
diplomatico austriaco molto
influente che, tra l'altro,
era stato ambasciatore
imperiale a Berlino dove
aveva avuto l'opportunità di
conoscere la grande arte
bachiana. Tornato a Vienna
il barone si era premurato
di collezionare le più
importanti opere dei maestri
nordici e, successivamente,
di diffonderne la loro
conoscenza. Settimanalmente,
Mozart partecipava alle
serate musicali di van
Swieten pur di aver modo di
attingere al patrimonio
artistico costituito dalla
sua fornitissima biblioteca.
In questo modo studiò
soprattutto gli Oratori
di Haendel ma ancora di più
il Clavicembalo ben
temperato e l'Arte
della fuga di Johann
Sebastian Bach. Così la
musica di Mozart subì uno
spostamento nel suo
indirizzo stilistico, che
procedeva ora parallelamente
alla contemporanea messa a
punto di un nuovo genere di
elaborazione
contrappuntistica che, con
il progredire degli anni,
avrebbe investito tutti i
settori della sua produzione
fornendogli sia gli
strumenti necessari per
l'ultimo e decisivo salto
verso una completa maturità
compositiva e sia per
l'originale risoluzione del
suo conflitto interno tra
stile galante e stile dotto.
Il musicista dedicò molto
tempo alla trascrizione di
fughe bachiane e alla
composizione di altri lavori
in questo stile ma, per la
verità, con risultati poco
personali. Tutt'altro esito
ebbe, invece, l'elaborazione
della Fuga in do minore
K.426 per due
fortepiani, completata nel
novembre del 1783. La
composizione, uno degli
esempi più aurei dell'arte
contrappuntistica
mozartiana, fu ripresa dal
musicista nel giugno del
1788, e trascritta in una
seconda versione per
orchestra d'archi (K.546),
nella cui veste è più
comunemente conosciuta.
Probabilmente questa nuova
stesura, che aggiunge una
maestosa sezione
introduttiva (Adagio) doveva
sviluppare in modo più
completo, nelle intenzioni
di Mozart, tutto il
potenziale contrappuntistico
che in parte andava perso o
inibito con la prima
destinazione strumentale. Il
lavoro si apre appunto con
un fosco e drammatico
Adagio, che ha la funzione
di preludio e che nel ritmo
e in alcuni solenni gesti
richiama alla mente la
grandiosità dello stile di
Haendel. La luce cupa, la
tensione generata, i sottili
intrecci contrappuntistici e
il visionario cromatismo che
attraversano la partitura
donano ancora più rilievo
alla successiva Fuga. Qui
Mozart risolve i severi
procedimenti barocchi in una
personalissima costruzione
di ampio respiro, di
perfetto equilibrio
architettonico e armonico e,
soprattutto, lontano da ogni
accademismo.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|