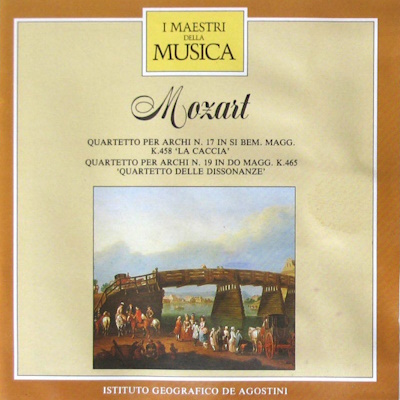 |
|
1 CD -
GMD 1/24 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wolfgang
Amadeus MOZART (1756-1791)
|
Quartetto
per Archi N. 17 in Si bemolle
maggiore "La Caccia", K. 458
|
|
27' 35" |
|
|
|
-
Allegro vivo assai
|
9' 06" |
|
|
1 |
|
-
Minuetto · Moderato
|
4' 23" |
|
|
2
|
|
- Adagio
|
7' 41" |
|
|
3
|
|
- Allegro assai
|
6' 25" |
|
|
4
|
|
Quartetto
per Archi N. 19 in Do
maggiore "delle Dissonanze", K.
465 |
|
28' 01" |
|
|
|
- Adagio, Allegro
|
7' 35" |
|
|
5 |
|
- Andante
cantabile
|
6' 49" |
|
|
6 |
|
- Minuetto·
Allegro
|
5' 17" |
|
|
7 |
|
- Allegro |
7' 20" |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
| Prague String
Quartet |
Studio Domovina, Prague - 1972
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1 11 1471-3 | (p) 1973
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/24 | 1 CD -
durata 55' 03" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
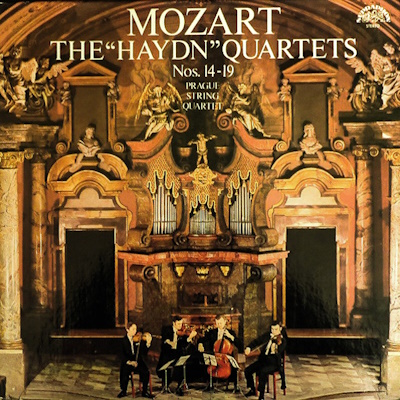
Mozart
|
QUARTETTO
PER ARCHI N. 17
IN SI
BEM. MAGG. K.458 'LA
CACCIA'
Non è stato
ancora stabilito con
esattezza quando Mozart
conobbe di persona Franz
Joseph Haydn ma è da
supporre che l'averne avuto
a Salisburgo come intimo
amico e collega il fratello
minore Michael abbia
rappresentato un fatto di
non secondaria importanza.
Tuttavia abbiamo la certezza
che dalla residenza degli
Esterházy, dove prestava
servizio, Haydn si recava a
Vienna con una certa
frequenza, il che creò
evidentemente le premesse
per la fatale conoscenza.
Comunque nel 1785 i due
compositori erano già amici,
ed ebbero tra l'altro
diversi incontri in casa dei
fratelli Storace, avendo
così occasione non solo di
parlare di musica ma anche
di eseguire insieme dei
quartetti. Col tempo la loro
amicizia doveva diventare un
mito, sfumato e amplificato
da un velo idealizzante ma
abbiamo testimonianze sicure
che Haydn capì presto la
grandezza di Mozart, ne subì
rapidamente l'influsso
compositivo e non perse
occasione, anche dopo la
morte di Wolfgang, di
parlarne sempre con
smisurata ammirazione, senza
mai sminuirne l'evidente
superiorità di
compositore. Mozart, da
parte sua, per tutta la
vita, apprezzo Haydn più di
qualsiasi altro musicista
sia del passato sia suo
contemporaneo, e ne accettò
con affetto l'esempio
creativo.
Nel 1781 Mozart si era
trasferito definitivamente a
Vienna, dove probabilmente
ebbe subito l'occasione di
conoscere i sei
rivoluzionari Quartetti
Russi op. 33, composti
quello stesso anno da Haydn,
secondo, come affermava lo
stesso autore, 'una nuova e
speciale maniera'. La
raccolta proponeva un
nuovissimo e deciso
allontanamento dai principi
compositivi settecenteschi,
legati alla melodia con
accompagnamento, per una
conseguente ed egualitaria
ripartizione dell'importanza
musicale fra le quattro voci
degli strumenti impegnate in
un paritetico colloquio
regolato dalle strutture
della forma-sonata. Sotto il
potente influsso di questi Quartetti,
toccato nel vivo da un senso
di sfida personale e da
un'orgogliosa volontà di
guadagnarsi l'ammirazione
del celebre musicista, il 31
dicembre 1782 Mozart
completava il Quartetto
K. 387, il primo di un
ciclo di sei che, oramai
terminato, inviò ad Haydn
nel settembre dell'85,
assieme a una affettuosa e
famosissima lettera in
italiano, con la quale gli
dedicava la raccolta. Nello
scritto il compositore
riferiva che l'opera era "il
frutto di una lunga e
laboriosa fatica", e, in
effetti, in contrasto con
l'abituale rapidità creativa
mozartiana, la serie di
quartetti detti 'Haydn' era
costata al compositore circa
tre anni di sostenuto e duro
lavoro. La stesura risultò
particolarmente impegnativa,
anche perché dapprima Mozart
dovette assimilare e
raffinare, in una estesa
serie di abbozzi
preparatori, la nuova
tecnica compositiva ideata
da Haydn e successivamente,
per appagare un suo spiccato
senso d'insoddisfazione,
impegnarsi in un'accurata
operazione di revisione e di
correzione. Ciò tanto che si
protrasse, fino all'ultimo
minuto, nella tipografia
dell'editore viennese
Artaria, che pubblicò il
ciclo nello stesso 1785.
Ma i Quartetti Haydn
rappresentarono per Mozart
anche un'occasione per
tentare un inedito innesto
nella forma-sonata di un
nuovo genere di elaborazione
contrappuntistica, non solo
d'influenza haydniana ma
anche, e soprattutto,
derivato dall'intenso studio
che il compositore stava
svolgendo, dal 1782, sulle
opere di Haendel e di Bach
conservate nella biblioteca
del barone Gottfried van
Swieten, in casa del quale
Mozart settimanalmente si
sottoponeva, pur di
attingere a quel patrimonio
artistico, a incontri ed
“esercitazioni” musicali.
Così nel giro di pochi anni
dai modelli cameristici
tardo-barocchi sbocciava
velocemente quel modello di
quartetto d'archi,
perfezionato poi da
Beethoven, che risulterà
essenziale per l'intero
sviluppo musicale
ottocentesco.
Dopo oltre un anno d'intenso
lavoro, il 9 novembre del
1784 Mozart portò a
compimento la partitura del
Quartetto in si bemolle
maggiore K. 458, la
cui limpida costruzione
musicale paradossalmente
contrasta con le fatiche e
le difficoltà compositive
incontrate dal musicista
nella elaborazione
dell'opera. L'Allegro vivace
assai iniziale è introdotto
da un brioso e baldanzoso
motivo che ricorda il
richiamo di un corno (il che
ha determinato il soprannome
'La caccia', del resto poco
appropriato alla globalità
della composizione), poi il
movimento prosegue in
un'aura raffinata e gentile,
che assume un fascino
quietamente bucolico
soprattutto all'inizio della
sezione dello sviluppo. Con
l'intento di creare una
maggiore stabilità della
forma del quartetto, Mozart,
a più riprese, sperimentò
dei mutamenti nelle
dimensioni e nella
successione dei vari
movimenti. Nel Quartetto
K.458 il musicista
trasferì il Minuetto
(Moderato) dal terzo al
secondo posto, con un
procedimento già
precedentemente adottato ma
poi, dal 1785, quasi
completamente abbandonato,
dallo stesso Haydn. Al
contrario Mozart fece di
questa non comune
disposizione dei tempi una
costante e frequente
caratteristica compositiva
della sua musica
cameristica, non a caso
utilizzata in ben tre numeri
della serie di Quartetti
dedicati ad Haydn. La
tecnica è adottata dal
musicista spesso con
l'intento di separare
dall'Allegro di apertura un
tempo lento notevolmente
ampio, complesso e impegnato
con il conseguente
ottenimento di una più
equilibrata distribuzione
dell'energiaespressiva. In
questo brano Mozart
sovrappone con frequenza
un'interessante e irregolare
costruzione delle frasi a un
convenzionale periodo di 8
battute. L'originalità
affascina e circuisce
gentilmente l'ascoltatore,
ma rimane sempre in
superficie senza mai
intaccare i saldi principi
compositivi classici. Con il
successivo Adagio ci
trasferiamo in un'atmosfera
totalmente diversa, pervasa
da un mesto accoramento. Il
tempo è aperto da un
estatico tema in mi bemolle
maggiore che conduce,
attraverso un elegante e
sviluppato ricamo musicale
del violino, a un secondo
soggetto in si bemolle
maggiore, dove in una luce
sospesa, ma sentita, il
violoncello risponde
intensamente alle proposte
del violino. In questo
movimento non incontriamo la
sezione dello sviluppo e in
un gioco simmetrico di masse
sonore, minutamente
calibrate, il materiale
tematico è con naturalezza
riproposto nell'originale
ordine. Tocca quindi a una
concisa coda chiudere il
brano con vibrante emozione.
Come movimento finale
originariamente Mozart aveva
iniziato a comporre un tempo
nello stile di una Polacca.
Non soddisfatto dalle
fattezze che il pezzo stava
assumendo lo interruppe alla
sessantacinquesima battuta,
e iniziò a elaborare
l'Allegro assai che oggi
conclude il Quartetto.
Il brano con la sua
spigliata gaiezza si
ricollega quindi
ciclicamente all'Allegro
vivace assai di apertura.
QUARTETTO
PER ARCHI N. 19 IN DO
MAGG. K.465
“QUARTETTO
DELLE DISSONANZE'
Mozart
completò la stesura del Quartetto
in do maggiore K . 465
il 14 gennaio 1785 e il
quartetto fu eseguito per la
prima volta solo pochi
giorni dopo, assieme ad
altri due numeri del ciclo,
in casa Mozart, alla
presenza dello stesso Haydn.
Come riferisce Leopold
Mozart in una lettera del 16
febbraio 1785, Haydn ebbe a
dirgli in quella occasione:
«Io vi dico di fronte a Dio,
da uomo sincero, che vostro
figlio è il più grande
compositore ch'io conosca,
di nome e di persona. Ha
gusto e possiede al sommo
grado la scienza del
comporre».
All'opera fu successivamente
attribuito l'arbitrario
soprannome di “Quartetto
delle dissonanze”, a causa
delle ardite armonie
dell'introduzione lenta
(Adagio) che, secondo una
caratteristica compositiva
haydniana, anticipal'ascolto
del primo movimento. Sono
soltanto 22 battute, ma
furono sufficienti a far
parlare e scrivere di sé
generazioni di musicofili
più o meno sconcertati.
Leopold trovò il Quartetto
'composto in maniera
eccellente' e Haydn mai
dubitò delle ottime ragioni
artistiche che dovevano
sottostarealle scelte
musicali mozartiane. Ciò
nonostante nell'800 furono
proposte, anche da parte di
eminenti studiosi,
'opportune' correzioni atte
a smussare le battute più
ardite, soprattutto la
seconda e la sesta che, al
contrario, nella loro
durezza, ci sembra mettano
in luce, meglio di altre, lo
sforzo compositivo
mozartiano. Cosicché, è
interessante notare come gli
esperimenti compositivi di
Mozart, a volte anche
ambigui e inquietanti, come
in questo caso, pur nella
loro ricerca di maggiori
possibilità espressive, non
rinunciano mai alle solide
basi strutturali dell'arte
musicale classica. Il brano,
prosegue con un intenso
cromatismo che ha lo scopo
di creare un senso
d'instabilità e di attesa,
quasi un caotico magma da
cui scaturisce il successivo
Allegro. Senza dubbio il
linguaggio mozartiano rimane
anche qui estremamente
d'avanguardia per
l'ascoltatore settecentesco
(da notare l'equivalenza
delle voci dei quattro
strumenti), ma il meccanismo
sonoro, strutturato sui
principi della forma-sonata,
prosegue, fino all'elegante
chiusa in pianissimo, con
una limpidezza esemplare. Il
secondo tempo (Andante
cantabile) è svolto con
sentimento malinconico e
intimamente assorto. Poi,
verso la conclusione, il
violoncello apre a
sensazioni più drammatiche,
ma ugualmente rapite, che
presto si trasferiscono
anche nel canto degli altri
strumenti. Il finale del
movimento presenta
un'atmosfera alleggerita,
che va a chiudere con un
graduale sfumato. Il
tripartito Minuetto
(Allegretto), sulla spinta
degli haydniani Quartetti
opera 33, si avvicina
alle fattezze diuno Scherzo.
La prima sezione alterna
grazia e decisione, mentre
nel Trio mediano la musica
si inserisce ancora di più,
negandosi anche le ultime
inflessioni di danza. La
terza parte ripete la prima
ma in forma abbreviata.
Anche l'ampio e brioso
Finale (Allegro molto)
presenta un'interessante
alternanza di modi
espressivi che si
stabilizzano nella sezione
dello Sviluppo su toni
energici e concentrati.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|