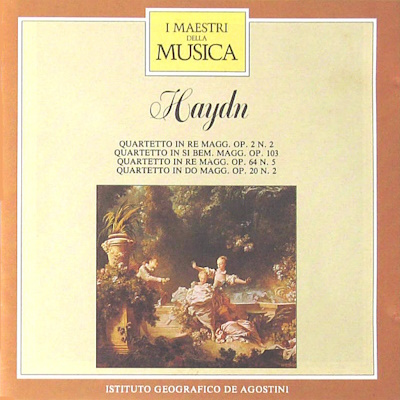 |
|
1 CD -
GMD 1/20 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franz Joseph
HAYDN (1732-1809)
|
Quartetto
per Chitarra e Archi in Re
maggiore, Op. 2 N. 2 |
|
18' 52" |
|
|
|
-
Allegro
|
2' 53" |
|
|
1 |
|
-
Adagio
|
8' 41" |
|
|
2
|
|
-
Minuetto
|
3' 25" |
|
|
3
|
|
-
Presto
|
3' 53" |
|
|
4 |
|
Quartetto
per Archi in Si bemolle maggiore,
Op. 103 |
|
11' 40" |
|
|
|
- Andante grazioso
|
5' 13" |
|
|
5
|
|
- Minuetto ma non
troppo presto
|
6' 27" |
|
|
6
|
|
Quartetto
per Archi in Re maggiore, Op. 64
N. 5
|
|
17' 15" |
|
|
|
- Allegro moderato
|
5' 31" |
|
|
7
|
|
- Adagio cantabile
|
5' 53" |
|
|
8 |
|
- Minuetto
(Allegretto)
|
3' 50" |
|
|
9 |
|
- Finale (Vivace)
|
2' 01" |
|
|
10 |
|
Quartetto
per Archi in Do maggiore, Op. 20
N. 2 |
|
22' 25" |
|
|
|
- Moderato |
7' 05" |
|
|
11 |
|
- Adagio |
7' 30" |
|
|
12 |
|
- Minuetto |
4' 00" |
|
|
13 |
|
- Fuga (Allegro)
|
3' 50" |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
Janacek Chamber
Orchestra / Vladimir Mikulka, chitarra
- (1-4)
|
"Husův sbor" Church in Slezská
,Ostrava - 29 October to 2 November 1979
|
Smetana Quartet
- (5-6)
|
(1963) |
Panocha Quartet
- (7-10)
|
Studio Domovina, Prague - 2 april
to 3 May 1974
|
Czech
Philharmonic Quartet - (11-14)
|
Studio Domovina, Prague - 17-21
Febraury & 24-26 March 1969 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1110 2700 | (p) 1960 - (1-4)
Supraphon | SUA ST 50535 | (p)
1964 - (5-6)
Supraphon | 1 11 1683 | (p) 1974
- (7-10)
Supraphon | 1 11 0829 | (p) 1970
- (11-14)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/20 | 1 CD -
durata 69' 53" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
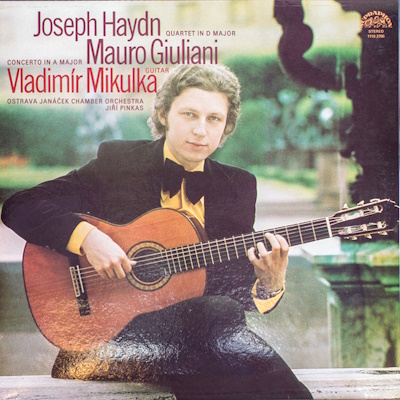
Haydn (1-4)
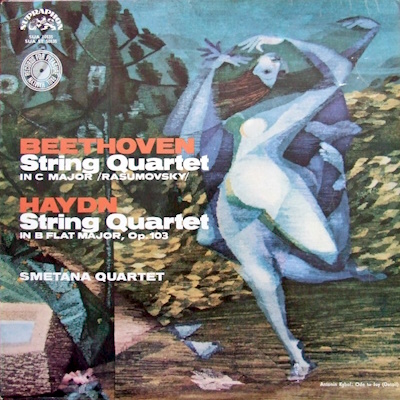
Haydn
(5-6)
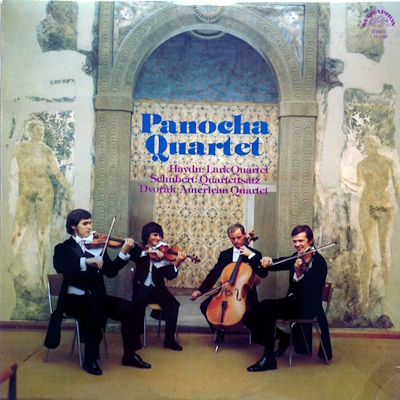
Haydn
(7-10)
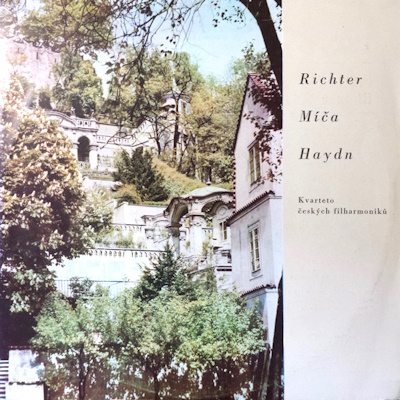
Haydn
(11-14)
|
4
QUARTETTI PER ARCHI
Nella
produzione musicale
haydniana, il settore
dedicato ai quartetti è
senz'altro quello che, con
il suo alto numero di
capolavori, esplica meglio
l'importante ruolo di
cardine portante svolto dal
compositore nel passaggio
dalla musica del Settecento
a quella dell'Ottocento. In
queste opere sono infatti
già espressi in maniera
decisa ed esemplare i
principi formali
(forma-sonata) e la nuova
sensibilità musicale che
saranno le decisive
fondamenta su cui sarà
eretta la grande
architettura compositiva
romantica. Non a caso,
mentre il genere della
Sinfonia e, soprattutto,
quello del Concerto
solistico dovranno attendere
l'iperbole creativa di
Mozart per assumere una
veste più completa, nel
Quartetto Haydn realizza un
organismo nuovo e già del
tutto compiuto nel suo
perfetto funzionamento. La
produzione quartettistica
importante, è sicuramente
attribuibile ad Haydn,
annovera circa 80
composizioni, quasisempre
riunite in raccolte di sei
numeri, e tutte pubblicate,
con enormesuccesso, vivente
l'autore.
I sei quartetti dell'Op.
2 furono probabilmente
composti da Haydn attorno al
1760, quindi prima del suo
passaggio al servizio degli
Esterházy, efanno parte
della sua primissima
produzione cameristica,
commissionatagli dal nobile
dilettante viennese C. J .
von Furnberg allo scopo di
allietarele serate estive.
Sono pezzi che non rientrano
ancora appieno nel genere
del Quartetto, avvicinandosi
piuttosto alla tipologia e
allo spirito del
Divertimento in cinque
movimenti. Le prime fonti
musicali di Haydn sono
barocche, spesso italiane
(Vivaldi); in effetti, in
queste opere, ancora prive
di un vero spirito
d'insieme, emerge una
vocazione virtuosistica
tipica della prima metà del
Settecento, che dona un
ruolo di spicco al primo
violino, relegando gli altri
strumenti alla sola funzione
di sostegno armonico e di
accompagnamento. Non ci pare
del tutto fuori luogo
intravedere in trasparenza
in questa struttura formale
il modello della Sonata
barocca, nel quale,
all'occorrenza, si potevano
moltiplicare gli esecutori,
proponendo così, almeno
fonicamente, delle sembianze
affini a quelle della
Sinfonia e del Concerto. Qui
viene presentato il secondo
numero della raccolta, in
unaversione in re maggiore
in quattro tempi che
utilizza una chitarra nel
ruolo di primo violino e
amplifica numericamente i
restanti strumenti fino al
livello di un'orchestra
d'archi da camera. Spicca
nel taglio strutturale della
composizione l'ampiezza di
cui è dotato il dolce
Adagio, molto barocco nella
sovrapposizione a fasce
della parte della chitarra,
che ha modo di liberare il
proprio virtuosismo in due
improvvisate cadenze, e
della sezione degli archi,
impegnati in lunghe note di
solo accompagnamento.
Dopo le prove giovanili, e
dopo quasi dieci anni di
silenzio, Haydn torna
decisamente al genere del
Quartetto, negli anni che
vanno dal 1768 al 1772, con
la stesura di tre raccolte
di sei numeri ciascuna: l'Op.
9, l'Op. 17 e
l'Op. 20. In queste
composizioni, alle quali non
deve essere stato
indifferente l'esempio
cameristico di Boccherini,
incontriamo già il tipico
modello haydniano di
Quartetto, definito e
stabilizzato nella forma,
dilatato e irrobustito nella
struttura, solidamente
suddiviso in quattro
monolitiche parti, già
dotato della caratteristica
scrittura dialogante. In
particolar modo, i quartetti
dell'Op. 20,
elaborati nel 1772 e
comunemente denominati 'Sonnenquartette'
(Quartetti del sole), sono
quelli che mostrano la
maggiore concentrazione
espressiva, all'interno di
una migliore articolazione
stilistica del fraseggio,
perennemente pervasa da una
costante ricerca ed
elaborazione di sentimenti
ed emozioni, in aderenza con
i dettami psicologici dello
'Sturm und Drang'.
Interessante è anche la
volontà di recupero
dell'antica arte
dell'organizzare la forma
attraverso 1'utilizzo del
contrappunto. Il Quartetto
n. 2 inizia con un
Moderato che si apre su
registri acuti e nel quale,
ancora una volta, è affidato
al primo violino un ruolo
privilegiato. L'Adagio che
segue, dalla struttura
libera, è il culmine e il
vero cuore dell'intera
composizione. Presenta
all'inizio un'introduzione
estremamente drammatica e
carica di tensione,
interamente giocata su toni
gravi e decisi, che serve
all'ascoltatore per
sintonizzarsi sul livello
emotivo, intensamente
appassionato, del discorso.
A questo punto, è affidato
al violoncello un canto
sconsolato,
sull'accompagnamento
ribattuto e ripetitivo degli
altri strumenti. I quattro
archi finiscono quindi per
unirsi e per sviluppare in
successione un più complesso
fraseggio, sempre
stabilizzato su toni severi,
che prosegue tra forti
contrasti, chiaro-scuri e
varietà di modi, e che, in
alcuni frangenti, permette
al violino di esprimere
un'acuta cantabilità. Anche
il successivo Minuetto
presenta un'oscura
ombreggiatura, ora però
munita di riflessi danzanti.
La sezione intermedia,
introdotta dal violoncello,
ha caratteristiche di
maggiore cantabilità,
nostalgica e cadenzata. Come
altri due numeri dell'Op.
20, anche questo
Quartetto è concluso da una
espressiva Fuga (Allegro) a
più soggetti, che si
mantiene ancora su registri
caratterizzati da un forte
sentire.
I sei quartetti dell'Op.
64 ci conducono
all'ultimo periodo della
produzione di Haydn. Furono
composti nel 1790, l'ultimo
anno passato dal musicista
al servizio degli Esterházy.
Nello stile cameristico del
compositore è già avvenuta
quella grande innovazione
proposta con i Quartettí
russi op. 33,
innovazione che consiste
nell'abbandono del tono
intensamente appassionato
per una scrittura più
leggera e brillante ma,
soprattutto, nella scoperta
e nella proposta,
all'interno dello sviluppo
della forma-sonata, di
un'ampia e articolata
elaborazione tematica. Il
Quartetto, nelle mani di
Haydn, si è ormai risolto in
un'armonica unità, dominata
da un perfetto equilibrio
classico nel quale la
forma-sonata ha trovato una
precisa e definitiva
calibratura; in esso spicca
inoltre la maggiore
innovazione di Haydnnel
campo della scrittura
quartettistica, cioè
quell'aria di conversazione
improntata sulla singola
autonomia e sull'equilibrio
paritetico di tutti gli
strumenti. Questa tecnica,
che permette al musicista la
'rappresentazione' di un
dialogo fatto di scontri e
incontri tra diverse
personalità psicologiche, si
rifà con realismo al vissuto
emotivo, ponendosi così,
grazie anche all'implicita
carica narrativa insita
nella forma-sonata, come la
più solida controparte
musicale della nascita del
moderno romanzo
ottocentesco. Haydn è ormai
riuscito in una delle
imprese più rappresentative
della ricerca compositiva
del classicismo viennese,
cioè nel superamento dei
generi legati a precise
situazioni della vita di
corte e nella proposta di un
nuovo linguaggio sensibile
per l'intera umanità,
proposta che avrà la sua
apoteosi finale nell'Inno
alla Gioia' beethoveniano.
Musica quindi per tutti,
raffinata e popolare
assieme, in un perfetto
amalgama tra complessi
rapporti formali e
immediatezza musicale, con
un inconsapevole ma
significativo richiamo ai
principi artistici del
Classicismo figurativo
rinascimentale, che vedeva
nel concetto di “grazia” la
risoluzione del problema di
una rappresentazione facile
e naturale di un complesso
microcosmo armonico e
proporzionale. Ed è proprio
questa magica mistura a
darci una valida ragione
dell'enorme glorificazione
pubblica che accompagnerà
gli ultimi anni di vita di
Haydn.
Il Quartetto n. 5
dell'Op. 64,
denominato 'Lerchenquartett'
(Quartetto dell'allodola)
spicca per la robustezza
architettonica e per
la trasparenza
formale. Il linguaggio è
semplice ma nel contempo
incisivo, la sonorità aperta
e del tutto nuova. Il primo
tempo è un Allegro moderato,
caratterizzato da una doppia
ripresa della melodia
principale, un solo del
primo violino molto acuto,
il cui ingresso è preparato
con raffinatezza da una
successione di disegni
staccati del secondo violino
e della viola a cui risponde
il violoncello. Il brano
prosegue con una musicalità
graziosa e leggera, ma
sempre concisa ed essenziale
nell'esposizione. Il
successivo Adagio cantabile
si propone come un'oasi di
meditazione. Interessante è
osservare come Haydn, anche
in questo caso, si preoccupi
di controllare l'espansione
melodica, asimmetrica e
libera ma sempre comunque
regolata nel periodo
musicale. Il Minuetto
(Allegretto) è plasmato su
un'ironica articolazione che
fa capo alla tipica
ispirazione popolare
haydniana. Nel Finale
(Vivace) incontriamo quel
gusto barocco per una
tecnica compositiva
virtuosística e per una
esecuzione tirata fino allo
spasimo. E ancora di più
riconduce all'età barocca
quell'impressione di moto
perpetuo che informa
l'intero brano. Ma qui, al
contrario, vive l'interesse
classico per la varietà
ritmica, che dona alle
singole frasi una propria e
chiara articolazione.
Nel 1794, al termine del suo
secondo soggiorno inglese,
Haydn tornò in patria e,
ormai famosissimo, riprese a
soddisfare, nel ruolo di Kapelmeister,
le commissioni musicali
della famiglia Esterházy. La
vecchiaia e le fatiche
compositive avevano tuttavia
logorato il suo fisico. Nel
1802 il musicista iniziò un
nuovo quartetto, 1'Op.
103, che non riuscirà
a portare a termine. Nel
1803 concluse il secondo e
il terzo tempo ma, invece di
continuare la stesura,
appose sulla partitura la
seguente frase: «Perduta è
la mia forza: io sono
vecchio e debole». L'Op.
103, pubblicata per la
prima volta a Lipsia nel
1806, è il congedo dalla
musica di Haydn ed è
separato dal primo quartetto
qui presentato da ben
quarant'anni di intensa
attività. L'Andante grazioso
si sviluppa in un'aura di
grazia e delicatezza, già
pienamente romantica e
pervasa da un accorato ma
sereno sentire. Affascinante
l'alternanza tra due
situazioni musicali, una
dolce e quasi danzante, e
una caratterizzata da un più
deciso interloquire. Il
Minuetto ma non troppo
presto, al contrario, è
privo di ogni reminiscenza
di danza, per proporsi
invececon maggior seriosità
su un registro di già
avanzata e ottocentesca
introspezione. Soltanto la
sezione mediana presenta una
certa affettuosa
cantabilità, nella quale
emergono brevi note in punta
di piedi e suggestivi
rallentamenti, che
riconducono a
stilízzatissimi gesti di
danza. Dopo queste note,
nessun'altra musica uscirà
dalla penna di Haydn.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|