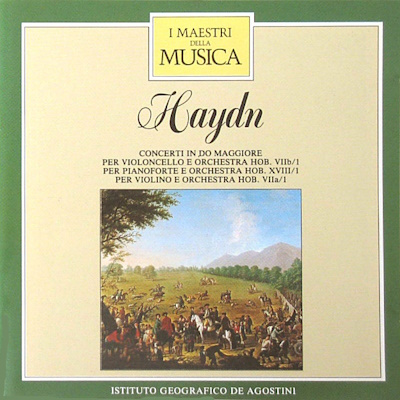 |
|
1 CD -
GMD 1/18 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franz Joseph
HAYDN (1732-1809)
|
Concerto
per Violoncello e Orchestra in Do
maggiore, Hob. VIIb/1 |
|
23' 37" |
|
|
|
-
Moderato
|
9' 29" |
|
|
1 |
|
-
Adagio
|
7' 23" |
|
|
2
|
|
-
Allegro molto
|
6' 55" |
|
|
3
|
|
Concerto
per Pianoforte e Orchestra in Do
Maggiore, Hob. XVIII/1 |
|
18' 37" |
|
|
|
-
Moderato |
8' 12" |
|
|
4
|
|
-
Largo |
7' 15" |
|
|
5
|
|
-
Allegro molto |
3' 10" |
|
|
6
|
|
Concerto
per Violino e Orchestra in Do
maggiore, Hob. VIIa/1 |
|
18' 26" |
|
|
|
- Allegro moderato
|
9' 31" |
|
|
7
|
|
- Adagio
|
4' 44" |
|
|
8
|
|
- Finale
|
4' 11" |
|
|
9
|
|
|
|
|
|
| Prague Symphony
Orchestra / Milos Sadlo, Violoncello
/ Alois Klima, Direttore - (1-3) |
Prague - 1961
|
| Virtuosi
Pragensis / Valentina Kamenikova, Pianoforte
/ Libor Hlavacek, Direttore - (4-6) |
Studio Domovina, Prague -
February, May & September 1974 |
| Prague Chamber
Orchestra / Bohuslav Matousek, Violino
/ Libor Hlavacek, Direttore - (7-9) |
Studio Supraphon,
Prague - 1971 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| SUA ST 50495 | (p) 1964 |
(1-3)
Supraphon | 1 10 1861/2 | (p)
1975 | (4-6)
Supraphon | 1 10 1175 | (p) 1971
| (7-9)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/18 | 1 CD -
durata 61' 32" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
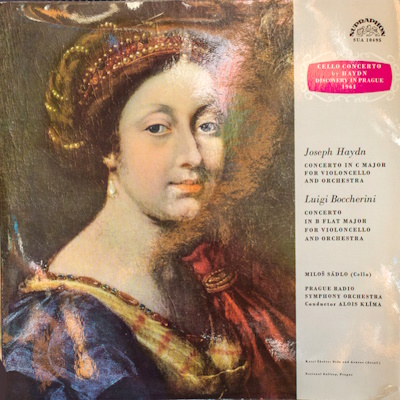
Haydn (1-3)

Haydn (4-6)
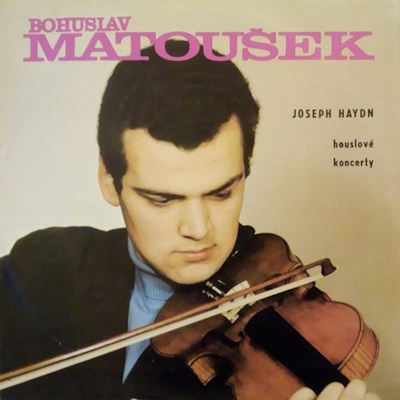
Haydn (7-9)
|
3
CONCERTI SOLISTICI IN DO
MAGGIORE
Nell'esteso
catalogo della produzione
musicale di Franz Joseph
Haydn il settore delle opere
concertistiche comprende,
all'incirca, una trentina di
numeri, la maggior parte dei
quali dedicata a un solo
strumento solista. La loro
identificazione è il
risultato di una paziente
ricerca musicologica
protrattasi per lunghi anni
sui fondi manoscritti delle
biblioteche di Vienna, di
Budapest ei di Praga, nonche
nelle biblioteche private
delle casate nobiliari per
le quali Haydn compose
musica. A tal fine si è
rivelato di indispensabile
utilità il costante ricorso
alle indicazioni del
catalogo completo delle
proprie opere, steso, fra il
l760 eil 1770, dal
compositore stesso. È questo
il cosiddetto catalogo
autografo Entwurf che, come
frequentemente accadeva nel
Settecento agli autori
particolarmente fecondi,
Haydn aveva elaborato sia
per ordinare le opere
composte (e in parte
stampate) fino ad allora sia
per controbattere le
numerose trascrizioni, se
non addirittura i falsi, che
incominciavano ad apparire
sul mercato editoriale.
Nello sviluppo dell'intera
musica colta occidentale,
Haydn svolse, come è ben
noto, un ruolo decisivo. Di
primaria importanza fu il
suo apporto alle
trasformazioni artistiche
che accompagnarono il
passaggio al XIX secolo e al
Romanticismo, che di
quell'età fu il sapiente
infuso culturale. Tra il
Settecento e l'Ottocento,
l'influsso e il modello del
compositore austriaco
operarono in maniera più
estesa e approfondita
rispetto all'esempio dello
stesso Mozart, la cui
personalissima opera subì
una diffusione lenta e
disordinata. Non a caso,
Haydn è da considerarsi come
Partefice della maniera
pre-mozartiana più matura di
quei generi strumentali
(Sonata, Quartetto,
Sinfonia) che saranno
cardinali per la produzione
musicale dell'Ottocento e
della forma compositiva (la
forma-sonata) che ne sarà
contemporaneamente materia
prima ed essenza più
profonda. Al contrario, il
genere concertante fu poco
praticato da Haydn, e
prevalentemente nei primi
anni di servizio presso gli
Esterházy. La tipologia
musicale del Concerto dovrà
così attendere l'iperbole
creativa di Mozart per avere
del tutto definite le
proprie linee fondamentali e
per vedere avviato il suo
rapido sviluppo compositivo.
Haydn trattò il concerto
solistico in una serie di
opere di circostanza, spesso
per assecondare le
caratteristiche esecutive
degli interpreti a cui erano
destinate. In pratica, il
compositore, oltre a non
suonare da virtuoso nessuno
strumento, non era attratto
da un modello musicale
brillante e spettacolarmente
esibizionistico; il suo
interesse era rivolto alla
costruzione di pure
architetture musicali
(secondo una notevole
varietà di soluzioni
formali), alla calibratura
di perfetti equilibri
classici, all'esplorazione e
alla definizione ultima
delle regole della
forma-sonata, non ancora
pronta, secondo Haydn, a
confrontarsi e realizzarsi
nel più libero e narrativo
colloquio tra solista e
orchestra. I concerti
haydniani mantengono
comunque importanza nel loro
esprimere un evidente sforzo
di proposta di un prototipo
concertistico di trapasso,
un trapasso che si andava
realizzando a più livelli
interagenti: la ricerca
tecnologica conduceva alla
mutazione di alcune
caratteristiche costruttive,
e di conseguenza sonore, di
alcuni strumenti musicali;
questi non erano altro che i
nuovi attrezzi di lavoro
indispensabili per
realizzare ed esprimere,
attraverso nuove forme,
differenti contenuti ed
emozioni, in sintonia con il
recente sentire.
Il ventennio 1750-70
rappresentò per Haydn un
periodo di progressiva
maturazione sul terreno
dello stile barocco e
galante. In particolare, dal
1761, il musicista, al
servizio della nobile e
militaresca famiglia
ungherese degli Esterházy,
passava la maggior parte del
suo tempo nella superba
residenza di Esterháza,
dotata tra l'altro di una
cappella, saloni per i
concerti solenni, sale per
musica da camera, un teatro
d'opera di 500 posti e un
teatrino per marionette,
decorato di conchiglie e
pietre colorate, per il
quale erano anche ridotte
vere composizioni
operistiche. Si capisce
quindi come il consumo
musicale fosse altissimo e
quanto Haydn fosse impegnato
a soddisfare con musica
strumentale e vocale le
commissioni dei suoi
signori. La stesura del Concerto
in do maggiore per
violoncello Hob.
Vllb/1 è da collocare
all'incirca tra il 1761 e il
1765. La partitura è stata
scoperta da Oldrich Pukert
nella Collezione Radenin del
Museo Nazionale di Praga. Il
manoscritto non riporta il
nome dell'autore, che però
compare nella parte staccata
del basso. Con probabilità,
la composizione fu dedicata
da Haydn all'amico
violoncellista Joseph Weigl,
che fece parte
dell'orchestra degli
Esterházy dal 1761 al 1769.
Il Concerto presenta
già una notevole maturità
compositiva; in particolar
modo, la scrittura del
solista, molto ardua, è
testimone dell'ottimo
livello tecnico-esecutivo
degli orchestrali a
disposizione dei signori
ungheresi. Nel primo
movimento (Moderato)
incontriamo due temi ben
distinti e caratterizzati
secondo la successiva
maniera ottocentesca:
energico il primo; patetico
e affettuoso il secondo. ll
solista riprende e
arricchisce il materiale
tematico esposto
dall'orchestra aprendo nuovi
orizzonti musicali. L'Adagio
è introdotto da una melodia
fortemente cantabile ed
emozionata, ingentilita
ulteriormente dalla parte
del violoncello. Nel terzo e
conclusivo tempo (Allegro
molto) riscontriamo un
procedere scattante e pieno
di energia, caratterizzato
da una certa immediatezza e
rusticità d'immagine, in
aderenza con un principio
formale che diverrà ancora
più accentuato ed evidente
negli ultimi tempi delle
successive composizioni
strumentali di Haydn.
Gli undici concerti per
strumento a tastiera e
orchestra di Haydn ci
conducono al centro di una
delle più importanti
metamorfosi della storia
musicale dell'Occidente. Ci
troviamo infatti nel mezzo
di quel lento passaggio che
porta dall'ancora
settecentesco concerto
solistico per organo o
clavicembalo, lo strumento
principe dell'età barocca, a
quello per fortepiano e
successivamente per
pianoforte, lo strumento che
diverrà principe nel
Romanticismo ottocentesco.
Non a caso abbiamo parlato
genericamente di concerti
per tastiere, dato che
queste composizioni di Haydn
hanno spesso doppie e
diverse destinazioni, che
coincidono con le varie fasi
del passaggio di consegne:
le prime sono dedicate
all'organo e al
clavicembalo, mentre le
successive al clavicembalo e
al fortepiano, uno strumento
questo che, sia nella forma
sia nelle sue capacità
sonore e nella scioltezza di
diteggiatura, preannunciava
il pianoforte. Il passaggio,
che non dimentichiamo è
anche formale e coinvolge i
principi del prossimo e
fortunatissimo concerto
romantico, rimane in parte
sfuggente, anche a causa
della concezione esecutiva
settecentesca. Assai
elastica e libera ma non
casuale, essa prevedeva
diverse letture dell'opera,
già però potenzialmente
preordinate nella partitura
stessa e da svolgersi
comunque sempre secondo i
dettami estetico-musicali
del tempo (come ad esempio
quando erano coinvolti dei
mirabolanti fortepiano
dotati di sonagliere e
campanelli, che bene si
adattavano soprattutto per
l'esecuzione, più magica che
esotica, di musiche 'alla
turca'). Il Concerto in
do maggiore per organo o
clavicembalo Hob.
XVIII/ 1 è qui presentato in
un'esecuzione che utilizza
come strumento solista un
pianoforte. La composizione
fu eseguita per la prima
volta il 12 maggio 1756, in
occasione dell'ingresso in
convento di Therese Keller,
primo amore del compositore
e sorella della sua futura
moglie. La stesura,
probabilmente dello stesso
anno, rientra nel periodo in
cui il poco più che ventenne
musicista si confrontava con
le sue prime, impegnate
esperienze compositive. Non
ci è pervenuto il
manoscritto originale del Concerto
e, ancor oggi, si discute
se, nell'organico
strumentale, debba rientrare
anche una coppia di trombe.
Il Moderato iniziale si
esprime in un`aura ancora
galante e rococò, con una
linea musicale sinuosa ed
elegante, nella quale
ricorrenti e raffinati
trilli rimandano alla tipica
scrittura clavicembalistica.
Il Largo successivo assume
un andamento placido e senza
strappi, ricco di una docile
gestualità; come alcuni
tempi centrali di concerti
haydniani, è inoltre dotato
di una breve cadenza in
stile improvvisativo.
L'Allegro molto, da parte
sua, concede ancora più
spazio alla vigorosa
brillantezza del pianoforte,
mentre sono particolarmente
interessanti i concisi ma
assai rudi interventi
dell'orchestra.
Con il Concerto in do
maggiore per violino
Hob. VIIa/l torniamo ai
primi anni trascorsi da
Haydn alla corte degli
Esterházy. L'autografo
riporta l'indicazionc “fatto
per il Luigi”. Il
personaggio in questione non
è altro che il violinista
Luigi Tomasini, che era al
servizio degli Esterházy sin
dal 1757 con lc mansioni di
valletto. Con il permesso
dei suoi signori si era
.successivamente recato a
Venezia per perfezionarsi
nella tecnica del suo
strumento e, dopo il suo
ritorno, nel 1761 era
divenuto primo violino
nell'orchestra della
famiglia ungherese. Fu lo
stesso violinista a
richiedere ad Haydn un
concerto che potesse
valorizzare le sue qualità
esecutive. La stesura
dell'opera è da far risalire
all'incirca agli anni che
precedono il 1769, e in
effetti la parte del violino
lascia emergere la buona
preparazione tecnica del
Tomasini e, soprattutto nel
saldo linguaggio dei due
movimenti estremi, alcuni
caratteri specificatamente
haydniani. L'Allegro
moderato è un tipico e
spettacolare movimento
d'apertura. Il solista si
esibisce in tre episodi nei
quali ci offre un notevole
virtuosismo, soprattutto
rivolto al registro acuto.
Al termine, dopo una
transizione tonale
dell'orchestra, il violino
presenta una pirotecnica
cadenza, pervasa da quel
gusto immaginifico per la
sorpresa tipico di Haydn.
L'Adagio è risolto in una
struttura ancora barocca, ma
non per questo meno
affascinante. Dopo una breve
e ascendente sezione
d'apertura, introdotta dal
violino, è ancora il solista
ad affrontare una dolce
cantilena sul suggestivo
pizzicato degli archi.
Conclude il concerto un
Finale (Presto) solare ed
espansivo, che curiosamente
assume ancora in alcuni
frangenti un tono
schiettamente energico.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|