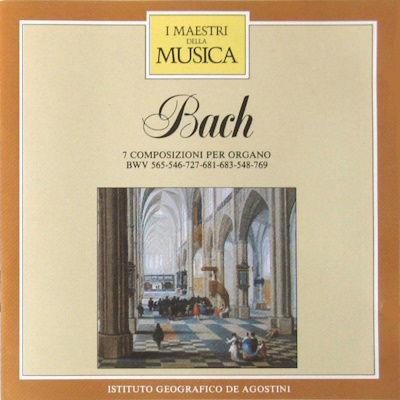 |
|
1 CD -
GMD 1/16 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Johann
Sebastian BACH (1685-1750)
|
Toccata
e Fuga in Re minore, BWV 565 |
|
8' 44" |
|
1 |
|
Preludio
e Fuga in Do minore, BWV 546
|
|
13' 53" |
|
2 |
|
Corale
"Erzlich tut mich verlangen", BWV
727
|
|
2' 38" |
|
3
|
|
Preludio
e Fuga in Mi minore, BWV 548
|
|
13' 22" |
|
4
|
|
Corale e
Fughetta su "Wir Glauben all'an
einen Gott", BWV 681 |
|
2' 41" |
|
5
|
|
Corale
"Vater unser im Himmelreich",
BWV 683
|
|
2' 20" |
|
6
|
|
Variazioni
canoniche sul Corale Natalizio
"Vom Himmel hoch, da Komm' ich
her", BWV 769
|
|
13' 55" |
|
7
|
|
|
|
|
|
| Jiri Reinberger,
Organo |
Michaelis-Kirche,
Zwolle (Holland) - 10-15 July 1962
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| SUA 10490 | (p) 1963 | (1,7)
Supraphon | SUA 10489 | (p) 1963
| (2-6)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/16 | 1 CD -
durata 58' 35" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
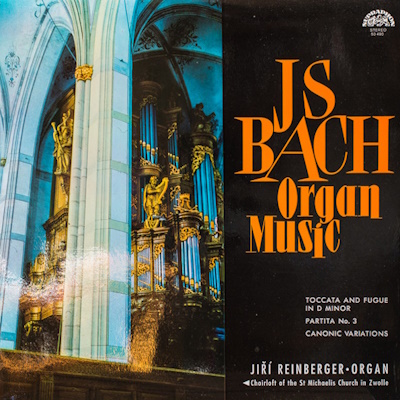
Bach (1,7)
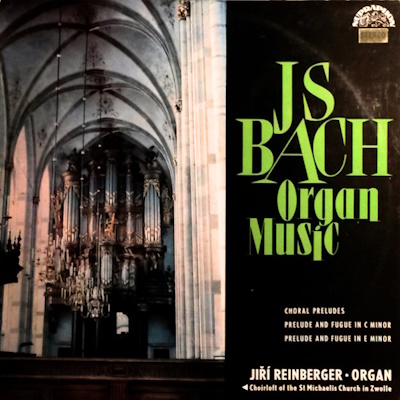
Bach (2-6)
|
7
COMPOSIZIONI PER ORGANO
Per Bach
l'esperienza organistica fu
un prediletto diario di
lavoro, un'occasione di
studio e di preghiera, di
intimo colloquio e di
ricerca spirituale;
un'esperienza che accompagnò
l'intero itinerariocreativo
attraverso lo svolgimento di
circa 250 opere, di cui un
centinaio “libere”, ossia
non liturgiche. L'insieme è
di difficilissimo
ordinamento crònologico, a
causa soprattutto delle
lacune storico-biografiche
relative al musicista, la
cui opera, audacemente
antica e d'avanguardia al
medesimo tempo, fu, vivente
l'autore e per molti anni
ancora, conosciuta e
ascoltata da pochi;
cosicché, oggi si è soliti
suddividerla in relazione ai
luoghi ove egli visse e
operò. Ancora più incerti e
oscuri sono per noi gli anni
di formazione artistica e di
prima attività, che Bach
essenzialmente trascorse con
il ruolo di organista in
chiese luterane di diverse
città. Sin dalle prime
opere, l'autore rivela una
personalissima inclinazione
alla diversità, al
cosmopolitismo, che lo
condusse a mettere alla
prova, attraverso una
ricerca continua di
perfezione e un avido
bisogno di nuove esperienze
e stimoli, diversi stili e
svariate forme musicali.
Benché la già matura
padronanza del mezzo
organistico ci confonda, la
celebre Toccata e fuga
in re minore BWV 565 è
un prodotto di questi primi
anni. Bach la compose prima
del 1708, probabilmente a
Mühlhausen se non
addirittura ad Arnstadt. La
composizione ci mostra
l'idea che Bach si era fatto
del caratteredell'organo,
patetico e sovrannaturale,
potente e sensibile,
ricchissimo di colori; ma ci
illustra anche come il
musicista concepisse la
virtuosità: una serie di
figure armoniche
arditissime, una dinamica
animata, modulazioni e
accenti appassionati, che,
come alcune fonti riportano,
sconcertavano la comunità
dei fedeli della parrocchia
di Arnstadt. Ancora oggi il
brano colpisce per la forza
emotiva impetuosa, lo
slancio audace, il
virtuosismo. La forma è
ottenuta di forza,
attraverso il vigore
gestuale, piuttosto che
attraverso una struttura di
combinazioni
contrappuntistiche, che, con
la mirabolante tecnica
musicale di far nascere la
composizione dall'esaustivo
utilizzo di tutte le
possibilità insite nel tema
stesso, si sarebbe
sviluppata con le opere a
venire. L'originale forma
della toccata per strumento
a tastiera è dotata di un
carattere d'improvvisazione,
di un brillante ed
esibizionistico virtuosismo.
Qui la sua tipica alternanza
di episodi figurativi e
fugati è ridotta a una
tripartizione, dove un'ampia
fuga è incorniciata da due
sezioni figurative. La prima
di esse è dotata di un tono
trionfante. All'esposizione
del famoso tema seguono
rapidi disegni ascendenti e
discendenti, che sfociano in
un maestoso finale. Con
lapidari blocchi di accordi
e un veloce pedale, esso
introduce al clima della
fuga, dallo spirito molto
simile a quanto già
ascoltato. La struttura è
dotata di uno sviluppo
libero e fantasioso,
singolarmente composto da
una serie di episodi. La
terza e ultima sezione
ripete lo stile della
toccata d'apertura, con i
medesimi mezzi figurativi e
accordali, ancor più
intensificati.
Nel 1708 inizia il secondo
soggiorno di Bach a Weimar.
Qui il musicista svolgerà le
funzioni di organista di
corte e, successivamente, di
Konzertmeister. Sulla
spinta delle commissioni del
principe regnante, il duca
Guglielmo Ernesto di
Sassonia-Weimar, alla
sintesi di tutte le
precedenti esperienze si
aggiunse l'influenza della
scrittura concertante
italiana. Il Preludio e
fuga in do minore BWV
546 è testimonianza di come
a Weimar si forgi
l'originale linguaggio
organistico maturo di Bach.
Non a caso, la maggior parte
della produzione del
compositore per questo
strumento è concentrata in
tale periodo. La
composizione è tra i testi
bachiani più importanti e,
nella sua grandiosa e
suggestiva struttura
musicale, rivela
l'affermazione, nel campo
delle opere libere per
organo, di una più chiara
ripartizione a contrasto in
preludio e fuga.
Già nel Seicento, il corale
luterano (canto liturgico
affermatosi con la Riforma
con lo scopo di avvicinare e
rendere partecipi le masse
dei fedeli) divenne punto di
partenza per l'elaborazione
di corali organistici che
utilizzavano le melodie
luterane, spesso di origine
profana e popolare, dotate
di testi in volgare. Bach
compose circa 170 corali per
organo. Questi presentano
una vasta gamma di tipi
formali, che possono
oscillare da composizioni
molto semplici fino a brani
complessi e difficili, per
trasformarsi a volte
addirittura in una serie di
variazioni. Il Corale
'Herzlich tut mich
verlangen' BWV 727,
composto da Bach negli anni
di Weimar, è esempio di come
il compositore, sulle tracce
di Sweelinck e dei
successivi Pachelbel e
Buxtehude, prosegua lo
sviluppo di tale genere
musicale, donandogli un
perfetto impianto
stilistico. Affascinante e
abilissima è la maniera con
cui Bach adatta le forme
musicali e i mezzi tecnici
al significato spirituale
insito nel testo.
Dopo il “profano” soggiorno
di Köthen, nel 1723 Bach si
trasferì a Lipsia,grande
città luterana di intensa
attività religiosa e
musicale, dove avrebbe
lavorato fino alla morte. In
quegli anni, il compositore
riprese con decisione a
scrivere per l”organo e si
preoccupò di stendere nuove
versioni e di sistemare in
cicli unitari, destinati
alla pubblicazione, opere
precedentemente elaborate.
La composizione del Preludio
e fuga in mi minore
BWV 548 è da far risalire
agli anni 1727-31 circa. Il
brano prosegue il decorso
strutturale che, in
parallelo ai corali, conduce
le composizioni organistiche
libere da una forma
articolata in più parti a
un'architettura unitaria.
L'opera è una delle poche
libere per organo di Bach
delle quali si abbia la
copia autografa. Il preludio
possiede un impianto
grandioso nel quale è
lontana qualsiasi proposta
d'improvvisazione, mentre,
in aderenza col tardo stile
bachiano, riscontriamo la
tendenza a una razionale
elaborazione della polifonia
e all'impiego di un severo,
ma sempre ingegnoso,
contrappunto. La fuga,
purtroppo, s'interrompe alla
ventesima battuta ed è stata
successivamente completata
grazie a frammenti e abbozzi
autografi. L'impianto
comunque è diverso e
strutturato in tre sezioni
che, pur presentando
difficoltà tecniche
rilevanti, mantengono un
andamento libero.
Il terzo dei quattro libri
che compongono la raccolta
bachiana del Klavier
Übung è dedicato alla
presentazione di una serie
di corali organistici, tutti
composti entro il 1739. La
successione si apre con un
grande preludio, a cui
seguono i 21 corali.
Incontriamo quindi 4 duetti,
destinati con tutta
probabilità al clavicembalo.
A conclusione, è posta una
vasta fuga. L'insieme mira a
un arricchimento
tecnico-manuale e
contemporaneamente
spirituale. La fonte è da
ricercarsi nei due
catechismi luterani: il
piccolo, destinato alla
massa dei fedeli, e il
grande, destinato alle
persone colte. Ugualmente, i
corali, che propongono
un'intima meditazione sui
temi principali dei
catechismi, oltre a disporsi
nell'ordine della messa
luterana, si suddividono in
due serie ordinate a coppie.
I grandi corali sono
complesse e austere
elaborazioni polifoniche.
Ognuno di essi è seguito da
un piccolo corale che
riprende, in pagine più
brevi, il tema appena
esposto. Sono brani che non
richiedono l'uso della
pedaliera e che quindi, in
aderenza alla destinazione
luterana, possono essere
eseguiti anche su un piccolo
organo da casa o su
qualsiasi strumento a
tastiera. Questi pezzi
possono avere fisionomie
diverse: alcuni sono
fughette, altri semplici
elaborazioni
contrappuntistiche. I due
piccoli corali qui
presentati affrontano due
fondamentali tematiche:
l'atto di fede (Fughetta
su 'Wir glauben all'an
einen Gott' BWV 681) e
il Pater Noster ('Vater
unser im Himmelreich'
BWV 683). L'ascolto
evidenzia una ricerca di
semplificazione, che si
risolve in una rinuncia a
ogni estetismo e facilità di
comunicazione per far perno
su un assoluto rigore
contrappuntistico e su una
severa disciplina
spirituale.
Con le Variazioni
canoniche BWV 769
giungiamo all'ultima tappa
dell'itinerario artistico di
Bach, da noi qui ripercorso
attraverso il filo
conduttore delle opere per
organo. La ricerca musicale
bachiana dell'ultimo
decennio presenta una
radicalizzazione della
tendenza all'evidenziamento
dell'aspetto
scientifico-matematico,
fortemente cerebrale, della
musica. Nascono sotto questo
segno le ultime vertiginose
e problematiche opere,
potentemente astratte e
speculative, di decisa
ricerca teorica; brani che,
pur procedendo a ritroso nel
recupero e nello studio
della grande e antica
tradizione polifonica
medievale e rinascimentale,
squarciano inquietanti
vortici prospettici verso
orizzonti e possibilità
musicali inaspettati e che
non fecero altro che isolare
ancora di più Bach da
un'epoca che si stava
sperisieratamente avviando a
un gusto galante. Le Variazioni
furono presentate da Bach
nel 1747 come saggio
d'ammissione alla Sozietat
der musikalischen
Wissenschaften,
un'associazione che
promuoveva le ricerche
scientifiche sulla musica.
La composizione,
travagliatissima nella
stesura, presenta la melodia
del corale natalizio 'Vom
Himmel hoch, da komm 'ich
her', che diventa puro
pretesto per lo svolgimento
di cinque variazioni. Come
nell'Arte della fuga,
anche in questo caso Bach
sembra disinteressarsi al
fruimento fonico,
all'utilizzazione pratica,
per proporre delle pagine
essenzialmente dedicate alla
lettura, allo studio.
L'interesse, il senso più
profondo, è da ricercarsi
nella volontà di ottenere,
attraverso un'eccelsa
tecnica contrappuntistica,
una realizzazione astratta e
sapienziale. Questa mira,
passando per un'iniziazione
intellettuale, artistica e
scientifica, per la quale
sono indispensabili capacità
di autocontrollo e
disciplina, ascetismo e
capacità di contemplazione,
alla conquista di una mente
superiore, al raggiungimento
di una serena sapienza
onnicomprensiva, che
eroicamente sfida le
visibili ma sempre sfuggenti
leggi armoniche
dell'universo.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|