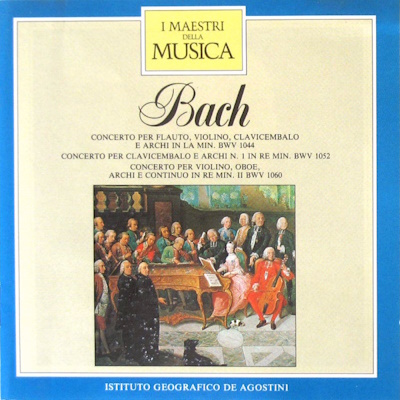 |
|
1 CD -
GMD 1/13 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Johann
Sebastian BACH (1685-1750)
|
Ouverture
N. 1 in Do maggiore, BWV 1066 |
|
24' 25" |
|
|
|
-
Ouverture
|
11' 09" |
|
|
1
|
|
-
Corrente |
2' 09" |
|
|
2
|
|
-
Gavotta I/II
|
2' 37" |
|
|
3
|
|
-
Forlana |
1' 27" |
|
|
4 |
|
-
Minuetto |
2' 28" |
|
|
5 |
|
-
Bourrée I/II
|
2' 12" |
|
|
6 |
|
-
Passepied I/II
|
2' 23" |
|
|
7 |
|
Ouverture
N. 2 in Si minore, BWV 1067 |
|
23' 28" |
|
|
|
- Ouverture |
12' 21" |
|
|
8
|
|
- Rondò
|
1' 54"
|
|
|
9
|
|
- Sarabanda
|
2' 37" |
|
|
10
|
|
- Bourrée I/II
|
1' 47" |
|
|
11 |
|
- Polacca |
2' 32" |
|
|
12 |
|
- Minuetto |
0' 57" |
|
|
13 |
|
- Badinerie |
1' 20" |
|
|
14 |
|
Ouverture
N. 3 in Re maggiore, BWV 1068 |
|
24' 19" |
|
|
|
- Ouverture |
11' 51" |
|
|
15
|
|
- Aria
|
5' 19" |
|
|
16
|
|
- Gavotta I/II |
3' 30" |
|
|
17
|
|
- Bourrée |
1' 12" |
|
|
18 |
|
- Giga |
2' 27" |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
| Ars Rediviva
Ensemble / Milan Munclinger, Direttore |
Recorded 1971 (Suites
1-2); 1972 Suite 3)
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1 10 1361-62 | (p) 1972
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/12 | 1 CD -
durata 72' 06" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
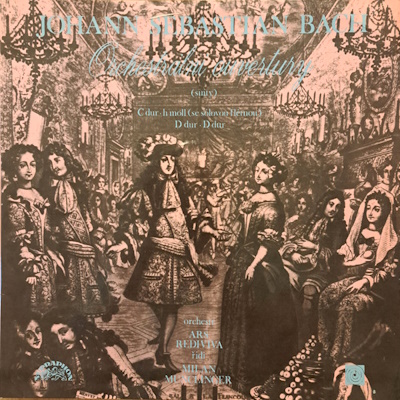
Bach
|
OUVERTURES N. 1, 2,
3
Le prime due
delle quattro Ouvertures
composte da Johan Sebastian
Bach fanno parte di quel
gruppo di composizioni
strumentali che videro la
luce presso la vivace corte
del principe Leopoldodi
Anhalt-Köthen. Il
compositore si era
trasferito a Köthen nel
1717, dopo aver lasciato, e
non nei migliori dei modi,
la corte di GuglielmoErnesto
di Sassonia-Weimar, con il
quale i contrasti erano
ormai divenuti insanabili:
il duca, di fronte alle
insistenti domande di
congedo da parte di Bach, lo
aveva addirittura
imprigionato per circa tre
settimane prima di esaudire
la sua richiesta.
Ai tempi dell'arrivo a
Köthen in qualità di
Kapellmeister, Bach, per
quanto ne sappiamo, aveva
scritto per lo più cantate
da chiesa e molti brani per
organo e cembalo. Gli era
del tutto ignoto, quindi,
1'ambiente di corte e,
soprattutto, l'attività al
servizio di un principe che
intendeva fare della musica
uno dei vanti del suo regno.
Infatti Leopoldo,
appassionato di musica ed
egli stesso buon musicista,
aveva capito che Bach poteva
fare molto di più di quanto
gli era stato possibile fino
a quel momento e che sarebbe
stato la persona ideale a
cui affidare le sorti della
sua cappella musicale,
costituita da sedici
musicisti di prim'ordine.
Questo gruppo di
strumentisti rappresentava
da circa quattro anni, dal
1713, il fiore all'occhiello
del principe Leopoldo, il
sogno che probabilmente
aveva cullato fin da
ragazzo, quando le sue doti
musicali non comuni avevano
cominciato a esprimcrsi.
Anche se non si conosce con
esattezza quali studi
musicali abbia compiuto
Leopoldo, È: certo che
frequentò per due anni
l'accademia musicale di
Berlino, dove, oltre a
raccogliere un certo
bagaglio di nozioni, conobbe
e frequentò un ambiente
musicale vivacissimo al
quale attinse in seguito
negli anni del suo regno.
L'altra tappa fondamentale
per la formazione musicale
di Leopoldo fu un lungo
viaggio intrapreso nel 1710
nei Paesi più interessanti
d'Europa dalpunto di vista
musicale. Lo scopo che si
prefiggeva, recandosi nei
Paesi Bassi, in Francia, in
Inghilterra e in Italia, era
quello di approfondire le
sue conoscenze musicali e di
studiare da vicino gli stili
e i generi che
caratterizzavano e facevano
grande ognuno di quei Paesi.
Così, quando arrivò a
Köthen, Bach si trovò di
fronte un datore di lavoro
che, oltre ad amare la
musica, la conosceva
profondamente e sapeva
suonare il violino, la viola
da gamba e il clavicembalo,
oltre a possedere una buona
voce da basso. Dal canto
suo, Leopoldo era da tempo
alla ricerca di un Kapellmeister
che sapesse valorizzare
tutte le qualità dei suoi
musicisti, provenienti dalla
prestigiosa cappella di
Berlino dopo che questa era
stata sciolta dal successore
di Federico I di Prussia,
Federico Guglielmo I, più
amante di armi e battaglie
che di strumenti musicali e
composizioni.
Il compito di Bach a Köthen
era radicalmente diverso
rispetto ai suoi impieghi
precedenti, dove era stato
prevalentemente organista,
clavicembalista e
compositore di musica da
chiesa. Al servizio del
principe Leopoldo,trovò
infatti a sua disposizione
un'intera orchestra per la
quale doveva scrivere
musiche di intrattenimento.
Non più composizioni
raccolte, ma musica
spumeggiante per divertire
un signore e i suoi ospiti,
una sorta di 'musica di
consumo'; non più un solo
strumento sul quale
inventare forme, impasti
timbrici e ritmici, ma
un'intera orchestra
costituita da tre violini,
una viola da gamba, un
violoncello, due flauti, un
oboe, un fagotto, due
trombe, timpani, un organo e
tre ripienisti (ossia,
quegli strumentisti che
eseguono le sole parti
raddoppiate).
Non sappiamo con quale
spirito Bach si accinse a
questo lavoro per lui nuovo,
ma i risultati dei suoi
cinque anni di permanenza a
Köthen parlano da soli,
poiché rivelano inventiva,
voglia di ricerca, conquista
di mete nuove, scoperta di
orizzonti prima
irraggiungibili perché erano
impraticabili le strade per
arrivarvi. A Köthen nascono
il Clavicembalo ben
temperato, la Fantasia
cromatica e fuga in re
minore, le Sei
Suites Inglesi, le Quindici
Sinfonie e le Quindici
Invenzioni (tutte
composizioni per tastiera);
e, poi, le Sonate e
Partite per violino,
le Sei suites per
violoncello solo; i Sei
Concerti brandeburghesi,
l'Ouverture n. 1 in do
maggiore, l'Ouverture
n. 2 in si minore, la
Passione secondo Giovanni
e molte altre opere, oggi
meno eseguite ma non per
questo di minore importanza.
E tutto ciò è stupefacente
se si considera che, prima
di allora, Bach non si era
mai interessato di musica
strumentale, per orchestra o
strumenti soli che non
fossero l'organo, e nemmeno
aveva mai pensato a musica
di tipo didattico, come il Clavicembalo
ben temperato o le Quindici
Invenzioni; e neppure
aveva avuto a disposizione
strumentisti di prim'ordine,
come il violoncellista
Christian Ferdinand Abel,
per il quale compose le Sei
suites per
violoncello, o il violinista
Josephus Spiess, per il
quale, molto probabilmente,
pensò le Sonate e
Partite per violino.
In questo contesto trovano
spiegazione anche le ouvertures,
musica di corte destinata a
ricevimenti fastosi e,
quindi, brillante, ricca e
varia nelle sonorità. La
struttura delle Ouvertures
n. I, n. 2 e n. 3
(quest'ultima composta in un
periodo successivo, a
Lipsia) si richiama alle suites,
una successione di varie
danze; ma in questo caso
Bach non usa il termine
tradizionale, perché i tre
pezzi iniziano con un brano
di introduzione, chiamato
appunto Ouverture,
che ricopre un posto
preponderante nel complesso
della composizione sia per
dimensioni sia per
caratteristiche musicali.
Inoltre, le danze scelte da
Bach non sono quelle
tradizionali e non seguono,
nemmeno per quanto riguarda
la successione, il modello
classico. Infatti, le
quattro danze fondamentali
che compongono la suite
sono, nell'ordine,
l'allemanda, la corrente, la
sarabanda e la giga; ebbene,
Bach elimina completamente
l'allemanda, che non compare
in nessuna di queste tre Ouvertures
(e non appare neppure nella
n. 4).
L'ouverture era un
tipo di composizione che
all'epoca andava molto
dimoda nelle corti tedesche,
perché faceva parte di quel
bagaglio di novità importate
dalla Francia. Allora era
assai vivo in tutta Europa
il mito della fastosa corte
di Versailles, e ogni corte
tedesca, nel suo piccolo,
cercava di non sfigurare
imitandone anche le mode
musicali. Così, le
invenzioni ritmiche e
formali, gli organici
orchestrali, tutte le novità
strumentali di lulliana
memoria diventavano, per i
musicisti delle corti
tedesche, un modello da
imitare a tutti i costi per
tenersi al passo con i gusti
del tempo.
In questo contesto, era
indispensabile lo spirito
salottiero e poco
impegnativo delle danze e,
allo stesso modo, diventava
fondamentale il ruolo
delbrano d”apertura, che si
prestava meravigliosamente
ad aprire con fasto la
composizione, proprio come
un cerimoniere che introduce
con tutta la solennità
possibile i banchetti, le
feste, le cerimonie e le
danze.
Bach non si sottrasse a
questa tendenza generale,
non foss'altro per servire
fedelmente il suo raffinato
padrone, ed è proprio in
osservanza della moda e del
gusto francese che eliminò
la più tedesca delle danze,
l'allemanda.
Ecco quindi nascere, tra il
1721 e il 1722, le prime due
Ouvertures, nelle
quali si rivela la volontà
di ricerca da parte
dell'autore anche in questo
genere 'di consumo'. Prova
ne è, da sola, la scelta
dell'organico, sempre
diversa da un'Ouverture
all'altra e tale da
permettere l'inserimento di
parti solistiche diverse con
una ricerca timbrica
notevolissima.
Nell'Ouverture n. 1 in do
maggiore BWV 1066,
l'organico è costituito da
due oboi, un fagotto, due
violini, una viola e un
continuo. Gli interventi
concertati, inseriti
all'interno della fuga nel
primo movimento oppure per
condurre il gioco tematico
nelle diverse danze, sono
affidati a un trio composto
da due oboi e dal fagotto.
Nell'Ouverture n. 2 in si
minore BWV 1067, con
l'organico più ridotto e
composto da un flauto
traverso, due violini, una
viola e un continuo, la
parte solistica è affidata
al flauto che, con giochi
brillanti e passi
velocissimi, conferisce al
brano un aspetto formale
insolito, a metà fra la suite
e il concerto solista.
Nell'Ouverture n. 3 in re
maggiore BWV 1068 il
ruolo conduttore e solistico
è affidato a due violini e
alla viola, che spiccano su
un organico composto da tre
trombe, timpani, due oboi e
un continuo. Il gusto
francese si rivela nella
scelta dei tempi nei
movimenti estremi che,
richiamandosi allo stile
lulliano al quale sono molto
care le volatine, le
sincopi, gli ornamenti e le
note non uguali, sono quasi
tutti impostati su un ritmo
puntato.
Curiosa, infine, è la scelta
delle danze che compongono
le tre Ouvertures:
la più frequente è la bourrée
che compare in tutti i
pezzi, mentre la gavotta e
il minuetto sono presenti
due volte e tutte le altre
compaiono una volta sola. Si
tratta di un particolare non
trascurabile, segno della
continua ricerca ritmica,
timbrica e formale che Bach
tanto amava e che non
tralasciò nemmeno in questo
genere musicale 'mondano',
arricchendolo di invenzioni,
idee e di elementi originali
e stupefacenti.
Mariangela
Mianiti
|
|
|
|
|
|