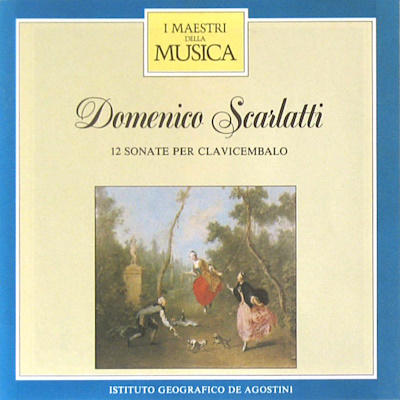 |
|
1 CD -
GMD 1/7 - (c) 1989
|
|
| I MAESTRI DELLA
MUSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Domenico
SCARLATTI (1685-1757)
|
Sonate
per Clavicembalo |
|
|
|
|
|
-
in Do maggiore, K. 49
|
|
6' 00" |
|
1
|
|
-
in Mi bemolle maggiore, K. 123
|
|
5' 10" |
|
2
|
|
-
in Sol minore, K. 426
|
|
6' 45" |
|
3
|
|
-
in Si bemolle maggiore, K. 70
|
|
2' 25" |
|
4 |
|
-
in Re minore, K. 9
|
|
4' 10" |
|
5 |
|
-
in Fa minore, K. 519
|
|
3' 32" |
|
6
|
|
-
in Si minore, K. 87
|
|
6' 30" |
|
7
|
|
-
in Sol maggiore, K. 375
|
|
2' 30" |
|
8 |
|
- in Si maggiore,
K. 244
|
|
4' 45" |
|
9
|
|
-
in Re minore, K. 1
|
|
2' 40" |
|
10 |
|
-
in Fa maggiore "Pastorale", K. 446
|
|
5' 40" |
|
11 |
|
-
in La maggiore, K. 113
|
|
4' 25" |
|
12 |
|
|
|
|
|
| Zuzana RUZICKOVA,
Clavicembalo |
Supraphon Studios at the House of
Artists, Prague - 10-17 September 1976
|
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1 11 2241/2 | (p) 1977
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/7 | 1 CD - durata
55' 06" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
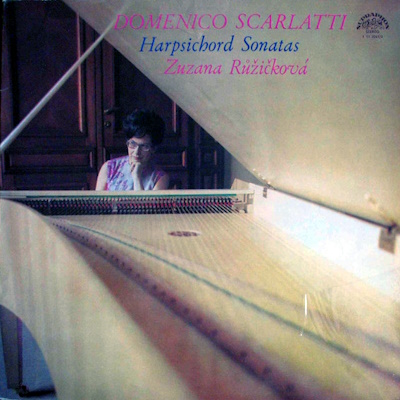
Domenico
Scarlatti
|
12 SONATE
PER CLAVICEMBALO
Basta un gesto
semplice come inserire un
compact nel lettore per
trovarsi immersi in un mondo
di corte, lontano dai fasti
e dai deliri dell'opera, in
camere da musica di
blasonati e ricchi signori
assorti nell'ascolto del
suono esile, eppure
espressivo, di un
clavicembalo. È quello che
si prova ascoltando queste
dodici sonate di Domenico
Scarlatti, sesto figlio del
musicista e operista
Alessandro; un padre e un
figlio ugualmente grandi, ma
lontanissimi nel modo di
concepire la musica, la sua
destinazione, il suo uso e,
naturalmente, lontani nello
scegliere i luoghi dove
praticarla.
Tanto Alessandro era
attratto dai teatri, tanto
ne era distante Domenico.
Pur avendo praticato con
successo la strada
dell'operismo, componendo
quattordici 'drammi per
musica', Domenico aveva
presto capito che non era
quella la sua destinazione
musicale, consapevole di non
aver la stoffa per
affrontare le liti, le
gelosie, la gloria, i
pettegolezzi, il fasto e la
confusione dell'opera. E
allora, che fare? Rinunciare
alla musica, defilarsi dalla
composizione, tirarsi da
parte? Sì, ma non del tutto.
Fu così che Domenico
Scarlatti scelse la strada
meno alla moda, meno
redditizia, più “vecchia”
per il suo tempo, delle
lezioni, in qualità di
maestro privato del fratello
minore e della figlia di
Giovanni, re del Portogallo.
Figlio di un grande
operista, Domenico tornava
quindi deliberatamente a
fare il musicista di corte,
un mestiere oscuro, in
ombra, lontano dalla fama e,
inoltre, strettamente legato
ai desideri, agli umori e
agli spostamenti del suo
signore.
In quel ritiro dorato
Domenico Scarlatti non visse
tuttavia di gloria riflessa,
ma diede vita a una delle
opere più grandiose della
storia della musica, quelle
cinquecentocinquantacinque Sonate
per clavicembalo che i
suoi contemporanei
ignorarono (ne furono
infatti pubblicate solamente
una trentina) ma che i
posteri impararono ad
apprezzare in tutta la loro
perfetta bellezza. Di questa
mastodontica produzione non
si è mai riusciti a
stabilire con esattezza i
contorni cronologici, poiché
l'autore ne omise
volutamente le date di
composizione. Molto
probabilmente le Sonate
furono comunque tutte
composte in Portogallo e in
Spagna. Alla morte del
musicista, avvenuta nel
1757, la raccolta dei
manoscritti (quindici
volumi) era infatti
conservata nella biblioteca
della regina di Spagna e
venne portata in Italia solo
due anni dopo dal celebre
cantante Farinelli.
Gran parte delle sonate, che
Scarlatti chiamava
“Essercizi”, venne
certamente composta per
Maria Barbara di Braganza,
la dotata allieva assurta
nel 1746 al trono di Spagna.
Tuttavia, che Scarlatti non
si fosse limitato a scrivere
dei semplici esercizi ma
avesse concentrato in quelle
sonate tutto il suo estro di
geniale musicista divenne,
con il trascorrere del
tempo, ben chiaro a tutti.
L'incantevole atmosfera
creata dalla musica di
Domenico non sfuggì a
Gabriele D'Annunzio che la
descrisse, in modo poetico,
quale scenario magnifico
davanti al quale «dame e
galanti strillano ridono
corrono si schivano si
salvano; in questo gioco di
figurine settecentesche,
ecco che «la prima collana
di perle si rompe
sgranellandosi: acini
ruzzolano giù per i gradini
lisci e rosei che l'acqua
discende in minuscole
cascate. Le perle si
moltiplicano, simulano una
grandine mite, scorrono per
ogni verso, rilucono,
risonano, rimbalzano, si
mescolano ai rivoli, ora
sembrano le bolle preziose
dellèacqua, ora le gocciole
della bellezza grondante.
Erano le Sonate di Domenico
Scarlatti». Quelle perle, il
loro gioco, i rivoli d'acqua
altro non sono se non i
suoni meravigliosi che il
compositore sapeva far
scaturire dal clavicembalo.
Il merito di D'Annunzio è
stato quello di aver capito
la solarità, la gioia,
l'espressività, il calore
tutto mediterraneo che
brilla nella musica
scarlattiana.
Al di là di questo giudizio
tutto poetico, è ben solida
la consapevolezza che
Domenico Scarlatti fu il più
grande clavicembalista del
suo tempo. Dallo strumento
riuscì infatti a trarre
suoni inediti, timbri
magici, effetti sconosciuti
persino al grande Bach, e un
virtuosismo talmente
trasparente, fluido e
naturale da non intaccare o
sopraffare mai il discorso
musicale.
Della sua abilità come
clavicembalista ci è rimasta
la testimonianza del
musicista inglese Thomas
Roseingrave, che conobbe
Domenico Scarlatti a
Venezia, nel 1708, in
occasione di un invito in
casa di alcuni nobili. Il
Roseingrave si era esibito
in un'esecuzione e, subito
dopo di lui, suono
Scarlatti. «Un
dignitoso, giovane uomo in
parrucca, che era stato in
piedi in un angolo della
stanza, molto tranquillo e
attento nel mentre io
suonavo, chiedeva di sedersi
al clavicembalo. Quando ebbe
iniziato a suonare, io
pensai subito che mille
diavoli fossero entrati
nello strumento. Mai prima
di allora avevo sentito, in
un'esecuzione, certi
passaggi e certi effetti.
L'esecuzione fu di gran
lunga superiore alla mia e
raggiunse quel grado di
perfezione al quale io
stesso avrei voluto
arrivare». Esecuzione,
passaggi, effetti: molto
probabilmente, oltre a
suonare e a comporre assai
bene per il clavicembalo,
Scarlatti sapeva anche
improvvisare mirabilmente,
inventando al momento
stupefacenti giochi sonori.
Può essere opportuno
accennare brevemente allo
stile esecutivo del tempo
confrontandolo con quello in
uso ai giorni nostri.
L'esecuzione tradizionale,
nel periodo barocco, era
quella a tre dita, che
utilizzava cioè solo
l'indice, il medio e
l'anulare. L'effetto che si
produceva consisteva in uno
spezzettamento continuo
della frase musicale, che
probabilmente era ciò che si
voleva ottenere. Fu Couperin
a proporre una riforma della
diteggiatura, introducendo
l'uso del pollice e del
mignolo, che Bach (il quale
conosceva e apprezzava la
musica del compositore
francese) accolse totalmente
e ampliò ulteriormente,
creando diteggiature assai
avanzate che consentivano di
eseguire più facilmente
passaggi molto complessi.
L'esecuzione moderna di
pezzi di musica barocca,
realizzata legando tutti i
suoni, è una “deformazione”
dell”effetto che si voleva
ottenere con l'antica
diteggiatura: sarebbe quindi
auspicabile che uno studio
accurato delle antiche
partiture conducesse a
un”esecuzione il
piùpossibile vicina allo
stile del tempo.
Un piccolo assaggio della
poliedrica arte scarlattiana
lo si ha nelle dodici sonate
qui presentate. Come la
maggior parte della sua
produzione, queste dodici
sonate hanno un solo tempo a
struttura monotematica
(cioè, a un tema) e
bipartita (ossia, in due
parti). Se la sonata è in
modo maggiore, la prima
parte si conclude con una
modulazione (cambiamento di
tonalità) alla tonalità
della dominante (il quinto
suono della scala); la
seconda parte si apre da
quest'ultima tonalità per
poi modulare nuovamente e
ritornare alla tonica
originaria. Questa polarità
tonica-dominante è di
fondamentale importanza,
perché su di essa si
costruisce tutto l'impianto
formale del classicismo.
Quando invece la sonata si
apre in modo minore, la
modulazione al termine della
prima parte non è più verso
la dominante bensì verso la
tonalità relativa nel modo
maggiore. Esistono infatti
corrispondenze tra modo
maggiore e modo minore per
cui, scegliendo un medesimo
ambito di suoni, una stessa
scala, è possibile costruire
una sequenza in modo
maggiore o in modo minore
senza mutare i suoni ma
cambiando il punto di
partenza. Considerando ad
esempio la situazione più
semplice, ossia la scala
naturale (i tasti bianchi
del pianoforte), se partiamo
dal do ed eseguiamo tutti i
suoni uno dopo l'altro,
otteniamo la scala di do
maggiore; se invece
cominciamo a suonare dal la,
otteniamo la scala di la
minore naturale, che è
appunto la relativa minore
di do maggiore (ovviamente
ciò vale per qualsiasi
scala). Quindi, le sonate di
Scarlatti in tonalità minore
si chiudono, al termine
della prima parte, al
relativo maggiore e
iniziano, nella seconda
parte, in questo nuovo
ambito tonale, per poi
ritornare alla tonalità
originaria. Occorre comunque
aggiungere che questa regola
non è rigida e che in
diverse occasioni la
modulazione centrale non
viene fatta in direzione del
relativo maggiore bensi
della tonalità della
dominante in modo maggiore.
La struttura formale è
dunque sempre assai
semplice, ma, ciò
nonostante, Scarlatti riesce
a non essere mai
prevedibile, mai monotono,
grazie soprattutto alla
grande inventiva melodica,
ritmica e armonica; senza
considerare la voglia di
bizzarria, di stranezza che
di tanto in tanto fa
capolino attraverso
abbellimenti e ricche
fioriture, riprese
impreviste di temi, un uso
sempre vivace e inconsueto
delle sonorità.
Da tutto ciò si deduce che
Domenico Scarlatti,
insegnando, componendo
esuonando il clavicembalo,
si divertiva; ma era un
divertimento che nasceva dal
desiderio dell'invenzione,
dalla voglia di scoperta,
dall'ansia di crescere e di
sperimentare tutto ciò che
era possibile trarre da
quella tastiera, da quelle
corde pizzicate che nessuno,
prima di lui, aveva saputo
far 'cantare' con la stessa
abilità e poesia.
Mariangela
Mianiti
|
|
|
|
|
|