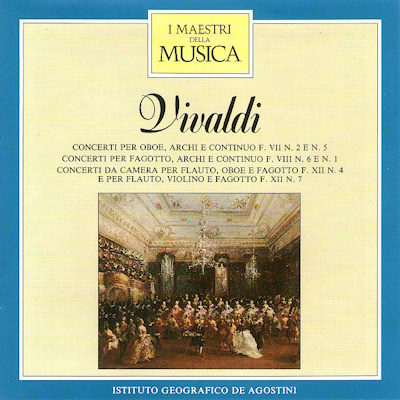 |
|
1 CD -
GMD 1/3 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antonio
VIVALDI (1678-1741)
|
Concerto
per Oboe, Archi e continuo in Fa
maggiore, F. VII N. 2 |
|
8' 50" |
|
|
|
-
Allegro giusto
|
3' 30" |
|
|
1
|
|
-
Grave |
2' 35" |
|
|
2
|
|
-
Allegro |
2' 45" |
|
|
3
|
|
Concerto
per Oboe, Archi e continuo in La
minore, F. VII N. 5 |
|
10' 10" |
|
|
|
-
Allegro non molto
|
3' 35" |
|
|
4
|
|
-
Larghetto
|
3' 50" |
|
|
5
|
|
- Allegro |
2' 45" |
|
|
6
|
|
Concerto
per Fagotto, Archi e continuo in
Mi minore, F. VIII N. 6 |
|
11' 40" |
|
|
|
- Allegro poco
|
4' 25"
|
|
|
7
|
|
- Andante
|
4' 05" |
|
|
8
|
|
- Allegro |
3' 10" |
|
|
9
|
|
Concerto
per Fagotto, Archi e continuo in
Si bemolle maggiore, F. VIII N. 1 |
|
9' 10" |
|
|
|
- Largo, Presto
|
3' 50" |
|
|
10
|
|
- Andante molto
|
2' 35" |
|
|
11
|
|
- Allegro |
2' 45" |
|
|
12
|
|
Concerto
per Flauto, Oboe e Fagotto in Sol
minore, F. XII N. 4 |
|
8' 51" |
|
|
|
- Allegro ma
cantabile
|
4' 00" |
|
|
13
|
|
- Largo
|
3' 12" |
|
|
14
|
|
- Allegro non
molto |
1' 39" |
|
|
15
|
|
Concerto
per Flauto, Violino e Fagotto in
Re maggiore, F. XII N. 7 |
|
10' 09" |
|
|
|
- Allegro |
3' 39" |
|
|
16
|
|
- Larghetto |
3' 39" |
|
|
17
|
|
- Allegro |
2' 51" |
|
|
18
|
|
|
|
|
|
| Orchestra da
Camera di Pardubice / Jiri Krejci, oboe
/ Frantisek Herman, fagotto / Libor
Pesek, Direttore - (F. VII, F VIII) |
Tesla Hall,
Pardubice - 17-20 April 1979
|
| Milan Munclinger,
flauto / Jaroslav Vagoun, oboe
/ Frantisek Herman, fagotto
/ Antonin Novak, violino -
(F. XII) |
1971 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1110 2666 | (p) 1980 | (F.
VII, F. VIII)
Supraphon | (?) | (p) 1971 | (F.
XII)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/3 | 1 CD - durata
61' 14" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
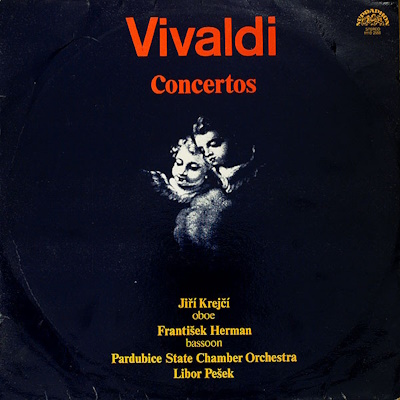
Vivaldi (F. VII,
F. VIII)
|
CONCERTI
PER OBOE, ARCHI E
CONTINUO F. VII N.2 E
N.5
Vivaldi ha
composto 19 concerti per
oboe, probabilmente i primi
dedicati dal musicista a uno
strumento a fiato solista.
Già l'ascolto del primo
tempo, Allegro giusto, del Concerto
in fa maggiore per oboe,
archi e continuo F. VII n.
2 evidenzia come la
struttura generale di tali
composizioni ricalchi quella
della forma del concerto
solistico settecentesco,
caratterizzato dalla tipica
alternanza tra gli
interventi del tutti
orchestrale, che ripropone
nei ritornelli il medesimo
materiale tematico, e gli
episodi solistici, sempre
nuovi e di norma sorretti
soltanto dal basso continuo.
Tuttavia in Vivaldi queste
alternanze musicali
divengono più elastiche
(possiamo infatti trovare
gli archi che accompagnano
il solista), il virtuosismo
diventa più pronunciato e
prevale un impulsoritmico e
melodico del tutto unico e
originale. Al contrario, nel
Grave chesegue vi è
esemplificata una struttura
musicale assai ricorrente
nei tempi lenti dei concerti
vivaldiani. La successione
di episodi del solista e del
tutti lascia spazio a un
procedere per fasce musicali
sovrapposte. È qui il ricamo
dell'oboe, fortemente
melodico ed emozionato, ad
anticipare l'ingresso degli
archi che lo accompagneranno
soffusamente in sottofondo
sino al termine del brano.
Nell'Allegro conclusivo, il
ritornello presenta nella
sua componente armonica
volute dissonanze, che
creano una venatura
d'inquietudine.
Il Concerto in la minore
per oboe, archi e continuo
F. VII n. 5 è uno dei
più famosi composti da
Vivaldi e si caratterizza
già per la scelta della
tonalità in minore,
solitamente adottata dal
musicista con una certa
parsimonia. Il primo tempo,
Allegro non molto, mescola
sapientemente ritmo e
appassionato melodismo.
Negli episodi solistici il
tutti si presenta a spezzare
la linea dell'oboe,
riproducendo così
l'alternanza tutti-solista
dell'architettura globale
del movimento. Nel Larghetto
che segue, è
l'orchestra,molto seriosa e
solenne, a introdurre
lentamente il lungo
intervento dell'oboe:
questo, molto malinconico e
sognante, è caratterizzato
da un disegno sospeso e
frammentario, sorretto da un
esile accompagnamento degli
archi che chiudono
solennemente il movimento.
Termina il concerto un
Allegrobriosissimo,
inaugurato da un tutti
orchestrale contraddistinto
da vigorose folate
degli archi, che presenta la
tipica struttura dei
ritornelli vivaldiani:una
serie a incastro di frasi e
semifrasi, tutte o in parte
riprese all'occorrenza
dall'autore per i successivi
ritornelli.
CONCERTI
PER FAGOTTO, ARCHI E
CONTINUO F. VIII N. 6 E
N.1
La cultura
musicale veneziana del
Settecento non vantava
un'affermata tradizione di
composizioni per fagotto
solista; tuttavia Vivaldi
dimostrò nei confronti di
questo strumento una vera e
propria attrazione, tanto
che gli dedicò ben 39
concerti solistici.
Probabilmente il mistero si
spiega con il desiderio di
ricerca timbrica che
accompagnò sempre il
musicista. Il Concerto
in mi minore per fagotto,
archi e continuo F. VIII
n. 6 è aperto da un
Allegro poco il cui primo
ritornello, diviso in due
parti, presenta un'idea
musicale struggente che
percorrerà tutto il brano.
Il fagotto mette in mostra
una scrittura che
valorizzasoprattutto il suo
registro più grave;
ricorrenti sono anche
impervi e singolari salti
dal registro di basso a
quello di tenore, che creano
l'effetto di un dialogo.
L'Andante che segue è di una
bellezza folgorante. Sono
gli archiche per primi
presentano, su note
profonde, drammatiche e
dolenti, sonorità a cui più
avanti si aggiungono acuti
lamenti che salgono come
sospiri. Interviene quindi
la voce del solista con il
suo canto desolato,
interrotto brevemente una
sola volta dall'orchestra
che va lentamente a
spegnersi sul debole tutti
conclusivo. L'Allegro finale
si mantiene, seppur su
un'agogica più lesta, in
un'atmosfera non del tutto
serena. I tre interventi
solístici sono sorretti da
disegni decisi e ostinati
degli archi.
Il Concerto in si
bemolle maggiore per
fagotto, archi e continuo
F. VIII n. 1 è uno dei
tre concerti di Vivaldi che
portano come sottotitolo "La
notte". Questa composizione,
tra le più belle, libere e
fantasiose del musicista,
abbandona la consueta
successione in tre tempi per
presentarsi invece più come
una suite di brani molto
elastici nell'architettura,
ognuno dei quali dotato di
un'indicazione
programmatica. Si apre con
un Largo introduttivo ('La
notte') che interpreta con
un sentimento quasi
romantico il calar della
sera come momento degli
amori e di intense emozioni.
Iniziano insieme archi e
fagotto con lente
declamazioni concluse da
scale ascendenti, cui segue
un breve ed espressivo
intervento della sola
orchestra. È quindi ancora
il fagotto a riproporre
dapprima l'idea delle scale
ascendenti e quindi a
concludere il brano in
calando con una soffusa
figurazione musicale
accompagnata dagli archi in
piano: dopo le immagini del
tramonto e delle prime ombre
della sera è calata al fine
la notte. Ed ecco infatti,
tripartito, il secondo tempo
(“Fantasmi'), che descrive
con accenti foschi e mobili
le inquietudini e gli incubi
notturni che precedono il
riposo. Si ascolta un Presto
introdotto con grande
animazione ritmica dagli
archi agitatissimi che
ripropongono veloci scale
ascendenti e poi
discendenti, riprese dal
fagottonei suoi interventi
solistici. Dopo una
brevissima pausa di silenzio
segue un secondo Presto di
ritmo differente, esposto
dal tutti, che sfocia in un
breve Adagio di sospensione,
ancora esposto dai soli
archi, che prepara
emotivamente al successivo
movimento, un Andante molto
(“Il sonno”). Qui Vivaldi
per realizzare una sonorità
più ovattata prescrive che
l'orchestra suoni senza
cembalo e con gli archi in
sordina. Questi eseguono per
tutta la durata del
movimento una successione di
lunghe dissonanze che creano
un senso d'immobilità. Su
questo sottofondo si
sovrappone il fagotto, che
con timbro velato dipana una
sognante linea musicale che
esprime il riposante
divagare della mente durante
il sonno.
L'ultimo tempo è un Allegro
(“Sorge l'aurora”).
Dopo gli struggimenti e le
angosce, con il sorgere del
sole tutte le immagini
notturne sono fugate e si
riprende forza e ragione. La
struttura musicale
riacquista, nella sua
alternanza di ritornelli e
di episodi, trasparenza e
luminosità, mentre il
fagotto ripresenta tutto il
suo vivace e ritmico
virtuosismo.
CONCERTI
DA CAMERA
PER
FLAUTO, OBOE E FAGOTTO
F. XII N. 4
E PER
FLAUTO, VIOLINO E
FAGOTTO F. XII N. 7
Dopo aver
assimilato e perfezionato la
forma del concerto
solistico, Vivaldi si
cimentò, sull'onda del suo
accentuato sperimentalismo
musicale, nell'adattamento
di questa tipologia
compositiva ad altri
organici. Furono così
composti i concerti per più
solisti, i concerti senza
solisti e 22 concerti da
camera (senza orchestra).
Il Concerto da camera in
sol minore per flauto
diritto, oboe e fagotto F.
XII n. 4 è l”unico
composto da Vivaldi per
questo organico. Nel primo
tempo, Allegro ma cantabile,
il flauto diritto ha il
ruolo di solista,
mentrel'oboe interviene
soltanto nei ritornelli. Il
primo ritornello è composto
da una coppia di frasi
eseguite due volte ciascuna.
Il Largo che segue sfrutta
il particolare organico
utilizzato per esprimere
un'atmosfera estremamente
intensa. È il fagotto che
inizia per primo con la
linea del basso, poi seguono
gli ingressi del flauto e
quindi dell'oboe. Più avanti
si presenta un Da capo, che
nel Settecento permetteva
agli esecutori di
ripresentare il materiale
tematico già esposto, ora
però variato e fiorito
liberamente da ciascuno
secondo le proprie
caratteristiche e capacità
musicali. Segue una terza
sezione nella quale, come
nella prima, l'oboe e il
flauto iniziano
rispondendosi per concludere
insieme. Chiude il concerto
un Allegro non molto
composto dalla successione
di quattro episodi e di
quattro ritornelli. In
questi ultimi è da notare il
sapore traballante e quasi
grottesco, reso dagli
strumenti attraverso un
calibratissimo uso di
sonorità dissonanti.
Il Concerto da camera in
re maggiore per flauto
diritto, víolino e fagotto
F. XII n. 7 è aperto
da un Allegro in cui, subito
dopo l'esposizione del primo
ritornello bipartito, si
presenta il primo episodio
nel quale flauto e violino
si rispondono. Nel secondo e
nel terzo episodio vi sono
rispettivamente un assolo
del flauto e uno del
violino. Prima del
ritornello conclusivo è
ancora il flauto a esibirsi
virtuosisticamente. Il
secondo tempo, Larghetto, è
strutturato in quattro
parti, ognuna delle quali
composta da tre lunghi
respiri musicali. All'inizio
della prima sono presentati,
con brevi interventi, il
flauto e il violino. La
seconda sezione è costituita
da un Da capo, mentre nelle
due successive (di cui la
seconda è ancora un Da
capo), violino e flauto
procedono insieme per creare
una rassicurante atmosfera,
pervasa dal tepore di un
affettuoso intimismo. Nel
terzo tempo, Allegro, i
ritornelli, caratterizzati
da un vitalismo tipicamente
vivaldiano, sono affidati
allo scattante e
freschissimo virtuosismo di
tutti gli strumenti, mentre
negli episodi è soltanto il
flauto a svolgere il ruolo
di solista e a proporre, col
suo fraseggio luminoso, una
striscia di colore
mobilissima.
Massimo
Rolando Zegna
|
|
|
|
|
|