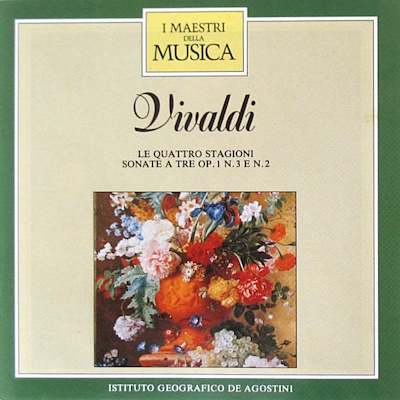 |
|
1 CD -
GMD 1/2 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Antonio
VIVALDI (1678-1741)
|
Concerto
in Mi maggiore "La Primavera", Op.
8 N.1
|
|
10' 14" |
|
|
|
-
Allegro |
3' 28" |
|
|
1
|
|
-
Largo |
2' 51" |
|
|
2
|
|
-
Allegro |
3' 55" |
|
|
3
|
|
Concerto
in Sol minore "L'Estate", Op. 8 N.
2
|
|
9' 54" |
|
|
|
-
Allegro non molto
|
4' 48" |
|
|
4
|
|
-
Adagio e piano
|
2' 08" |
|
|
5
|
|
- Allegro |
2' 58" |
|
|
6
|
|
Concerto
in Fa maggiore "L'Autunno", Op. 8
N. 3
|
|
11' 15" |
|
|
|
- Allegro |
5' 09"
|
|
|
7
|
|
- Adagio molto
|
2' 32" |
|
|
8
|
|
- Allegro |
3' 34" |
|
|
9
|
|
Concerto
in Fa minore "L'Inverno", Op. 8 N.
4
|
|
9' 19" |
|
|
|
- Allegro non
molto
|
3' 42" |
|
|
10
|
|
- Largo |
2' 14" |
|
|
11
|
|
- Allegro |
3' 23" |
|
|
12
|
Antonio VIVALDI
|
Sonata
a tre Op. 1 N. 3 |
|
5' 31" |
|
|
|
- Adagio
|
1' 23" |
|
|
13
|
|
- Allemanda,
Allegro
|
1' 48" |
|
|
14
|
|
- Adagio |
0' 38" |
|
|
15
|
|
- Sarabanda,
Allegro
|
1' 42" |
|
|
16 |
|
Sonata
a trre Op. 1 N. 2 |
|
7' 22" |
|
|
|
- Grave |
2' 16" |
|
|
17
|
|
- Corrente,
Allegro |
2' 11" |
|
|
18
|
|
- Gigue, Allegro |
2' 12" |
|
|
19
|
|
- Gavotta, Allegro |
0' 43" |
|
|
20
|
|
|
|
|
|
| Orchestra da
Camera di Praga / Libor Hlaváček, Direttore
- (Le Stagioni) |
House of artists
(Supraphon Studio), Prague - 13-16 March
1975 |
| Ars Redeviva
Ensemble / Milan. Munclinger, Direttore
- (Sonate a tre)) |
National House, Zizkov, Prague -
15-30 April 1976 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1 10 2028 | (p) 1976 | (Le
Quattro Stagioni)
Supraphon | 1 11 1676 | (p) 1974
| (Sonate a tre)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/2 | 1 CD - durata
54' 57" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|

Vivaldi (Sonate a
tre)
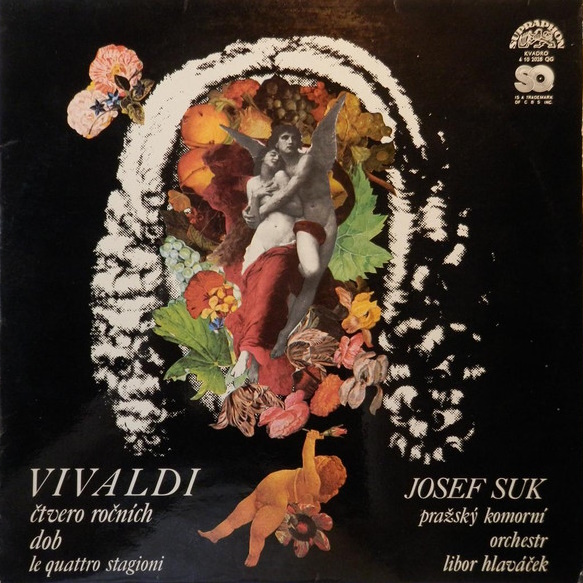
Vivaldi (Le
Quattro Stagioni)
|
LE
QUATTRO STAGIONI
Antonio
Vivaldi rappresenta una
delle figure più insigni del
Barocco italiano. Questa
composizione, sicuramente la
sua più conosciuta,
raggruppa quattro concerti,
ciascuno ispirato a una
stagione, tutti nella forma
tripartita Allegro - Adagio
- Allegro,che l'autore
adottò sistematicamente.
Anzi, per meglio guidare il
pubblicoche assisteva ai
suoi concerti, Vivaldi
scrisse quattro sonetti che
avevano la funzione di
programma.
Dedicati al conte Venceslao
di Marzin, i quattro
concerti vennero
probabilmente eseguiti per
la prima volta
dall'orchestra privata del
nobiluomosotto la direzione
dello stesso Vivaldi.
L'argomento è il fluire del
tempo, scandito
dall'avvicendarsi delle
stagioni, e in ciascuna di
esse vengono narrati i fatti
più divertenti e ingenui
legati alla cultura
popolare-contadina.Vivaldi
accoglie dalla natura tutto
quanto è sonoro e quindi
trasferibile inmusica, ma
sempre secondo la sua
sensibilità e la sua visione
della realtà tipicamente
settecentesche: infatti egli
non imita la realtà, né la
descrive,bensì la interpreta
e la piega alle regole del
suo mondo ideale
interiore.Troviamo le
onomatopee, i ritornelli, le
alternanze “soli-tutti”. Non
è quindi la realtà che il
compositore ci presenta, ma
la sua visione della
realtà,ordinata e composta,
regolata da leggi analoghe a
quelle scientifiche scoperte
in quegli anni: così come la
teoria della gravitazione
universale organizza il
sistema solare secondo una
serie di rapporti di
interdipendenza, allo stesso
modo il sistema tonale si
comporta con i suoni
musicali. Un'esperienza
antitetica
dell'interpretazione della
realtà può essere
considerata, adesempio,
quella della musica
concreta, una corrente
musicale del nostro secolo
in cui i suoni della realtà
divengono essi stessi i
protagonisti del
branomusicale, generalmente
secondo un ordine casuale:
anche in questo caso non è
difficile scorgere una nuova
visione filosofica del
mondo, caratterizzata dai
concetti di casualità e di
relatività.
Il primo concerto, "La
Primavera”, è cosi descritto
dallo stesso autore nel
relativo sonetto: "Giunt'è
la primavera/ e
festosetti/ la salutan
gl'augei con lieto
canto,/ei fonti allo
spirar de' zeffiretti/ con
dolce mormorio scorrono
intanto./ Vengon' coprendo
l'aer di nero ammanto/ e
lampi e tuoni ad
annunziarla eletti;/ indi
tacendo questi,
gl'augelletti/ tornan di
nuovo al lor canoro
incanto./ E quindi sul
fiorito ameno prato/ al
caro mormorio di fronde e
piante/ dorme 'l caprar
col fido can' a lato./ Di
pastoral zampogna al suon
festante/ danzan ninfe e
pastor nel tetto amato/ di
primavera all'apparir
brillante".
L'Allegro iniziale descrive
le prime due scene di tipo
naturalistico, gli uccelli
cinguettanti, il fiumicello
gorgogliante, la tiepida
aria primaverile, interrotta
dal frastuono del temporale
che si gonfia, esplode e poi
si quieta, facendo ritornare
la tranquilla soavità della
scena iniziale. Il Largo è
estremamente pittoresco e di
grande modernità. Vivaldi
sovrappone tre elementi
corrispondenti a tre linee
melodiche con dinamiche
(intensità) differenti: lo
sfondo del quadro è il
mormorio delle fronde
(violini pianissimo); in
primo piano si snoda
l'ampia, riposante melodia
del violino principale che
rappresenta il sonno del
capraio; infine, il fido
cane di cui si fa menzione
nel sonetto ha l'equivalente
musicale nell'unico
strumento che in questo
movimento funziona da basso,
cioe la viola. Più
esattamente, sulla parte
della viola si legge sia il
sottotitolo "il cane che
grida" sia l'indicazione "si
deve suonare sempre molto
forte e strappato". Per
tutte le trentotto battute
la viola ripete sempre lo
stesso disegno ritmico. Il
fatto curioso è che in
nessuna esecuzione, di cui
almeno siamo a conoscenza,
la viola suona «forte e
strappato» come voleva
Vivaldi. Si suona invece
mezzoforte se non
addirittura piano, con un
effetto stupendo: l'uniforme
battito del disegno ritmico
della viola, quasi a
rievocare il regolare
respiro del capraio e del
cane, ci introduce infatti
in una natura immersa nel
sonno. Una danza gaia e
vivace conclude poi, secondo
lo stile del tempo, la prima
stagione.
Per il secondo concerto,
"L'Estate", leggiamo ancora
le parole di Vivaldi: "Sotto
dura staggion dal sole
accesa/ langue l'huom,
langue 'l gregge ed arde
il pino/ scioglie il cucco
la voce,/ e tosto intesa/
canta la tortorella e 'l
gardellino./ Zeffiro dolce
spira,/ ma contesa/ muove
Borea improvvisa al suo
vicino;/ e piange il
pastorel, perché sospesa/
teme fiera borasca e 'l
suo destino./ Toglie alle
membra lasse il suo
riposo/il timor de' lampi,
e tuoní fieri/ e de mosche
e mosconi/ il stuol
furioso!/ Ah, che
purtroppo i suoi timor son
veri;/ tuona e fulmina il
ciel e grandinoso/ tronca
il capo alle spiche e a'
grani alteri". Anche
in questo concerto abbondano
le citazioni desunte dai
suoni naturali; i richiami
delle diverse specie di
uccelli sono riprodotti con
precisione, così come i
ronzii degli insetti e il
fragore del temporale
estivo, violento e
travolgente.
Il terzo sonetto, relativo a
"L'Autunno", suona così: "Celebra
il villanel con balli e
canti/ del felice
raccolto il bel piacere,/
e del liquor di Bacco
accesi tanti/ finiscono
col sonno il lor godere./
Fa ch'ognuno tralasci e
balli e canti/ l'aria che
temperata dà piacere/ e la
staggion ch'invita tanti e
tanti/ d'un dolcissimo
sonno al bel godere./ I
cacciator alla nov'alba a
caccia/ con corni,
schioppi e cani escon
fuore;/fugge la belva e
seguono la traccia./ Già
sbigottita e lassa al gran
rumore/ de' schioppi e
cani,/ ferita minaccia/
languida di fuggir, ma/
oppressa muore".
In questo terzo concerto
hanno la prevalenza i
ricordi di scene di vita
campestre: è il tempo della
vendemmia e i contadini
gustano il nettare di Bacco,
che prima accende gli animi
e poi li abbandona in un
sonnolento torpore. La scena
conclusiva celebra i piaceri
della caccia, senza
dimenticare però le pene
della preda che viene
pietosamente descritta nella
sua inutile ricerca di
salvezza e nel suo cedere
sfinita ai suoi persecutori.
Infine il sonetto de
"L'Inverno": "Agghiacciato
tremar tra nevi algenti/
al severo spirar d'orrido
vento,/ correr battendo i
piedi ogni momento/ e per
soverchio gel/ batter i
denti;/ passar al foco i
dì quieti e contenti/
mentre la pioggia fuor
bagna ben cento./ Camminar
sopra 'l ghiaccio, e a
passo lento/ per timor di
cader girsene intenti./
Gir forte, sdrucciolar,
cader a terra,/ di nuovo
ir sopra 'l ghiaccio e
correr forte/ sin ch'il
ghiaccio si rompe e si
disserra;/ sentir uscir
dalle ferrate porte/
Sirocco, Borea e tutti i
venti in guerra./ Quest'è
'l verno, ma tal che gioia
apporte".
ll primo movimento riproduce
il clima rigido dell'inverno
descritto nei versi iniziali
del sonetto: si apre con un
'tremare' dei primi violini
sopra gli accordi marcati
dell'orchestra, poi le
'folate` del violino solista
scuotono la scena,
costringendo il viandante a
correre battendo i piedi
(note ribattute) e i denti
(suoni ribattuti e
dissonanti); il movimento si
conclude con un brivido di
freddo generale (tutti
forte). Il secondo quadretto
è tanto breve quanto
suggestivo. Sopra gli
accordi pizzicati dei
violini (la pioggia che
"bagna ben cento") e sopra
le note lunghe (pianissimo
con Parco) della viola il
violino solista libra una
dolce melodia, che richiama
i giorni "quieti e contenti"
trascorsi davanti al fuoco,
ripresa con diverso
sviluppo: un'evocazione
incomparabile di sole
diciotto battute. Nel terzo
movimento ondeggianti
sestine del violino solista
introducono il circospetto
camminare sul ghiaccio,
quindi anche l'orchestra si
unisce in ribattuti puntati.
Seguono rapide scale
discendenti "sdrucciolar,
cader a terra", e quando il
ghiaccio si rompe anche gli
archi spezzano lo
svolgimento della melodia su
accordi secchi e pausati.
Infine i venti escono "dalle
ferrate porte": violino
solista e orchestra si
contrappongono in un dialogo
sempre più incalzante e
turbinoso fino all'impetuosa
chiusura del concerto.
SONATE A
TRE OP. 1 N. 3 E N. 2
Questo genere
di sonata, la più importante
tra le composizioni
strumentali del Barocco,
venne usata da numerosi
musicisti, tra cui anche
Vivaldi. Scritta per due
strumenti melodici e basso
continuo, rispetta la
suddivisione in più
movimenti, tipica della
sonata da chiesa da cui
deriva: al tempo lento
iniziale seguono movimenti
più vivaci, nei quali
prevalgono la forma
imitativa e l'uso del
fugato, sempre in
un'atmosfera di severità e
di equilibrio. Infatti, da
questo tipo di sonata derivò
la sonata classica, mentre
dalla sonata da camera, più
briosa e salottiera, nacque
la suite.
La combinazione strumentale
più comune nella sonata a
tre prevede due violini e
basso continuo, ma ve ne
sono anche con due flauti,
flauto e violino, oboe e
violino o viola da gamba. Le
due sonate che vengono
presentate in questa
raccolta appartengono al
secondo tipo: abbiamo
infatti un flauto e un
violino oltre al basso
continuo eseguito al
clavicembalo. A questo
proposito dobbiamo
aggiungere una piccola
curiosità che riguarda il
numero degli esecutori; la
sonata a tre infatti viene
per consuetudine eseguitada
quattro musicisti, in quanto
la parte del basso continuo
è di norma raddoppiata: ciò
si verifica anche nel nostro
caso, e così possiamo udire
la parte del clavicembalo
rinforzata dal violoncello.
Entrambe le sonate
vivaldiane si attengono alla
struttura formale propria di
questo genere, sia nella
suddivisione dei movimenti
sia negli espedienti
narrativi prescelti. Ci
troviamo dinanzi a graziose
gemme di semplicità e
purezza di stile, oltre che
a notevoli esempi di
narrazione concisa e intima,
che riesce a creare in uno
spazio di tempo esiguo uno
stato di profonda commozione
anche nell'ascoltatore
attento del ventesimo
secolo.
Maria
Luisa Merlo
|
|
|
|
|
|