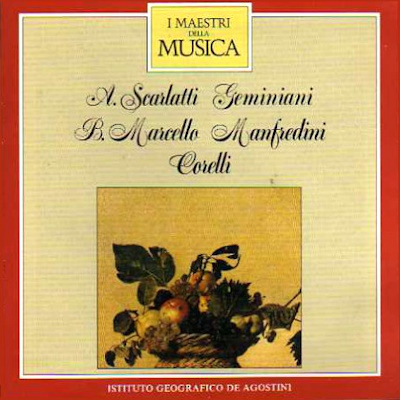 |
|
1 CD -
GMD 1/1 - (c) 1989
|
|
I MAESTRI DELLA
MUSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alessandro
SCARLATTI (1660-1725)
|
Concerto
in la minore |
|
10' 34" |
|
|
|
-
Allegro |
1' 49" |
|
|
1
|
|
-
Largo |
1' 48" |
|
|
2
|
|
-
Fuga |
2' 30" |
|
|
3
|
|
-
Piano |
2' 33" |
|
|
4
|
|
-
Allegro |
1' 54" |
|
|
5
|
Francesco GEMINIANI
(1687-1762)
|
Concerto
Grosso in Sol minore, Op. 3 N. 2 |
|
11' 03" |
|
|
|
- Largo e staccato |
4' 55" |
|
|
6
|
|
- Adagio |
2' 33"
|
|
|
7
|
|
- Allegro |
3' 35" |
|
|
8
|
Benedetto MARCELLO
(1686-1739)
|
Concerto
Grosso in Fa maggiore, Op. 1 N. 4 |
|
9' 12" |
|
|
|
- Largo |
2' 35" |
|
|
9
|
|
- Presto vivace |
2' 18" |
|
|
10
|
|
- Adagio |
1' 45" |
|
|
11
|
|
- Prestissimo |
2' 35" |
|
|
12
|
Francesco MANFREDINI
(1684-1762)
|
Concerto
Grosso in Re maggiore, Op. 3 N. 9 |
|
9' 14" |
|
|
|
- Adagio, Presto
|
3' 10" |
|
|
13
|
|
- Largo |
3' 27" |
|
|
14
|
|
- Allegro |
2' 37" |
|
|
15
|
Arcangelo CORELLI
(1653-1713)
|
Concerto
Grosso in Do minore, Op. 6 N. 3 |
|
10' 01" |
|
|
|
- Largo |
2' 46" |
|
|
16
|
|
- Allegro |
2' 15" |
|
|
17
|
|
- Grave, Vivace |
3' 20" |
|
|
18
|
|
- Allegro |
1' 40" |
|
|
19
|
|
|
|
|
|
| Ars Redeviva
Ensemble / Milan. Munclinger, Direttore
- (Scarlatti) |
National House,
Zizkov, Prague - 15-30 April 1976
|
| Bohuslav Martinů
Orchestra / Josef. Tesik, Direttore
- (Geminiani, Marcello) |
Stadion Hall, Brno - 24-30 June
1975 |
| Orchestra da
Camera Janáček / Zdenek. Dejmek, Direttore
(Manfredini, Corelli) |
Prague - 1-5
November 1975 |
|
|
|
|
Manufactured |
|
Tecval
Memories SA (Switzerland) |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Supraphon
| 1 11 1676 | (p) 1977 |
(Scarlatti)
Supraphon | 1 10 1877 | (p) 1976
| (Geminiani, Marcello)
Supraphon | 1 10 1890 | (p) 1976
| (Manfredini)
Supraphon | 10 3608-1 011 | (p)
1989 | (Corelli)
|
|
|
Edizione CD |
|
De
Agostini | GMD 1/1 | 1 CD - durata
45' 01" | (c) 1989 | ADD |
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|

Alessandro
Scarlatti
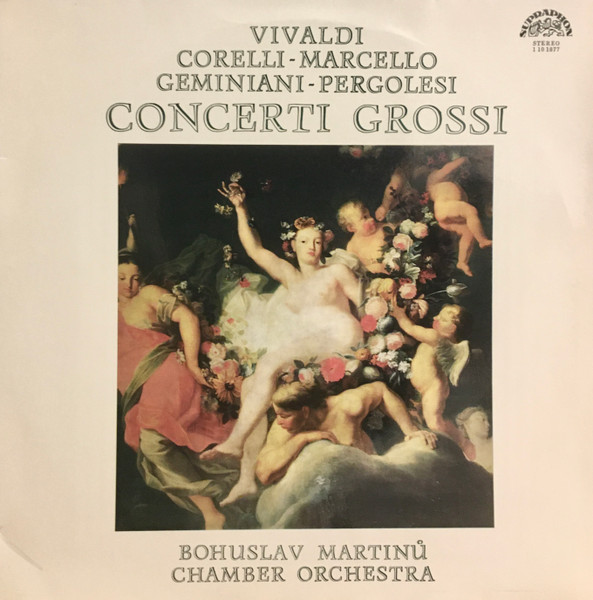
Geminiani |
Marcello

Manfredini
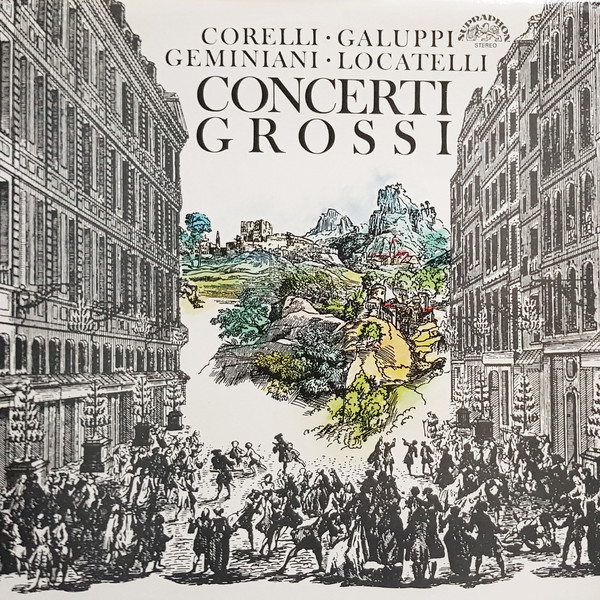
Corelli
|
CONCERTI
GROSSI
Nel 1682, il
compositore tedesco George
Muffat, dopo aver
presenziato a un concerto
romano, scrisse: "ho
ascoltato con gran piacere e
meraviglia un'eccellente
produzione di concerti
dell'abilissimo signor
Arcangelo Corelli, ben
eseguiti con gran numero di
strumenti". Con queste
parole, Muffat rendeva
omaggio ai dodici Concerti
grossi con duoi Víolini e
Violoncello di Concertino
obligati, e duoi altri
Violini, Viola, e Basso di
Concerto Grosso ad
arbitrio che si potranno
raddoppiare del suo
maestro, il violinista e
compositore Arcangelo
Corelli. Ma perché Muffat
provò meraviglia, oltre che
piacere, nell'ascoltarli?
Perché a quei tempi il
concerto grosso era una
composizione nuova,
sperimentata da pochi
compositori e non in ogni
città. Pur non potendo
vantare una precisa data di
nascita, il concerto grosso
aveva mosso i primi passi,
molto presumibilmente, tra
le navate di San Petronio, a
Bologna, dove, già
all'inízio della seconda
metà del Seicento, i
musicisti locali avevano
iniziato a raddoppiare le
parti delle sonate a tre da
chiesa. Questa operazione,
che creava un effetto sonoro
alquanto nuovo e piacevole,
in breve tempo raggiunse
un'altra città musicalmente
importante: Roma. Fu proprio
a Roma che, tra il 1670 e il
1680, Alessandro Stradella
compose il primo concerto
grosso che si conosca nella
storia della musica. Fu
tuttavia necessario
aspettare Arcangelo Corelli
perché questa nuova forma
musicale stupisse, piacesse,
conquistasse i gusti e i
favori generali.
Dal punto di vista formale,
il concerto grosso mostra
aspetti analoghi a quelli
delle sonate, cioé la
presenza del genere da
chiesa e da camera e la
successione di sezioni
accoppiate secondo il
criterio dell'alternativa
Adagio-Veloce. Dal punto di
vista strutturale, possiede
però un assetto peculiare:
anzitutto, l'organico
strumentale è suddiviso in
due sezioni di diversa
consistenza, l'una formata
da un piccolo gruppo di
strumenti ad arco analoghi a
quelli della sonata a tre e
l'altra formata dal
complesso degli strumenti ad
arco in uso all'epoca, ossia
violini, viole, violoncelli,
talvolta contrabbassi, oltre
allo strumento a tastiera
necessario a realizzare il
basso continuo; in secondo
luogo, l'andamento del
concerto grosso è regolato,
all'interno di ogni sezione
o movimento, dall'alternarsi
di episodi musicali fra il
piccolo gruppo di strumenti,
detto “concertino”, e il
complesso, chiamato “tutti”.
Gli episodi sono distribuiti
in modo tale che il
concertino propone materiali
nuovi o variati in maniera
virtuosistica, mentre il
tutti tende a ripetere le
stesse idee musicali per
sottolineare la differenza
tra le due sezioni
strumentali e far risaltare
la “bravura” del concertino;
inoltre, l`alternanza fra
concertino e tutti delinea
una differenza di spessori
sonori tra “piano” e
“forte”, spesso paragonata
ai “pieni” e ai “vuoti”
dell'architettura barocca.
L'esempio quasi da manuale
di queste regole sono
proprio i dodici Concerti
grossi op. 6 di
Corelli, dei quali qui
ascoltiamo il terzo. Il Concerto
grosso op. 6 n. 3 in do
minore inizia con un
tempo lento e maestoso, che
fa esporre il tema a tutta
l'orchestra. Durante lo
svolgimento, che predilige
suoni compatti e sonorità
rotonde, il gruppo del
concertino a tratti si
stacca, mettendo in evidenza
l'intreccio dei due violini
e del violoncello, ai quali
viene regolarmente
contrapposta tutta
l'orchestra. Il secondo
tempo è invece veloce, ma
mantiene intatte le
caratteristiche di
alternanza fra soli e tutti.
Il terzo tempo ha una breve
introduzione lenta, a
struttura fugata, con gli
archi che entrano, uno dopo
l'altro, a formare a poco a
poco una
stratificazione densissima
di suono che, sul finale, è
sostenuto da tutta
l'orchestra, ma su un
accordo sospeso. La
soluzione arriva subito,
insieme al cambio repentino
in un tempo veloce:
l'effetto di domanda e
risposta, di eco fra
concertino e tutti si fa
immediatamente sentire in
una successione di
interventi incalzanti e
incisivi, sottolineati da
scansioni ritmiche veloci.
L'ultimo tempo vede esordire
i due violini in un effetto
di rincorsa o imitazione, in
cui si inserisce a tratti
tutta l'orchestra, come per
tracciare un commento, una
sottolineatura del serrato
dialogo tra i due strumenti
solisti, che emergono sempre
dal resto del gruppo.
Secondo un ordine
cronologico, al concerto di
Corelli segue il Concerto
grosso op. 1 n. 4 in fa
maggiore di Benedetto
Marcello, che venne scritto
nel 1708, quindi nel periodo
di piena fioritura di questo
genere di composizione.
Anche il concerto di
Marcello è suddiviso in
quattro tempi, due lenti e
due veloci, quasi a
confermare che il nobile
veneziano seguì con
attenzione le tracce segnate
in questo campo da Corelli.
ll primo tempo del Concerto
grosso n. 4 ha un
andamento maestoso e
andante, un inizio a tutta
orchestra che a tratti è
all'unisono, a tratti si
divide in due parti: mentre
alcuni strumenti tracciano
note lunghe
d'accompagnamento, altri
eseguono il tema, molto
semplice sia melodicamente
sia ritmicamente. Il secondo
tempo è veloce, e inizia con
un tema grazioso e incisivo,
eseguito prima dal
violoncello, poi dal violino
e, infine, dagli archi e dal
clavicembalo; a questo
gruppo di strumenti si
contrappone poi l'orchestra,
e si prosegue così sino al
finale, maestoso e in
rallentando. Il terzo tempo
è, invece, lento e
caratterizzato da sonorità
tenui; il protagonista ne è
il violino, che mantiene una
linea melodica molto
cantabile e dolce con
l'accompagnamento di tutta
l'orchestra. L'ultimo tempo
ha come protagonisti la
viola e il violino, che si
intrecciano nell`esposizione
e nell'elaborazione
tematica, interrotta,
sottolineata e accompagnata
dal resto degli strumenti
dell'orchestra.
Segue questa traccia anche
il Concerto grosso in re
maggiore op. 3 n. 9 di
Francesco Manfredini,
composto nel 1718. Simile è
la struttura, simile
l'alternanza tra il gruppo
dei solisti (formato da
violino, viola e basso
continuo) e tutto il gruppo
orchestrale, simile il
succedersi dei tempi lenti e
di quelli veloci. Il genere
reso famoso da Corelli è
ormai di moda e imitarlo
diventa un obbligo per quasi
tutti i musicisti e,
soprattuto, per coloro che,
come Manfredini, intendevano
far conoscere, durante i
viaggi all'estero, le novità
dei grandi compositori
italiani.
L'altro esempio qui proposto
di concerto grosso
appartiene a Francesco
Geminiani, che, avendo
studiato con Corelli,
apprese evidentemente
dalmaestro l'arte di
comporre i concerti grossi.
Geminiani scrisse il Concerto
grosso op. 3 n. 2 in sol
minore nel 1732, molti
anni dopo la morte di
Corelli e quando ormai si
era da tempo stabilito a
Londra, dove raccoglieva
unnotevole successo. Anche
in questo caso, l'esordio è
lento e breve, quasi
un'introduzione, maestoso e
caratterizzato da suoni
molto lunghi. Il dualismo
fra il violino e il
violoncello e il resto
dell'orchestra si dipana poi
dallaprecedente compattezza.
Il violino inizia quindi con
delle terze discendenti,
sulle quali si sviluppa il
tema; entra tutta
l'orchestra, poi i violini
riprendono il tema, dal
quale nasce il commento,
dolcissimo, di una viola,
seguitonuovamente
dall'intervento di tutta
l'orchestra. Conclude, come
sempre, il tempo veloce: ai
violini seguono, secondo la
tecnica dell'imitazione, le
viole, i violoncelli e poi
il resto degli strumenti,
sempre sulla struttura di
terze discendenti che aveva
caratterizzato il tempo
precedente; compare quindi
un ritornello e, infine, il
tema, ripreso dagli
strumenti solisti e poi da
tutti.
Senza data di composizione è
il brano di Alessandro
Scarlatti che qui
ascoltiamo. Il Concerto
in la minore fa parte
delle Dodici sinfoníe di
concerto grosso che il
musicista compose, secondo
un'indicazione
dell'autografo conservato al
British Museum di Londra, a
partire dal 1715. La sua
struttura è semplice,
affidata al solito organico
di strumenti ad arco con
clavicembalo, con la novità
dell'introduzione di un
flauto. Nel primo tempo, il
musicista sviluppa molto
bene il dialogo tra flauto e
violino, accompagnati con
semplicità e garbo da tutta
l'orchestra. Nel secondo
tempo emerge invece il
violino, che intreccia con
violoncello e clavicembalo
un dialogo dal sapore
lirico. Il tema è poi
brevemente ripreso dal
flauto e dal violino in
stretta alternanza, fino
all'accordo finale sospeso,
che risolve sull'inizio del
terzo tempo. Qui la
struttura è fugata, con i
temi che continuano a
intrecciarsi fra i tre
strumenti protagonisti
durante l'elaborazione,
freschissima e gradevole,
sino all'arrivo della
stretta finale che, iniziata
dalviolino, viene poi
continuata da viola, flauto
e cembalo e conclude con un
grande accordo finale. Molto
delicati sono anche i due
ultimi tempi, il primo lento
e l'ultimo veloce, in cui
Scarlatti fa cantare e
dialogare gli strumenti con
una semplicità,
un'eloquenza,
un'espressività
incredibilmente suggestive e
calde.
Mariangela
Mianíti
|
|
|
|
|
|