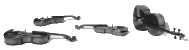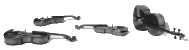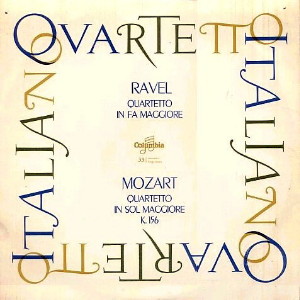 |
|
1 LP -
33QCX 10381 - (p) 1960
|
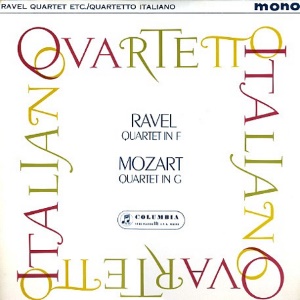 |
| 1 LP -
33CX 1727 - (p) 12/1960 |
 |
| 1 LP -
35732 - (p) 1960 |
|
| Maurice
RAVEL (1875-1937) |
|
|
|
| Quartetto in fa
maggiore |
|
30' 54" |
|
| -
Allegro moderato |
9' 09" |
|
|
| -
Assai vivo |
6' 50" |
|
|
-
Molto lento
|
9' 09" |
|
|
|
|
|
|
| -
Vivo e agitato |
5' 46" |
|
|
|
|
|
|
| Wolfgang
Amadeus MOZART
(1756-1791) |
|
|
|
| Quartetto
in sol maggiore, K. 156 |
|
15' 12" |
|
| - Presto |
3' 20" |
|
|
| - Adagio |
7' 18" |
|
|
| - Minuetto
e Trio |
4' 34" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Milano
(Italia) - novembre 1959 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10381 - (1 LP) -
durata 46' 06" - (p) 1960 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1727 - durata 46' 06" - (p) 1960 -
Mono
Angel Records (USA) - 35732 -
durata 46' 06" - (p) 1960 - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
Il Presente
Quartetto fa parte di una
collana di sei, composti da
Mozart
durante il suo terzo viaggio in
Italia; viaggio che lo condusse
a Milano
per musicare e mettere in iscena
l'opera Lucio Silla, commessagli
l'anno
prima dai sovraintendenti al
Teatro Ducale. Il terzo
soggiorno nella terra
di Scarlatti, di Vivaldi, di
Tartini, di Pugnani, di
Locatelli, di Galuppi,
di Sammartini, rivelò
decisamente al giovane
salisburghese lo spirito
della musica italiana e coronò
in maniera definitiva le
esperienze
già da lui acquisite a Londra
attraverso i contatti con
l'italianizzante
Christian Bach, con Felice
Giardini, con Pier Domenico
Paradisi e poi approfondite
durante le "calate" a Milano, a
Bologna, a Roma, a Napoli, fra
il 1769
e 1771. Più che nel campo del
melodramma dove tutti, in fondo,
scrivevano
allora "all'italiana",
l'influsso latino diventò palese
nel campo
della musica istrumentale, nelle
Sinfonie, nelle Sonate da
chiesa, nelle
Sonate per clavicembalo, nei
Divertimenti e nei Quartetti.
Una nuova luminosità,
una nuova grazia, una nuova
snellezza ed armonia di forme
apparvero a fianco
della nativa, inesauribile
fantasia e le conferirono uno
slancio più
ardito e sicuro.
Dal punto di vista strettamente
tecnico, il piacere di certe
cadenze
ornamentali, la tenerezza delle
linee melodiche e l'uso di un
contrappunto
libero, sinuoso ma estremamente
leggero, si aggiunsero ai valori
già
in atto. Del resto fu proprio in
Italia, ed esattamente a Lodi,
durante
una sosta della diligenza, che
il prodigioso ragazzo aveva
scritto il suo
primo Quartetto per archi,
nell'anno 1770; ed è in Italia
ch'egli
aggiunse, a quel primissimo
saggio, la serie di cui parlammo
in principio.
A voler esser giusti, il genere
quartettistico era praticato
allora
più all'estero che non nella
nostra penisola così, la
decisione
di Mozart ebbe un po' l'aria di
voler immettere in una forma non
particolarmente
italiana gli andamenti e, più
ancora, il genio segreto della
musica
italiana. Ebbe l'aria di voler
esporre a nuova luce le
conquiste tecniche
e estetiche di Tartini, di
Locatelli, di Giardini, di
Giovan Battista Sammartini.
Il primo Quartetto di tutto il
gruppo venne creato in
circostanze quasi
identiche a quello che videro
nascere lo storico Quartetto di
Lodi; venne
fuori, cio è dire, a Bolzano o a
Verona, come mezzo ideale per
passare
il tempo fra una coincidenza e
l'altra delle cosidette "sedie
postali".
Il secondo, quello in sol K.156,
vide invece la luce a Milano o
nella campagna
milanese, mentre le prove del
Lucia Silla andavano per le
lunghe e il maestrino,
durante la giornata, aveva molte
ore libere da impiegare in altri
lavori.
Codesto Quartetto, al pari dei
suoi confratelli, è suddiviso in
tre soli "movimenti" e, secondo
una formula assai praticata
dagli italiani,
(Sammartini in testa) terminò
con un Tempo di menuetto anzichè
con un Allegro più o meno
condotto secondo lo schema di
Rondò.
L'Adagio (e anche questo
particolare si ricollega con un
procedimento caro
ai maestri d'Italia) si presenta
nel mi minore, ossia nel
somigliante minore
di sol maggiore. Pieno di vita,
spumeggiante di felicità
giovanile
è il Presto iniziale; dove
campeggiano tre idee
fondamentali, più
un'idea di coda, le quali, più
che concatenarsi fra loro
attraverso
"sviluppi" e genuinazioni di
incisi tematici, si susseguono
secondo l'impulso
della libera fantasia. Solo alla
"seconda idea" Mozart imprime
qualche
evoluzione, mostrando così, di
voler attenersi alle
consuetudini
degli autori italiani, quasi
sempre più attratti dal secondo
che
non dal primo tema.
Naturalmente, ciò che più conta
sono
l'invenzione e l'accento del
pezzo, quel suo passo franco e
gaudioso, quella
sua eloquenza rapida e
trillante. L'Adagio, quasi
intieramente cantato
dal primo violino dall'inizio
alla fine, richiama un po'
l'arcata sostenuta
di certe Arie d'opera seria
italiana, ma ha un patetismo suo
personalissimo,
meraviglioso quando lo si
riferisca ad un ragazzo di
sedici anni. Il Tempo
di Menuetto consta in realtà di
due Minuetti, l'uno in maggiore
e l'altro in minore, con ripresa
finale del primo. Anche in
simile struttura
e, piu ancora, nella condotta di
tutto l'insieme, dove
l'abbandono melodico
predomina in confronto
all'incisività ritmica, noi
possiamo riconoscere
un segno ulteriore
dell'influenza italiana.
··········
Il Quartetto per archi
fu la prima composizione di
Ravel che fece convergere
l'attenzione del mondo
musicale sul giovane maestro
di Ciboure. Presentata
al pubblico della Société
Nationale di Parigi il 5 marzo
1904, l'opera ottenne un
grande successo e Debussy
scrisse subito all'autore:
"Nel nome degli dei della
musica ed in nome mio proprio,
La supplico di
non cambiare una sola nota nel
Suo Quartetto". L'autore
medesimo, giunto,
al
colmo del magistero tecnico e
arricchito di infinite
esperienze, predilesse
sempre il Quartetto per la sua
freschezza d'invenzione e la
sua giovanile
tenerezza.
Eppure, un lavoro così
palpitante, così felice nel
suo
sviluppo e nel suo modo di
discorrere, venne scritto
quando l'autore si
trovava ancora al
Conservatorio di Parigi,
allievo di composizione nella
classe di Gabriel Fauré. E'
anzi noto che il primo
"tempo", l'Allegro
moderato, presentato da Ravel
in una sessione d'esami,
ottenne da un giudice
la classificazione "pénible" e
dal direttore del
Conservatorio,
Théodore Dubois, l'appunto
"manca di semplicità e di
chiarezza".
Questo esito scolastico del
Quartetto, quest'esito così
poco favorevole
del giovane musicista, non fu
certo estraneo alla successiva
esclusione
di Ravel dai cosidetti "Premi
di Roma".
Magrado le inìziali traversie,
il Quartetto restò un
modello di spontaneità, un
esemplare di buona scrittura
in tutta
la produzione del grande
maestro e mostrò di contenere
già
in nuce tutte le
caratteristiche della sua
originale personalità.
In primo luogo, quel nuovo
"senso modale" che, pur senza
sovvertire la
tradizione di tonalità
maggiore e minore, toglie
spesse volte alla
tonica e alla cadenza di
tonica la loro perentorietà,
la loro rigida
alternativa e vi sostituisce,
se così possiamo dire, un
aggiornamento
di conclusioni definitive e
troppo categoriche. In secondo
luogo, un gusto
dei timbri più sottile di
quanto non si avesse prima;
specie in
riguardo agli strumenti più
gravi (la viola ed il
violoncello) che
assai frequentemente si
spingono nel registro
acutissimo, provocando
un'impressione
di intensità quasi morbosa,
l'ìmpressione di trovarci
sopra
un limite non ancora
oltrepassabile. Con tutto
questo, nel Quartetto in
fa non c'è nulla che non sia
immediatamente percepibile,
che non
risulti terso, che non
concreti subito e senz'ombra
di dubbi le intenzioni
del creatore. Sotto tale puntu
di vista, potremmo dire che si
tratti di
un prodotto mozartiano.
Il primo "tempo", condotto
secondo il diagramma del
classico Allegro
di Sonata, consta, così, di
due temi principali; entrambi,
però,
affini per l'affettuosità, il
calore e, insieme, la serenità
dell'accento. Come spesso
avviene nella musica di Ravel,
la grazia un poco
languida, un poco capricciosa
e infantìle è percossa, qua
e là, da folate rabbrividenti:
ombre o incertezze che passano
sopra
un cielo chiaro e pulito. Il
secondo "tempo" (Très rhytmé)
ci mette avanti un Ravel
innamorato della danza come
tutti i figli della
razza basca cui egli
apparteneva. Codesta specie di
scherzo, alterna un
movimento tambureggiante,
ottenuto con il pizzicato di
tutti quattro gli
istrumenti, a un movimento più
espansivo cantabile,
preferibilmente
scambiato fra il primo violino
e la viola. Nel centro del
pezzo troviamo
un istante di raccoglimento
pensoso: una pausa fra tanta
vivacità,
segnata da armonie cromatiche
e da interiezioni melodiche
del violoncello
e della viola. Nel terzo
"movimento" (Très lent)
emergono il lirismo
e la malinconia dei maestro,
uniti al suo nostalgico
desiderio di qualcosa
remoto ed arcaico, profumi,
ormai spenti, di età non mai
conosciute,
ma vagheggiate nella fantasia
come consolazione e
liberazione. Il finale
(Vil et agité) è tutto tenuto
nell'inconsueto ritmo
quinario,
tranne quando si presenta la
seconda idea, annunciata e
brevemente sviluppata
in "tre quarti". Rapido,
anelante, estremamente mobile
per l'impiego assiduo
del "tremolo", questo
"movimento" corre via con
l'incanto, la labilità,
l'umore un po' instabile dei
mattini di primavera.
Giulio
Confalonieri
|
|