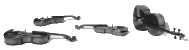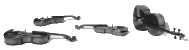|
|
1 LP -
33QCX 10219 - (p) 1957
|
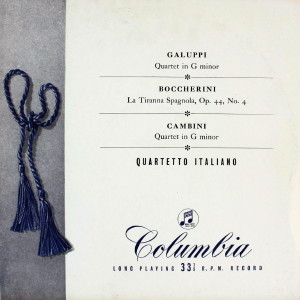 |
| 1 LP -
33CX 1408 - (p) 02/1957 |
 |
| 1 LP -
45001 - (p) 1957 |
|
| IL QUARTETTO
D'ARCHI IN ITALIA NEL XVIII SECOLO |
|
|
|
|
|
|
|
| Baldassare GALUPPI
(1706-1785) |
|
|
|
| Quartetto n. 1 in
sol minore |
|
13' 28" |
|
-
Grave e adagio
|
3' 48" |
|
|
| -
Spiritoso |
4' 18" |
|
|
| -
Allegro |
5' 22" |
|
|
|
|
|
|
| Luigi BOCCHERINI
(1743-1805) |
|
|
|
| Quartetto
in sol maggiore "La Tiranna", Op.
44 n. 4 (G 223) |
|
10' 39" |
|
| -
Presto |
4' 48" |
|
|
-
Tempo di minuetto
|
5' 51" |
|
|
|
|
|
|
| Giuseppe Maria CAMBINI
(1746-1825) |
|
|
|
| Quartetto
n. 2 in sol minore |
|
20' 54" |
|
- Allegro affettuoso
|
8' 30" |
|
|
| - Adagio |
6' 37" |
|
|
| - Presto |
5' 47" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Basilica
di Sant'Eufemia, Milano (Italia) -
1956 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10219 - (1 LP) -
durata 45' 01" - (p) 1957 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1408 - durata 45' 01" - (p) 1957 -
Mono
Angel Records (USA) - 45001 -
durata 45' 01" - (p) 1957 - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
La carriera di
compositore di Baldassarre
Galuppi detto Buranello è
essenzialmente compresa nelle
112 opere da lui scritte su
commissione dei teatri di tutta
Europa, per cui ne ebbe una fama
e un successo che molti
musicisti suoi contemporanei
dovettero invidiargli. Fosse
stato per la musica strumentale,
tali onori e relativi utili il
Buranello non li avrebbe certo
conosciuti: e tuttavia, sarebbe
errato trascurare il significato
oltre che il valore poetico vero
e proprio, che in più di
un'occasione assume la
produzione per così dire
"minore" (almeno in cifre di
quantità) di questo artista. Si
pensi soltanto all'emozione che
in Robert Browing destò una sua
Toccata. Il Browing ne
descrisse, quasi per battuta, le
reazioni sentimentali e
fantastiche provocategli,
lasciandoci una pagina singolare
e suggestiva che più facilmente
crederemmo scritta per un pezzo
romantico anzichè per il
disincantato eloquio del
Buranello.
Nello stesso quartetto che
compare in questa incisione, del
resto, troviamo una serie di
motivazioni interessanti e
creativamente validissime che
non sono solo di carattere
stilistico. Sotto questo
particolare aspetto, va
certamente rilevata la fusione,
l'equilibrio fra la polifonia e
l'omofonia, che è poi un'osmosi
a cui tutta la musica italiana
ha guardato nel '700 con
crescente volontà realizzatrice,
e che va intesa come la sintesi
di una naturale attitudine
melodica, di canto, con le
crescenti esigenze di più
complesse e costruite
articolazioni del discorso
musicale. Oltre a ciò, sempre
sotto il profilo stilistico,
assume significato, perchè
tipico del Galuppi strumentale,
il mantenimento della medesima
tonalità per i tre tempi; nonchè
particolare la disposizione di
questi che ad un movimento lento
a carattere di fantasia, fanno
seguito due movimenti veloci,
vivi, palesamente e volutamente
contrastanti.
C'è però qualcosa di più da
reperire al di là dei valori
formali di chiarezza, di
linearità, di semplicità
armonica del Galuppi: ed è la
presenza del musicista di teatro
anche in un quartetto o in una
toccata, il suo saper dire le
cose che sente, la capacità di
narrare, di dialogare, di
esprimere stati d'animo diversi.
Galuppi, nato a Burano nel 1706
e morto a Venezia nel 1785, per
quanto vissuto per alcuni anni
in Inghilterra e poi in Russia,
tuttavia fu compositore che
affondò la sua personalità nella
Venezia di Goldoni (col quale
ebbe a collaborare in più
occasioni), dei Gozzi, di
Longhi, di Guardi: e di questa
Venezia, anche nel Quartetto in
do minore, sentiamo pesantissimo
il gesto, il costume, il
rapporto (spesso convenzionale e
artificioso) fra l'artista e il
pubblico (che specie alla musica
chiedeva larghe concessioni al
"rococò", al "galante"). Ma
sentiamo anche che alla sostanza
- pur tuttavia non toccando
certe vette di verità universale
come in Goldoni, ossia non
arrivando a superare una
determinata condizione
obbiettiva ambientale per
piegarla alle esigenze di un
discorso coinvolgente l'intiera
umanità -, sentiamo dunque che
v'è l'artista capace di
cogliere, nella leggiadria e
nella vaghezza delle forme
richiestegli, i tratti ideali di
una società sempre più chiusa
nei propri compiacimenti
aristocratici. Ossia troviamo
nella sua musica la descrizione
di un mondo oramai incline agli
estetismi, alla ageografia di sè
stesso, pago dei traguardi di
benessere e splendore raggiunti,
e perciostesso sul limitare del
proprio disfacimento.
E che in un lavoro strumentale
sia rintracciabile così
puntualmente una situazione
sociale e culturale ben
determinata, è di per sè titolo
sufficiente di legittimità
artistica e quindi di piena
cittadinanza in un'antologia del
quartetto italiano nel '700.
La
scelta del lavoro boccheriniano
compiuta per questa incisione,
ha tutto il sapore di una
preziosità filologica quanto mai
benemerita per la diffusione e
la conoscenza del grande maestro
lucchese. Dei Sei quartettini
che compongono infatti l'inedita
op.44, è stato scelto il 4° il
cui primo tempo, segnato presto,
porta come sottotitolo "la
Tiranna", cioè l'indicazione di
una danza spagnola sul cui ritmo
il movimento appunto si
costruisce. Boccherini, vissuto
a lungo in Spagna alla Corte di
Madrid, trasse in ripetute
occasioni ispirazioni dal
materiale musicale popolare
iberico, e il testuale
riferimento che qui viene
compiuto ne è una conferma e
un'indicazione significative.
Non bisogna dimenticare che uno
dei primi e più acuti studiosi
di Luigi Boccherini, Maurice
Cristal, scriveva su una rivista
francese (Ménestrel 29 agosto
1875), che "Boccherini è il
ritratto musicale della Spagna",
e che nella sua musica scorre
continuo "il carattere tipico
degli antichi ritmi spagnoli e
l'impressione ora sensuale ora
appassionata ed ora dolorosa, e
talvolta terribile, della musica
atoctona della penisola". Ne La
Tiranna, questa fisionomia
boccheriniana certamente
inacettabile se estesa a tutta
quanta la sua produzione
immensa, ma attendibilissima se
riferita a una pur notevole
quantità di sue opere, è
particolarmente evidente. Almeno
si tende nel primo movimento di
questo Quartetto: il quale,
scritto nel 1792, si compone
soltanto di due tempi, il
secondo essendo però un Minuetto
dagli scarsi legami espressivi
con il primo, ed evidentemente
destinato a far corpo in
un'opera più vasta, in quattro
tempi, poi rimasta incompiuta.
Nel 1792, infatti, Boccherini
era già giunto alla successione
classica dei quattro movimenti
Allegro, Adagio, Minuetto e
Allegro, che ritroviamo anche in
Haydn, in Mozart e insomma nel
quartetto formalmente maturato
del '700. Boccherini
(1743-1805), scrisse in tutto 92
quartetti offrendo un contributo
fondamentale alla definitiva
sistemazione delle
caratteristiche strutturali e
formali di questo generere
cameristico. Non va infatti
dimenticato che ancora oggi la
musicologia disputa se tocchi ad
Haydn o a Boccherini la priorità
dell'invenzione del quartetto
per archi come complesso di
parti contrappuntisticamente
indipendenti, laddove fino ad
allora il violoncello fungeva da
basso continuo soltanto e la
viola suonava per lo più
all'unisono con esso.
Quartettista
insigne e famoso fu Giovanni
Giuseppe Cambini, cui toccò fra
l'altro l'onore postumo, ad
opera dei musicologi, di essere
scambiato in più di un quartetto
o quintetto, con il Boccherini.
Cambini ebbe vita avventurosa ed
agitata, almeno negli anni della
giovinezza. Nato a Livorno nel
1746, intraprese gli studi
musicali col Padre Martini a
Bologna, portandoli a termine
fra il '63 e il '66. Catturato
dai pirati durante un viaggio
per mare, fu venduto come
schiavo in Barberia.
Fortunatamente acquistato da un
mercante veneziano, venne da
questi liberato in
riconoscimento dei suoi meriti
artistici. Si trasferì nel '70 a
Parigi, e di qui ebbe inizio la
sua fortuna di compositore e di
esecutore (era violinista di
prima qualità). Le sue Sinfonie
(ne scrisse 60) e i suoi
Quartetti (ammontano a 144)
ebbero subito un successo
strepitoso. Manfredi, Nardini e
Boccherini stesso, vollero
suonare con lui. Fu direttore
del teatro di Beaujolais e
svolse pure attività di
scrittore. Morì a Parigi quasi
ottantenne, nel 1825, circondato
dall'affetto e dall'ammirazione
della città che lo aveva
raccolto e innalzato alla
gloria. I suoi quartetti, per
quanto molti portino le date
della stagione romantica,
risentono maggiormente della
"clarté" settecentesca che degli
impeti del primo '800. Tuttavia
troviamo in essi. e in specie
nel Quartetto in sol minnore
compreso nell'incisione, quella
disposizione sentimentale sempre
incline ai repentini mutamenti
di stati d'animo, che già in Boccherini
significava un distacco dal
convenzionaliamo "galante", e
che in lui è ancor più
evidentemente in rapporto con le
nuove esigenze di espressione
umana, non certo estranee alla
stessa Francia pur passata
attraverso la raggelante
esperienza dell'arte
napoleonica.
Luigi
Pestalozza
|
|