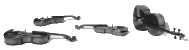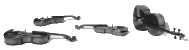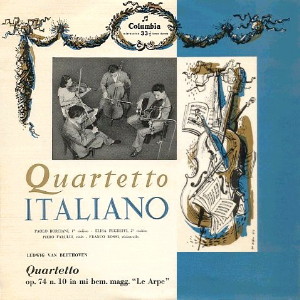 |
|
1 LP -
33QCX 10209 - (p) 1956
|
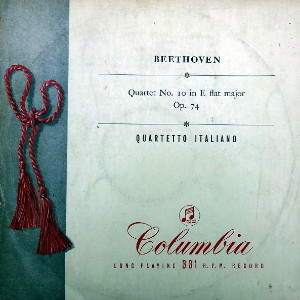 |
| 1 LP -
33CX 1396 - (p) 11/1956 |
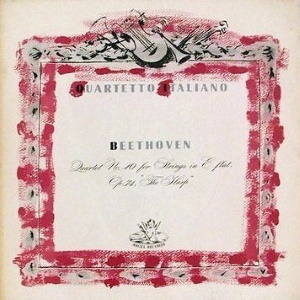 |
| 1 LP -
35367 - (p) 1956 |
|
| Ludwig
van BEETHOVEN (1770-1827) |
|
|
|
| Quartetto n. 10
in mi bemolle maggiore "Le Arpe",
Op. 74 |
|
35' 27" |
|
-
Poco adagio - Allegro
|
10' 29" |
|
|
-
Adagio, ma non troppo
|
11' 41" |
|
|
|
|
|
|
| - Presto |
6' 12" |
|
|
| - Allegro con
Variazioni 1-6 |
7' 05" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Basilica
di Sant'Eufemia, Milano (Italia) -
giugno 1956 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10209 - (1 LP) -
durata 35' 27" - (p) 1956 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1396 - durata 35' 27" - (p) 1956 -
Mono
Angel Records (USA) - 35367 -
durata 35' 27" - (p) 1956 - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
Ludwig van
Beethoven (1770-1827) affrontò
la forma quartettistica quando
già aveva alle spalle una
sinfonia, dei concerti, delle
sonate, dei trii ed anche musica
di chiesa e di teatro: in realtà
Beethoven aveva esitato parecchi
anni prima di provarsi nella
composizione di un quartetto,
una forma strumentale di cui
conosceva bene le estreme
difficoltà, l'esigenza di
un'assoluta padronanza del
contrappunto onde potersi
muovere nello scarno tessuto
determinato dai quattro archi
con la capacità di attribuire a
ciascuno di essi una precisa e
autonoma personalità
nell'rticolazione del dialogo
polifonico. "Con esso (il
quartetto) non sono ancora in
grado di cimentarmi", aveva
scritto senza falsi pudori
all'amico Amanda, e quando nel
1795 il conte Apponyi gliene
aveva ordinato uno, assolse
senz'altro la commissione...
scrivendo un trio! Beethoven. lo
ripeterà più volte nei primi
anni della sua attività, voleva
essere ben certo di non avere
più nulla dell'allievo prima di
affrontare la forma
quartettistica. E non a caso il
timore e il rispetto che per
tanto tempo rivolse ad essa, gli
varrà in vecchiaia, e pensiamo
agli anni prodigiosi dal 1824 al
1826 rischiarati dalla luce dei
cinque ultimi quartetti, di
affidare ad essa le più alte,
intime, profonde e sofferte
confessioni della sua grande
anima. Beethoven pubblicò nel
1801 i Sei Quartetti op.18 che
aveva composto nei due anni
precedenti. Siamo, con essi,
nello stile haydniano e in
quello mozartiano,
formalisticamente assunti come
guida nella nuova esperienza.
"Freschi e giovani, spensierati
e sorridenti", sono stati detti:
questa prima prova beethoveniana
è però caratterizzata da
un'ancora incerta osmosi fra il
trattamento della forma e
l'espressione attraverso essa
delle proprie interne
alternative. In effetti già
allora pesavano su Beethoven le
istanze romantiche, e ben
diversi erano i fattori storici,
ideali, culturali - rispetto a
quelli, poniamo, di un Haydn -
entro i quali veniva maturando
la sua personalità. Ma era
comprensibile che accingendosi
alla composizione in generale,
egli, giovane ancora, si
trovasse indotto soprattutto a
mutuare dai maestri l'evidenza
di superficie delle loro opere,
prima di trasformare la materia
musicale ad immagine del proprio
spirito, delle proprie idee e
sentimenti. Così per il
Beethoven dell'op.18, l'oramai
raggiunta coscienza dei mezzi
strumentali (il trattamento del
complesso quartettistico), non
significa ancora andare oltre un
convenzionalismo senza grande
pretese di significati. semmai
tralucere in rapide impennate la
presenza di un nuovo mondo
poetico.
Ben diversa si presenta, a
distanza di appena otto anni, la
situazione in cui nasce il
Quartetto in mi bomolle maggiore
op.74, detto "delle arpe".
Beethoven, nel 1809 ha oramai
vissuto la stagione artistica
dell'"espressione eroica", una
stagione feconda di capolavori
eccelsi in ogni genere musicale.
Durante quegli otto anni, la
piena coscienza e adesione ad
una nuova epoca che entrava
nella storia sulla punta della
spada napoleonica, aveva
significato per l'artista la
scoperta di nuovi rapporti umani
e artistici e musicali: che la
delusione degli ideali non farà
rinnegare, bensì priverà
soltanto dell'erompente bisogno
di estroversione, volgendo il
musicista ai processi di
interiorizzazione che
domineranno nella sua "terza
maniera". Nel genere
quartettistico, la "espressone
eroica" aveva significato la
volontà di dilatare le
possibilità sonore dello
strumentale cameristico fino
alla vigoria e alla pienezza
dell'orchestra. Il Quartetto in
do magg. op.59, chiamato anche
l'"eroico", che precede
immediatamente l'op.74,
costituisce il punto limite
raggiunto in questa direzione:
ciò che gli è specifico, dice
infatti il Chantavoin, "è
l'imitazione dell'orchestra e la
potenza sonora alla quale
pervengono le quattro voci, di
solito così deboli, del
quartetto ». "Dopo di ciò -
aggiunge il Mila - non rimaneva
che l'approfondimento
individuale della vita
interiore"; e prosegue: "I due
Quartetti che seguono (op.74 e
op.75), benchè scritti ancora
alla cosidetta seconda maniera,
sono da considerarsi soprattutto
come una preparazione all'ultima
trascendente espressione
beethoveniana. La straordinaria
plasticità formale,
l'oggettivazione evidente del
pensiero musicale e le
aspirazioni sinfoniche a una
sonorità orchestrale, cedono il
posto a un'esatta corrispondenza
del pensiero musicale, fatto più
intimo e capillare alla sonorità
propria dei quattro archi ".
Detto "delle arpe" per i
passaggi di pizzicati che
ricorrono nel primo movimento e
che ricordano quegli strumenti,
il Quartetto in mi bemolle
maggiore op.74 si apre con una
"Introduzione" (segnata "Poco
adagio"), pensosa e
vigorosamente contenuta in
un'intensa emozione. Essa
conduce dopo 19 battute,
attraverso un'espressiva
progressione cromatica,
all"Allegro" caratterizzato da
una bella vivacità di ideee
melodiche e di figurazioni
ritmiche che gli imprimono una
dinamica non di superficiale
compiacenza discorsiva, ma
palesemente partecipe di un
preciso retroscena ideale e
sentimentale, quale del resto a
poco a poco si svela nel corso
della composizione. E' durante
lo sviluppo, che interviene per
la prima volta il singolare
passaggio di arpeggi pizzicati,
dal violoncello alla viola al
secondo violino su lunghe note
tenute dal primo violino, che dà
il nome a questo Quartetto.
L'"Adagio ma non troppo"
seguente, è in forma di lied, ed
è una pagina di altezza degna
degli ultimi Quartetti
beethoveniani. L'intensità
meditativa di due temi che
intervengono per primi, è
soltanto attenuata dalla
dolcezza della terza idea che
viene a dare a questo movimento
una continua sensazione di
produzione melodica nel disegno
di un approfondimento
sentimentale condotto alla
scoperta di intime e dolorose
verità. Subito dopo, il "Presto"
è un tipico Scherzo
beethoveniano, ricco di
vivacità, di idee, di
ispirazione, e condotto
naturalmente con estrema
perizia: l'atmosfera è qui ben
diversa da quella dell'"Adagio",
però non tale da far parlare di
convenzione e di formalismo. Vi
è pur sempre una dialettica
musicale tutt'altro che fine a
se stessa. L'ultimo movimento,
un "Allegretto con variazioni",
è una pagina di strepitosa
grandezza. Su un tema a
carattere interrogativo di
efficace suggestione, si
svolgono sei variazioni ciascuna
conchiusa in una specifica
fisionomia e significato, che
poliedricamente svelano e danno
una risposta alla sospensione,
alla domanda, contenuta nel dato
tematico. E' il finale degno di
un grande artista che non si
accontentò mai di una visione
univoca della realtà, ma sempre
ne cercò la totalità attraverso
la conoscenza dei suoi diversi
aspetti. In un musicista come
Beethoven, in cui il dato
musicale è sempre un dato di
pensiero, di idee, la scelta
della forma variazione - a lui
del resto così cara -, non va
certo intesa come una scelta
determinata soltanto da
opportunismi formali, ma
evidentemente nata da un
atteggiamento mentale e
sentimentale legato al crescente
bisogno di ricercare in se
stesso, nelle cose degli uomini
e della natura, senza mai
arrestarsi alle prime
conclusioni raggiunte.
Luigi
Pestalozza
|
|