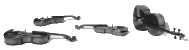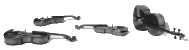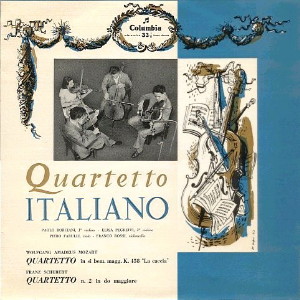 |
|
1 LP -
33QCX 10199 - (p) 1956
|
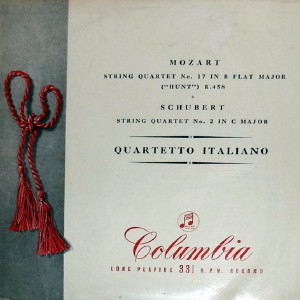 |
| 1 LP -
33CX 1367 - (p) 09/1956 |
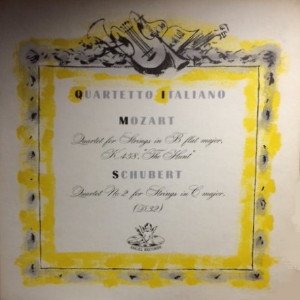 |
| 1 LP -
35351 - (p) 19xx |
|
| Wolfgang
Amadeus MOZART (1756-1791) |
|
|
|
| Quartetto n. 17
in si bemolle maggiore "La
Caccia", K. 458 |
|
25' 49" |
|
| -
Allegro vivace assai |
8' 30" |
|
|
| -
Menuetto |
4' 42" |
|
|
| -
Adagio |
7' 51" |
|
|
-
Allegro assai
|
4' 46" |
|
|
|
|
|
|
| Franz SCHUBERT
(1797-1828) |
|
|
|
Quartetto
n. 2 in do maggiore, D 32
|
|
18' 11" |
|
- Presto
|
3' 32" |
|
|
| -
Andante |
5' 31" |
|
|
| - Minuetto |
3' 11" |
|
|
| - Allegro con
spirito |
5' 56" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Milano
(Italia) - 1956 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10199 - (1 LP) -
durata 44' 00" - (p) 1956 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1367 - durata 44' 00" - (p) 1956 -
Mono
Angel Records (USA) - 35351 -
durata 44' 00" - (p) 19xx - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
E' nota la
centralità della figura di
Joseph Haydn nella storia
dell'evoluzione del quartetto
d'archi; Haydn introdusse nel
quartetto quel principio
dell'elaborazione tematica che i
predecessori non vi avevano
utilizzato, riconobbe cioè
appunto nel quartetto per archi
lo strumento più indicato ad
accogliere ed a sviluppare il
nuovo principio. Ne scrive Adolf
Scandberger (Zur Geschiclite des
Haydschen Streichquartetts):
"Finchè dominava come voce
principale il primo violino, il
secondo, la viola ed il
violoncello facevano
d'accompagnamento, in modo
interessante e vario, per vita
d'armonia e di ritmo, ma
accompagnavano. Questo
procedimento, anche al di fuori
delle parti tematicamente
elaborate, è approfondito,
altresì, dal lato di una
condotta indipendente delle
voci. Comincia così quel
dialogare musicale degli
strumenti che oggi andiamo
cercando come carattere tipico,
nei vari quartetti; lo stile
della fine conversazione, che il
Kretzschmar paragona allo stile
degli Enciclopedisti francesi,
prende possesso definitivo del
quartetto. In tale modo di
dialogare, nessuno può parlare
troppo a lungo; la dialettica
dei motivi è quella che conduce
questa conversazione; essa
concede la parola ad ognuno, ma
la sua deve essere al primo
posto. Al posto dell'amabile
schieramento dei pensieri
musicali si presenta ora la
rielaborazione organica dei
motivi. Così il quartetto è,
nello stesso tempo, omofono e
polifonico".
Giustamente dunque i
contemporanei individuarono in
Haydn il creatore del quartetto
d'archi moderno; giustamente
ancora il contemporaneo Mozart
volle dedicargli una serie di
sei quartetti, composti tra il
1782 ed il 1785, che vanno
appunto sotto il nome di
Quartetti dedicati ad Haydn. Il
Quartetto in si bemolle maggiore
K.458 è il quarto di tale serie.
La dedica, scritta da Mozart il
1° settembre 1785 dice: "Un
padre avendo risolto di mandare
i suoi figli nel gran mondo,
stimò di doverli affidare alla
protezione ed alla condotta di
un uomo celebre; il quale, per
buona sorte, era inoltre il suo
migliore amico. Ecco del pari,
celebre uomo ed amico carissimo,
i sei miei figli. Essi sono, è
vero, il frutto di una lunga
fatica, ma ho la speranza,
condivisa da molti amici, che mi
daranno un giorno qualche
consolazione. Tu stesso, amico
carissimo, nell'ultimo tuo
soggiorno in questa capitale, me
ne dimostrasti la tua
soddisfazione. Questo tuo
suffragio mi incoraggia sopra
ogni altro a raccomandarteli, e
mi fa sperare che non ti
sembreranno del tutto indegni
del tuo favore. Piacciati dunque
accoglierli benignamente ed
essere loro padre ed amico. Da
questo momento io ti cedo i miei
diritti sopra di essi, ti
supplico però di guardare con
indulgenza i difetti, che
l'occhio parziale di padre mi
puo aver celati, e di
continuare, loro malgrado, la
generosa tua amicizia a chi
tanto l'apprezza mentre sono di
tutto cuore il tuo sincerissimo
amico...".
Di fatto Haydn aveva avuto già
modo di ascoltare i nuovi
quartetti ed aveva in
quell'occasione riaffermato a
Leopoldo Mozart la sua infinita
ammirazione per il giovane
Wolfango "il più grande
compositore che io conosca di
persona e di nome".
Non tutti però condivisero gli
entusiasmi del dedicatario; il
Wiener Zeitung del gennaio del
1781 trovava ad esempio i 6
quartetti tanto drogati da
renderne impossibile l'ascolto,
dato il pur lodevole intento di
Mozart di voler divenire un
innovatore ad ogni costo; il
Dittersdorf si sentì
disorientato dalla "eccessiva
abbondanza di magnifiche idee";
il Sarti, per parte sua, deprecò
che barbari assolutamente privi
d'orecchio, continuassero a
scrivere musica. Ed è giusto
convenire che a quei tempi un
linguaggio quartettistico tanto
"costruito" poteva facilmente
riuscire difficile; si è già
detto della funzione innovatrice
di Haydn nella struttura del
quartetto: conviene chiarire che
i quartetti haydniani che
costituiscono il vero momento
della trasformazione, sono i sei
quartetti chiamati russi, che il
compositore portò a termine nel
1781, poco prima dunque che
questi quartetti mozartiani, che
gli furono dedicati, fossero
composti. Di qui dunque la
scarsa attitudine dei
contemporanei all'ascolto di
musiche di questo genere. Gli
sviluppi ottocenteschi dell'arte
del quartetto avrebbero
dimostrato la validità, anche
sul piano storico oltre che su
quello estetico, degli
orientamenti di Haydn e di
Mozart.
Quindici
quartetti per archi furono
composti da Schubert tra il 1812
ed il 1826, ma soltanto uno di
essi fu pubblicato in quel
periodo, vivente l'autore.
L'editore Peters pubblicò altri
nove quartetti prima del 1870,
ma soltanto nel 1890, quando
Breitkopf pubblicò l'edizione
completa delle musiche di
Schubert, apparvero tutti i
quindici quartetti.
Uno di essi però, quello
contrassegnato dal numero 2,
aveva soltanto, nell'edizione
completa di Breitkopf, due
tempi, un Presto e un Minuetto,
entrambi in do maggiore. Qualche
anno dopo, nel 1897, un'altra
parte del quartetto fu
pubblicata, nel cosiddetto
Revision-Bericht; si trattava
esattamente dell'ultima parte
del Finale (Allegro in do
minore); su tale pubblicazione
era scritto: "Schubert scrisse
il Primo tempo di questo
quartetto alla fine della
partitura del Kyrie in Re
minore. Alla fine del tempo vi
sono le parole Finis primae
partis. Gli altri tempi sono
stati scritti su fogli staccati.
Più tardi Schubert numerò i
tempi a matita. Evidentemente
uno di questi è scomparso e
manca inoltre l'esposizione del
Finale". Il quartetto era pur
sempre incompleto.
L'8 febbraio 1953, finalmente,
il quartetto è stato eseguito
nella sua interezza al Museo di
Storia Musicale di Stoccolma,
grazie al ritrovamento delle
parti mancanti nella raccolta di
manoscritti schubertiani di
proprietà del console Otto
Taussing a Malmö. Taussig., che
abitò a lungo a Praga prima di
trasferirsi in Svezia, dispone
oggi della più importante
raccolta privata di materiale
schubertiano.
Secondo quanto è scritto, in
articolo apparso su "Music and
Letters" (ottobre 1951), da
Maurice E. Brown, ("Recent
Schubert discoveries") il
quartetto fu probabilmente
consegnato da Schubert al suo
editore Diabelli; questa casa
passò in seguito ad altri
proprietari e nel 1876 si fuse
con la casa editrice Cranz di
Lipsia che aveva pure una
succursale a Bruxelles; dopo la
guerra, in seguito alla
divisione della casa tra vari
membri della famiglia Cranz, le
sedi di Vienna e di Bruxelles
vennero ad acquistare piena
autonornia, divenendo due ditte
diverse. La parte di materiali
di Schubert e di Diabelli
rimasta a Vienna fu sempre ben
conservata, mentre la parte
rimasta a Bruxelles fu dispersa.
Appunto da tale dispersione il
manoscritto del secondo tempo
del quartetto e dell'inizio
dell'ultimo tempo, giunse nelle
mani del Taussig. Il Quartetto
in do maggiore, fu composto da
Schubert all'età di quindici
anni.
Memo
Zambrini
|
|