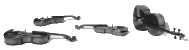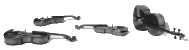|
|
1 LP -
33QCX 10164 - (p) 1956
|
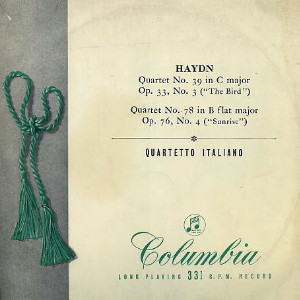 |
| 1 LP -
33CX 1383 - (p) 10/1956 |
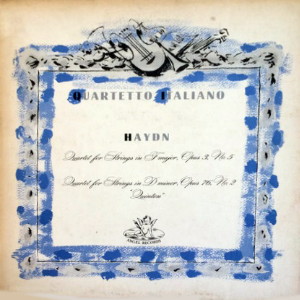 |
| 1 LP -
35185 - (p) 19xx |
|
| Franz
Joseph HAYDN (1732-1809) |
|
|
|
| Quartetto in do
maggiore, Op. 33 n. 3 (Hob.
III:39) |
|
20' 12" |
|
-
Allegro
moderato
|
7' 02" |
|
|
-
Scherzo
|
3' 03" |
|
|
| -
Adagio |
7' 05" |
|
|
| -
Finale
(Rondò) |
3' 02" |
|
|
|
|
|
|
| Quartetto
in si bemolle maggiore, Op. 76 n.
4 (Hob.
III:78) |
|
24' 44" |
|
- Allegro con spirito
|
8' 17" |
|
|
| -
Adagio |
6' 50" |
|
|
| - Minuetto |
5' 07" |
|
|
| - Finale (Allegro) |
4' 30" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Basilica
Sant'Eufemia, Milano (Italia) -
giugno 1954 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10164 - (1 LP) -
durata 44' 56" - (p) 1956 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1383 - durata 44' 56" - (p) 1956 -
Mono
Angel Records (USA) - 35185 -
durata 44' 56" - (p) 19xx - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
Nel secolo
scorso, quando si amavano tanto
le definizioni rette,
categoriche, e il forte spirito
scientifico cercava consolarsi
delle sue concretezze ammettendo
il miracolo e la creazione dal
nulla nel campo delle attività
spirituali, Franz Joseph Haydn
passava per "padre"
assoluto, unico, indecomponibile
della Sinfonia e del Quartetto
moderni. Oggidì, più estese
ricerche e maggior freddezza
nella considerazione dei fatti
storici hanno dimostrato che
Haydn, come tutti, ebbe i suoi
precursori, e che le due forme
dianzi nominate, queste due
forme così producenti lungo il
corso della musica europea fra
illuminismo settecentesco,
romanticismo ottocentesco e
vitalismo contemporaneo,
nacquero da una gestazione
lenta, frammentaria e condivisa
da autori di parecchie nazioni.
Ciò malgrado, resta un fatto ben
più importante che non quello
della "paternità" esclusivamente
carnale: resta che Franz Joseph
Haydn, musicista di genio, trovò
nella Sinfonia e nel Quartetto
il modo di espressione meglio
aderente alla sua personalità
originalissima; lo specchio
magico entro cui riflettere con
esattezza e far vivere, intiere,
le immagini del suo mondo
interiore. Mozart, che fra i
maestri del suo tempo fu
probabilmente il più ricco di
conoscenza in ogni genere di
musica e che durante i suoi
viaggi, entrò in contatto con le
opere di innumerevoli
compositori, tenne sempre Haydn
in conto di definitore, se non
inventore, delle nuove
concezioni quartettistiche e non
esitò a dire ed a scrivere che
"soltanto da Haydn aveva
imparato a fare un Quartetto".
E' innegabile che
simultaneamente al lavoro del
maestro austriaco, il nostro
Luigi Boccherini, confinato a
Madrid, procedesse per suo conto
alla formazione del Quartetto
moderno e vi portasse un
contributo di straordinario
valore. Ma è difficile stabilire
se quei due grandi esercitassero
uno sull'altro, influenze
formali marcate. Un fratello di
Boccherini era librettista
melodrammatico presso i teatri
viennesi all'epoca di Haydn ed è
possibile che possedesse e
facesse circolare copie dei
Quartetti di Luigi fra gli
amatori della capitale. Così
com'è possibile che il principe
Esterhazi, imparentato con la
nobiltà spagnola, propagandasse
oltre i Pirenei le composizioni
da camera del suo diletto e
stipendiato Franz Joseph.
Comunque sia, l'affermazione
mozartiana ci sembra fare il
punto della situazione. Fra
tanti Quartetti che si
scrivevano allora in Germania,
in Austria, in Francia, in
Italia (sì, anche in Italia, da
parte dei nostri grandi operisti
che ne avevano ritratto il gusto
durante i viaggi all'estero) fra
tanti Quartetti, quelli di Haydn
rappresentavano un'intuizione
profonda, elevavano il genere su
un piano singolare, si da
renderlo un qualcosa non
altrimenti esprimibile. La
psicologia haydniana, fatta di
cordiale attenzione verso le
cose esterne, verso i movimenti
e i gesti della vita umana; la
psicologia haydniana commista
d'ironia, di tenerezza e di
salubri energie, animata sempre
dal piacere del dibattito fra sè
e se stesso, dal senso di
disparità vocali e dal desiderio
di comporle, di armonizzarle,
differenza del più giovane
Mozart, visse fino alla
vecchiezza una vita sedentaria,
tutta spesa fra le campagne
feudali del suo aristocratico
padrone. A differenza di Mozart,
Haydn non subì sollecitazioni
così numerose, attraverso
incontri ed esperienze in
ambienti differentissimi di
mezza Europa. Si costruì da
solo, nel silenzio dell'anima e
in mezzo agli spettacoli di un
mondo rurale, la sua
meravigliosa parabola.
Incominciò a dettare Quartetti
ch'era ancor giovanissimo, senza
un piano preciso, ma piuttosto
rimpicciolendo in un complesso
esiguo le dimensioni ed i
caratteri del Divertimento,
della Serenata, della Suite per
orchestra, fin quasi, possiam
dire, al limite dell'esistenza.
A poco a poco, fondò un dominio
indipendente fra quei due
violini, quella viola, quel
violoncello; ne scrutò ogni
possibile rapporto, ogni
capacità di recezione e di
reazione; confidò loro tutte le
chimere, tutti i capricci, tutte
le certezze e i sottintesi della
sua fantasia. Il primo grande
blocco di Quartetti haydniani si
estende sino al 1772. Per dieci
anni il maestro, affascinato
dalle sirene dell'opera, cessò
dal comporne. Ma nel 1781 venne
fuori con i sei capolavori
dell'op.33 dedicati al Granduca
Paolo di Russia e quindi
conosciuti sotto il nome di
"Quartetti russi". Consapevole
di quanto aveva composto,
dichiarò francamente che
trattavasi di "una maniera
speciale e del tutto nuova". I
quattro dialoganti ormai, si
muovono sovra una linea di
parità assoluta; se qualcuno di
essi tace per breve tratto, ciò
viene predisposto perchè il suo
"rientrare" risulti più efficace
ed espressivo; lo spazio
sfruttato si estende verso
l'acuto e verso il grave; la
materia tematica filtra,
serpeggia, si cristallizza e si
rifluisce fra tutte le quattro
voci. E' come un grosso diamante
che scintilli di ugual luce in
ognuna delle sue facce. Il terzo
Quartetto di quest'opera 33 (do
maggiore) inizia con un Allegro
moderato, dove il primo violino,
dopo brevi accordi ribattutti
del "secondo" e della viola
annuncia il tema principale. Si
tratta di una frase
personalissima, che precipita
ritmicamente dopo aver preso lo
slancio sopra un sol, attaccato
"piano" e rinforzato via via da
"acciaccature". Codesto tema
viene ripetuto un tono più alto,
in minore, e quindi, dopo
essersi affermato nella sua
intierezza, si sgretola, si
suddivide e si espande alla
viola e al violoncello. La
seconda "idea", (piano,
semplice) viene esposta
sommessamente dai due violini
soli e, anch'essa è ricamata da
"acciaccature". Si direbbe che
questa figura ornamentale e
mordente sia come la cifra di
tutto il primo "tempo". E' da
essa, comunque, che al terzo
Quartetto dell'op.33 venne il
titolo di "Quartetto degli
uccelli". Gli svolgimenti della
"seconda parte" sono costruiti
tanto sul primo quanto sul
secondo tema, e presentano
quella proprietà, quella
nettezza, quell'essenzialità
così caratteristiche dello stile
di Haydn. In deroga agli schemi
ordinari, il secondo "movimento"
non un Adagio, bensì uno
Scherzo, palpitante e un poco
enigmatico come uno Scherzo
beethoveniano. Estremamente
conciso, questo pezzo magnifico
ha un trio ancor più breve,
affidato ai due soli violini e
immaginoso, luminoso come
un'ispirazione di musici
popolareschi. Anteponendo lo
Scherzo all'Adagio, Haydn ha
forse voluto preparare, con
maggior effetto, l'entrata
cantabile del terzo "movimento".
E invero, l'ingresso di quella
melodia affettuosa, dolce e
nello stesso tempo sostenuta
come un'Aria del grande
melodramma italiano, risulta per
causa del momento in cui cade,
ancor più suggestivo e
impressionante. L'Adagio in
parola non offre molte
digressioni da uno stato d'animo
fondamentale. Soltanto vaghi
arabeschi del primo violino lo
interpuntano di respiri, lo
allietano di rapide brezze.
Bellissima è la "coda", che
porta al termine in una specie
di accorata dissolvenza. Il
Rondò finale irrompe con passo
sicuro, con franchezza paesana,
con ritmo insistente e poi
dilaga ilare, felice, attraverso
un giuoco mirabile di
modulazioni sottili. L'idea
principale ha molte affinità con
una frase della scena del ballo
ducale in Rigoletto di Verdi. La
chiusa sfuma in lontananza il
travolgente disegno del pezzo.
Dopo i Quartetti delle opere 50,
54, 55, 64, 72, e 74, Haydn, nel
1797, compose i sei che formano
l'op.76. Secondo molti esegeti,
con questa sestina, Franz Joseph
toccò il culmine dell'arte sua.
In realtà, il raggio d'azione
viene ancora ampliato, sia per
quanto riguarda la qualità della
materia melodica, ritmica,
armonica, e sia per quanto
riguarda la sfera degli
interessi umani. Spunti
drammatici, si insinuano nella
luce delle più beate visioni;
ore contemplative succedono al
caldo lirismo degli Adagio
precedenti. L'Allegro con
spirito, ch'apre il Quartetto
n.4 in si bemolle maggiore, dopo
l'esposizione del tema basilare,
volubile e alitante, ribolle e
si condensa, si indugia in
passaggi a toni minori, senza
che una vera e propria "seconda
idea" venga a distrarre dal
clima fondamentale del brano.
L'Adagio esprime una profonda
serietà dello spirito, un che di
meditativo e concentrato, quasi
di orante, che fruscii di
sestine, serpeggianti nel primo
violino e raccolti qualche volta
dal violoncello, screziano di
malinconici sorrisi. Haydn
chiama ancora Minuetto il
"tempo" successivo. Ma noi, in
questa pagina, avvertiamo un
sentore d'aria aperta, un
profumo di campagne e di boschi
che sconvolgono dalle radici la
vecchia danza salottiera,
galante, ed aprono l'accesso al
popolare ländler germanico. Di
mirabile effetto, per il
contenuto ideale e per la
sonorità preziosa, è il Trio.
L'ultimo "tempo" ("Allegro ma
non troppo") è un nuovo prodigio
di invenzione musicale. di
immagini rinascenti l'una
dall'altra, d'intrecci
contrappuntistici resi con
abilità soltanto pari alla loro
chiarezza e, staremmo per dire,
al loro candore. Il ritmo di
codesto Finale si accelera
progressivamente e raggiunge,
nella conclusione, l'andamento
della vertigine.
Giulio
Confalonieri
|
|