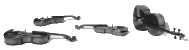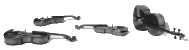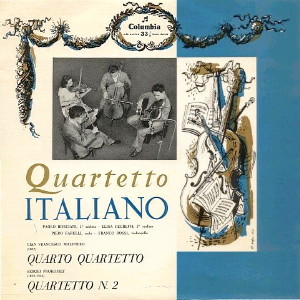 |
|
1 LP -
33QCX 10145 - (p) 1955
|
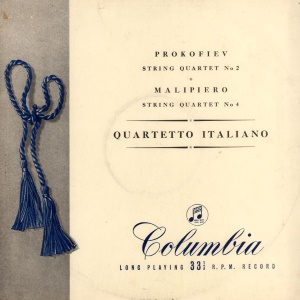 |
| 1 LP -
33CX 1295 - (p) 11/1955 |
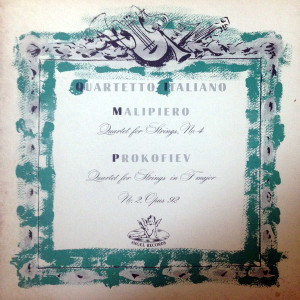 |
| 1 LP -
35296 - (p) 19xx |
|
| Sergei
PROKOFIEV (1891-1953) |
|
|
|
| Quartetto n. 2,
Op. 92 |
|
22' 18" |
|
-
Allegro sostenuto
|
6' 40" |
|
|
| -
Adagio |
7' 41" |
|
|
| -
Allegro |
7' 57" |
|
|
|
|
|
|
| Gian Francesco MALIPIERO
(1882-1973) |
|
|
|
| Quartetto
n. 4 |
|
15' 50" |
|
| - [...] |
15' 50" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Milano
(Italia) - 1955 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10145 - (1 LP) -
durata 38' 08" - (p) 1955 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1295 - durata 38' 08" - (p) 1955 -
Mono
Angel Records (USA) - 35296 -
durata 38' 08" - (p) 19xx - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
Personalità
singolare, quella di Gian
Francesco Maliero comunque
impostasi tra le più incisive
della musica italiana
contemporanea. Tale da sfuggire
ad ogni sorta di "collocazione"
anche approssimativa.
Appartenente a quella famosa
generazione dell'ottanta, a
quella stretta cerchia di
musicisti che sentirono, al loro
affacciarsi sulla ribalta della
vita musicale italiana, la
necessità di interrompere il
cielo ottecentesco del
melodramma per intraprenderne
nuovi (appartengono alla stessa
"generazione" due musicisti non
meno illustri e non meno ansiosi
di rinnovare il linguaggio
musicale: Casella e Pizzetti).
Gian Francesco Malipiero ha
dedicato la sua vita ad una
serie dì esperimenti e di
ricerche che doveva portarlo ad
una salda maturità stilistica ed
espressiva.
Non diversamente dai suoi più
avveduti contemporanei (e
particolarmente dai due citati),
non diversamente da quella sorta
di precursore che può essere
considerato Ferruccio Busoni,
Malipiero era già negli anni
precedenti la prima guerra
mondiale convinto
dell'opportunità di considerare
superato quel costume
melodrammatico che aveva
caratterizzato tutta l'attività
musicale dell'Italia
ottocentesca, fino a far
dimenticare la musica italiana,
pure tanto preziosa, dei secoli
precedenti. Ma non si lasciava
trascinare il musicista
veneziano nelle posizioni di una
sterile polemica contro
l'Ottocento: una sua
affermazione, risalente al 1928,
ci dà la misura della sua
"apertura" verso ogni forma di
musica, al di là delle
distinzioni più o meno
artificiali: "La musica italiana
non si deve fabbricare con lo
stampo, essa può manifestarsi in
mille modi, sotto variissimi
aspetti, e nei secoli XVI e XVII
l'Italia ha dato grandi
musicisti i quali oggi
potrebbero additare nuove
strade, o forse ricondurre sulla
grande strada maestra qualora li
rimettessimo, almeno, allo
stesso livello di quelli
ottocenteschi". Almeno allo
stesso livello: non è questa una
dichiarazione di serena
accettazione di "tutta" la
tradizione musicale italiana?
Naturalmente con una personale e
razionale e attualissima
inclinazione verso quei
linguaggi musicali che per tanto
tempo erano stati trascurati. E'
il caso di aggiungere che a quel
processo di reinserzione nel
vivo costume moderno delle
musiche dei secoli XVI, XVII,
XVIII, ha portato un valido,
decisivo contributo mediante
un'enorme mole di lavoro di
ricerca, di revisione, di
riordinamento di antichi e
dimenticati manoscritti. Una
consuetudine dunque di anni e
anni con le voci dei musicisti
di quei tempi, consuetudine che
non poteva non riflettersi sulla
musica sua, conferendole quella
molteplicità di inflessioni,
diversissime e pur così
splendidamente organizzate, che
ne costituiscono una delle
fondamentali ragioni di fascino.
Gian Francesco Malipiero, in
occasione dell'incisione del suo
Quarto Quartetto da parte del
Quartetto Italiano ha dettato a
sua illustrazione, su invito
della Columbia, le parole che
riportiamo.
"Sette
sono i miei quartetti perciò il
quarto è al centro, tre lo
precedono tre lo seguono.
Difatti esso rappresenta una
specie di intermezzi ed il sesto
è più il seguito del terzo che
il quarto non lo sia.
Ma queste osservazioni sono
postume, cioè quando scrissi il
quarto quartetto, non mi proposi
di considerarlo un intermezzo
chè non potevo immaginare che
altri tre sarebbero usciti più
tardi dalla mia penna.
I compositori annunziano a gran
voce le loro innovazioni, i loro
programmi, tutte cose che
lasciano il tempo che trovano.
Io vorrei dire semplicemente
senza peccare ne di umiltà nè di
vanità: nel 1920 nascevano i
"Rispetti e Strambotti", cioè il
mio primo quartetto (ottenne il
premio Coolidge del 1920) il
quale in realtà non era il primo
perchè, nel 1909 circa con un
altro quartetto avevo tentato di
dire qualche cosa che mi
soddisfacesse, ma con esito
negativo, tanto che lo distrussi
insieme a tutti quegli
esperimenti che non avrei mai
valuto conservare entro boccali
di vetro e sotto spirito come
nei musei si conservano i feti
venuti intempestívamente alla
luce.
Da questa premessa la
conclusione: già nel 1920 mi
rendevo conto di quali risorse
sonore i quattro istrumenti ad
arco nel loro perfetto
equilibrio dispongono. Pure i
temi devono essere intraducibili
per altri istrumenti, tutto deve
nascere naturalmente per
quartetto e se ciò è avvenuto in
tutti e sette i miei quartetti
null'altro posso dire, cioè
sperare nonostante
l'adattabilità della materia
l'invenzione non sia venuta
meno.
E questo il grande segreto della
creazione.
Il quarto quartetto lo conclusi
a termine ad Asolo, nel maggio
1934, è dedicato alla mia grande
amica Elizabeth S. Coolidge,
però la prima esecuzione ha
avuto luogo a Milano nel
dicembre del 1938, esecutori: Il
Quartetto Veneziano.
Il quarto quartetto venne
pubblicato a Copenaghen,
dall'editore Wilhelm Hansen, nel
1936."
Il
quartetto n.2 op.92 appartiene
all'ultimo periodo dell'attività
creativa di Prokovief, a quel
periodo cioè seguente al suo
ritorno definitivo nell'U.R.S.S.
dopo una permanenza di molti
anni in Francia ed in America.
Un primo quartetto era già stato
composto dal musicista russo nel
1930 durante il suo soggiorno
americano su commissione della
Fondazione Elizabeth Sprague
Coolidge della Biblioteca del
Congresso. Il quartetto n.2 fu
invece composto nel 1942 a
Nalchik nel Cancaso. Nel 1941,
quando le armate tedesche
premevano minacciose verso
Mosca, il Governo Sovietico
decise di fare abbandonare ai
suoi artisti più preziosi le
zone pericolose per trasferirli
in località più tranquille e
sicure. Prokovief raggiunse
appunto Nalchik, nella
Repubblica autonoma di
Kabardino-Balkaria e fu subito
sedotto dai canti popolari di
quella popolazione; nel
Quartetto egli inserì materiali
tematici tolti appunto alla
tradizione musicale popolare
locale. Così come già il primo,
anche questo secondo Quartetto
si articola su tre movimenti;
come già il primo anche il
secondo Quartetto si apre con un
"Allegro" costruito sul metro di
un classico primo tempo di
sonata, ma il secondo tempo del
Quartetto n.2 è un dolce
movimento lento riprendente il
tema d'una canzone caucasiana ed
il terzo una libera e bizzarra
invenzione sulla musica delle
danze del popolo montanaro della
regione di Nalchik.
La prima esecuzione del
Quartetto n.2 ebbe luogo a Mosca
il 7 aprile 1942
nell'interpretazione del
Quartetto Beethoven.
(autore
delle note non citato)
|
|