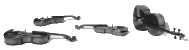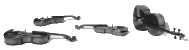|
|
1 LP -
33QCX 10026 - (p) 1953
|
 |
| 1 LP -
33CX 1103 - (p) 12/1953 |
 |
| 1 LP -
35064 - (p) 19xx |
|
| Ludwig
van BEETHOVEN (1770-1827) |
|
|
|
| Quartetto n. 13
in si bemolle maggiore, Op. 130 |
|
--' --" |
|
| -
Adagio ma non troppo - Allegro |
--' --" |
|
|
| -
Presto |
--' --" |
|
|
| -
Andante con moto ma non
troppo. Poco scherzando |
--' --" |
|
|
|
|
|
|
| -
Alla danza tedesca (Allegro
assai) |
--' --" |
|
|
- Cavatina (Adagio
molto espressivo)
|
--' --" |
|
|
- Finale (Allegro)
|
--' --" |
|
|
|
|
|
|
| QUARTETTO
ITALIANO |
|
| - Paolo
Borciani, violino I |
|
| - Elisa Pegreffi,
violino II |
|
| - Piero Farulli,
viola |
|
| - Franco Rossi,
violoncello |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Basilica
Sant'Eufemia, Milano (Italia) -
6-8 ottobre 1953 |
|
|
Registrazione: live /
studio |
|
studio |
|
|
Producer / Engineer |
|
- |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Columbia
(Italia) - 33QCX 10026 - (1 LP) -
durata --' --" - (p) 1953 - Mono
Columbia (United Kingdom) - 33CX
1103 - durata --' --" - (p) 1953 -
Mono
Angel Records (USA) - 35064 -
durata --' --" - (p) 19xx - Mono
|
|
|
Note |
|
- |
|
|
|
|
|
E' ormai chiaro
che Ludwig van Beethoven non fu
soltanto un genio musicale di
primissimo piano, ma colui,
ancora, che assunse nella musica
una posizione personale del
tutto inedita, del tutto nuova e
imprevista. Tanto che il
beethovenismo oltre che a
costituire una maniera, uno
stile, un carattere specifico di
linguaggio sonoro, costituì pare
un fatto umano e morale; la
candidatura, non mai prima
posta, di un musico, ad apostolo
di una particolare concezione
del mondo, ad assertore di una
verità intravista, di una fede
acquisita, ansiosa di
comunicarsi. Con l'avvento di
Beethoven, l'arte della Musica
intese rivestire i lineamenti
dell'etica; intese farsi
testimonio di un dramma
individuale (dramma svelato per
fraterna carità, per atto
solidale, per coscienza di
rappresentare una sorta di
prototipo) e infine additarci la
strada per superarlo. L'atto
primo di codesta parabola
consistette in una coraggiosa
discesa dentro gli abissi
dell'anima; in un'indagine
spietata e in un'eroica
annotazione di ogni suo
contrasto, d'ogni sua
insofferenza, d'ogni sua rivolta
contro il destino. Già questo
mettersi a nudo, già questo
rivelare la propria
crocifissione, adeguandosi alle
condizioni di tutti i suoi
simili, era un assunto magnanimo
e consolatore. Ma la grandezza
di accento, con cui questo
rapporto veniva presentato
conferiva per se stesso, alla
tragicità dell'umana sorte, un
lineamento eccezionale, un segno
di necessità arcana, una prova
del suo essere come prezzo
indispensabile a una successiva
elevazione e ad una successiva
catarsi. Per ascendere alla luce
e alla pace, cui era chiamato
dal suo desiderio e dalla
tendenza spontanea della sua
essenza spirituale, l'uomo
doveva bruciare tutto il suo
dolore; doveva consumarlo
vivendolo, scoprendone le
ferite, esaurendo, senza
reticenze, lo smarrimento e la
disperazione. Un simbolo antico,
il simbolo di Prometeo ribelle
agli dei per ansia di soccorrere
gli uomini, rinunciatario della
felicità divina per impulso a
spartire l'infelicità degli
uomini, il mito di Prometeo,
pronto a sostituire con la
sofferenza il brutale oblio
delle creature purchè da tale
sostituzione nascesse una
coscienza virile dei propri
compiti e dei propri doveri,
svelarsi nell'esistenza e
nell'opera di un solitario
artista, figlio di una cuoca e
di un volgare musicante, nel
pellegrinaggio terreno di un
artista duro e traboccante
d'amore, nemico della società
per eccessiva brama di volerla
perfetta, proteso verso
l'avvenire come a solo e
possibile paese d'ogni speranza.
Simile volontà di Beethoven,
simile impegno e simile
addossarsi di responsabilità non
ancora affrontate, simile
decisione di vivificare il
contenuto della musica con la
presenza di una idea, s' da
farne un lungo e quasi
sanguinoso apologo, doveva,
necessariamente, sconvolgere
ogni ordine prestabilito e
sottoporre ogni forma a una
tensione massima, a una
disgregazione totale, d'onde
sarebbe poi sorta una nuova
architettura. In Beethoven, il
drammatismo non scaturì più da
situazioni predisposte e
antecedenti il contatto con la
musica (così come avveniva nel
caso del teatro); non andò più
sviluppandosi, fatalmente, dal
giuoco serrato delle entità
sonore (così come avveniva in
certi momenti della composizione
sinfonica e da camera), ma fu
ricercato e attuato con avida,
con rigorosa consapevolezza.
L'ideale non venne più situato
nella purità cristallina, nella
celeste giustezza d'ogni
movimento, d'ogni linea, d'ogni
rapporto, bensì in quella che
apparve come verità del proprio
essere umano e nella fedeltà ad
una missione profetica. Se
Beethoven avesse potuto disporre
della cultura letteraria di un
Wagner e se, ai suoi tempi,
anche un uomo spregiudicato e
avventuroso quanto lui avesse
potuto concepire che un
musicista scrivesse da sè i
propri libretti, forse un così
forte empito drammatico si
sarebbe risolto nella creazione
d'opere teatrali e si sarebbe
espresso per via di allegorie,
per via di sdoppiamenti nei
caratteri scenici. Educato fin
da giovane allo stile
istrumentale e troppo geloso di
libertà, di sincerità, intesa
come obbligo insormontabile,
Beethoven elesse a campo di
battaglia la Sinfonia, la Sonata
e i generi affiniti della musica
da camera. Di qui, egli si
sentiva più atto a cogliere in
pieno il bersaglio; qui non
avvertiva ostacoli o pericoli di
deviazioni. Qui, il transito dal
mondo interiore al mezzo
materiale per comunicarlo poteva
compiersi direttamente, per la
strada più breve. Fu un viaggio
lento e faticoso, tutto segnato
di perplessità e di abbandoni.
Quasi un rimorso, talvolta, nel
dover distruggere le
paradisiache forme di Haydn e di
Mozart. Ma lo schema della
Sonata prese, a poco a poco, un
aspetto intieramente diverso.
Incominciarono a dilatarsi i
quattro "tempi" classici; a
incidersi, più profondamente, il
contrasto fra prima e seconda
idea. Cessò il Minuetto di
rievocare, con maggiore o minore
precisione, relegante passo di
danza, e, in suo luogo, esplose
lo Scherzo, travolgente,
tempestoso, ferrigno, spesso
sarcastico e quasi brutale. Poi,
i quattro "tempi" di prammatica
si fecero più numerosi,
riproducendosi, non di rado,
anche per brevi e inaspettati
ritorni. Il corso inflessibile
degli "allegro" subì improvvise
fratture; in certi punti
culminanti degli "sviluppi",
chiaramente tesi verso una
conclusioue, si trovarono
polverizzati ad un tratto,
inceneriti, cancellati da
fulminei silenzi, come da
catastrofi o come da un
annichilirsi d'ogni forza
vitale. E i limiti delle
sonorità si allargarono, verso
il più acuto e verso il più
grave; i moti contrappuntistici
divennero più spericolati;
talune melodie si compiacquero
di conservare uno stato
primordiale, di mantenersi
pressochè informi per non
tradire il loro essere di
immagine non ben determinata e
non ben posseduta. La Sinfonia,
la Sonata, il Quartetto si
tradussero in lunghi e complessi
poemi; sul gorgo dell'orchestra
si librò infine anche la voce
umana. Ora, noi possiam ben dire
che la rivoluzione
beetboveniana, se risulta più
appariscente (e quindi è
diventata più popolare)
attraverso le nove Sinfonie e
attraverso taluna delle Sonate
per pianoforte, ritiene la più
alta espressione, offre il suo
documento più vivo negli ultimi
Quartetti per archi. Negli anni
1824, 1825 e 1826, presago della
fine imminente, malato e
bisognoso di tutto ("miser et
pauper", com'egli stesso ebbe a
dire) il grande maestro era già
trasceso oltre la vita. Le linee
dell'immenso mondo, creato in
trent'anni di accanito lavoro,
si andavano serrando entro
disegni sempre più complessi ed
astratti. Ogni esperienza ed
ogni sensazione, ogni gioia ed
ogni dolore, ogni vicenda di
un'esistenza pensierosa, china
sul profondo dell'anima e aperta
a un contatto mistico con la
natura e con gli uomini, si
concretavano in superbe
invenzioni, ove nulla si trovava
dimenticato ed ove tutto
rivestiva l'aspetto di cosa
nuovamente scoperta. Il
persistente dramma dello spirito
beethoveniano si innalzava a tal
punto da farsi scorgere, in un
unico sguardo, gli abissi più
segreti e le più chiare
efflorescenze. Meno esposti alle
minacce dell'enfasi orchestrale,
regolati da vertiginosa
dialettica nel discorso fra i
due violini la viola e il
violoncello; concentrati, a
tratti, in mondo siffatto che il
doppio dialogo andò a
confondersi dentro risolazione
di uno stoico soliloquio;
attardati, ogni tanto, nel
ricordo di felicità smarrite, di
feste godute o vanamente
sperate, i Quartetti dell'ultimo
Beethoven si inoltrano verso
zone dello spirito che nessuno,
nè prima nè dopo, aveva mai
osato esplorare.
Sono sei codesti capolavori,
addensati in un periodo di poco
più di due anni e tali da
superare di molto i dieci già
composti a lunghi intervalli di
tempo. Il Quartetto in si
bemolle op.130, scritto
lentamente, dalla primavera
all'autunno del 1825, consta di
parecchi "movimenti", disposti
in un ordine assolutamente
eterodosso dal punto di vista
della disposizione haydniana e
mozartiana. S'apre con un
"Adagio non troppo"; meditabondo
e inconcluso, il cui inizio
ritorna cinque volte a
interrompere, ad arginare, a
deviare il corso di un "Allegro"
fondato su tre temi essenziali,
i primi due gagliardi
rimbalzanti e pieni di vita, il
terzo assai più dolce e sereno.
In tutto questo "Allegro"
circola un che di fremente; e i
quattro istrumenti ora si
ravvicinano ora si espandono
verso registri estremi; bruschi
passaggi, cesure vigorose
spezzano il discorso per farne
più vertiginose le riprese. Il
"Presto" successivo par
travolgere con maschia
accelerazione e flagellare con
il pungolo di un humour
selvaggio il galante andamento
della vecchia Gavotta;
l'"Andante con moto ma non
troppo" ("poco scherzoso")
oscilla fra la tenerezza e la
leggerezza, fra la vaporosità e
la consistenza. Il quinto
"tempo" ("Alla danza tedesca,
allegro assai"), scandito sopra
un ritmo popolaresco, alterna
figure di plasticità incisiva
con episodi sfumati; parole
semplici e forti con sussurri e
mormorii enigmatici. Succede a
questa "tempo" la famosa
"Cavatina" ("Adagio molto
espressivo") che non ha nulla a
vedere con l'omonimo pezzo
vocale, caro al melodramma
dell'ultimo Settecento, ma che è
una specie d'inno cantato a se
stessi, una specie di preghiera
pronunciata nel silenzio
notturno o una specie di
interrogazione, indirizzata
all'eterno e raccolta dalla
pietà di qualche angelo. Di
questa pagina prodigiosa,
Beethoven disse al violinista
Holtz "l'ho composta piangendo e
il solo suo ricordo mi fa
tornare agli occhi le lacrime!".
Il "Finale" ("Allegro")
costituisce il brano meno
preoccupato di tutto il
Quartetto. E' la fiducia,
vittoriosa di ogni precedente
inquietudine; è la risorgenza
dell'uomo coraggioso, il congedo
di un forte, che entra a testa
alta nel mondo ultraumano delle
verità assolute.
Giulio Confalonieri
|
|