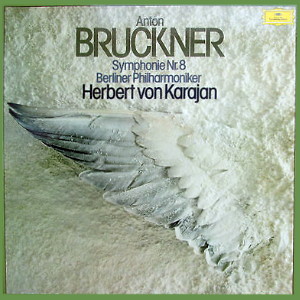 |
|
2 LP's
- 2707 085 - (p) 1976
|
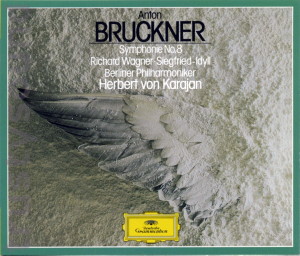 |
| 2 CD's -
419 196-2 - (c) 1987 |
|
| ANTON BRUCKNER
(1824-1896) |
|
|
|
|
|
|
|
| Symphonie
Nr. 5 c-moll |
|
82' 39" |
|
| Versione 1887;
edizione Robert Haas |
|
|
|
Long playing 1
- 2530-648
|
|
32' 07" |
|
| -
1. Allegro moderato |
16' 57" |
|
|
| -
2. Scherzo: Allegro moderato |
15' 11" |
|
|
| Long playing 1
- 2530-649 |
|
50' 32" |
|
| -
3. Adagio: Feierlich langsam; doch
nicht schleppend |
26' 22" |
|
|
| -
4. Finale: Feierlich nicht schnell |
24' 10" |
|
|
|
|
|
|
| Berliner
Philharmoniker |
|
| Herbert von KARAJAN |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Philharmonie,
Berlino (Germania) - aprile 1975 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Production |
|
Dr.
Hans Hirsch, Magdalene Padberg |
|
|
Recording
Supervision |
|
Michel
Glotz
|
|
|
Balance Engineer |
|
Günter
Hermanns |
|
|
Prima Edizione LP |
|
Deutsche
Grammophon - 2707 085 - (2 LP's) -
durata 32' 07" & 50' 32" - (p)
1976 - Analogico |
|
|
Prima Edizione CD |
|
Deutsche
Grammophon - 419 196-2 - (2 CD's)
- durata 58' 15" & 43' 47" -
(c) 1987 - ADD - (+ Wagner:
Siegfried Idyll)
|
|
|
Note |
|
Cover
Design: Holger Matthies, Hamburg
|
|
|
|
|
"Nel caso di
Bruckner non si deve parlare
di opere, ma di una frode
che si scoprirà in uno o due
anni."
Questa frase che Johannes
Brahms ha pronunciato a
proposito del suo
concorrente viennese
dimostra la perplessità che
le sinfonie bruckneriane
suscitarono in molti
contemporanei. Una
perplessità che si trasformò
successivamente in una
completa accettazione.
Continua così quella
corrente ricettiva iniziata
non per caso con la Nona
Sinfonia di Beethoven, di
cui un elemento essenziale è
l'inconscia sensazione che
la composizione sia rivolta
direttamente
all'ascoltatore, lo avvolga
ed infine lo assorba
completamente, portandolo ad
una comunione metafisica con
la musica stessa. E così
sconsideratamente egoistico
e prevalentemente basato su
criteri soggettivi è il
consumo che si fa di questa
musica. In breve: l'arte
sinfonica di Bruckner viene
giudicata per quello che non
è, anche se ciò ne
semplifica la comprensione;
viene considerata classica.
Le sinfonie di Bruckner non
possono essere considerate
classiche, anche se in esse
è presente ancora la
simmetria formale del
periodo dei classici, già
soltanto perchè,
distaccandosi dalle sinfonie
classiche, non hanno tanto
ripreso il dualistico
impulso tematico, ma sono
molto di più plasmate
secondo concezioni
architettoniche. Hugo Wolf
ha in questo
appropriatamente chiamato
Bruckner progressista
geniale, definizione certo
inconsueta vista l'attuale
tendenza verso l'immagine di
un Bruckner borghese e di
ideali cristiani. Bruckner
ha realizzato, al contrario
di Brahms, anche se non di
proposito almeno nel
risultato, una sintesi di
differenti prassi
compositive e l'ha
subordinata alla sua
concezione di una musica
lenta. Sotto questo aspetto,
in effetti, non sono
importanti le singole opere,
anche se la loro
caratterizzazione nei
dettagli è possibile e
ragionevole, ma
l'atteggiamento artistico,
ciò che Brahms voleva
screditare come "frode"
(questo non toglie che egli
avesse ben capito quali
differenze fondamentali di
gusto esistessero fra lui e
Bruckner).
L'attrazione profonda che
Bruckner provava per la
tecnica della composizione è
da attribuire al suo
interesse per lo stile
palestriniano e per la
polifonia di Bach. A questo
si aggiunge poi la sua
inclinazione per la grande
forma sinfonica
beethoveniana e il suo
pressochè acritico
entusiasmo per l'opera del
grande, ammirato Maestro,
Richard Wagner, di cui
riprese per la sua musica la
gamma timbrica.
Determinanti, però, per le
sue sinfonie, sono le
esperienze dell'organista
Bruckner. Gli effetti
timbrici di questo
strumento, spesso rigidi e
taglienti a causa di
improvvisi ammassamenti o
riduzioni di registri, si
possono rilevare spessissimo
nelle sinfonie di Bruckner.
Il compositore ha unificato
stilisticamente questa
molteplicità di influssi
combinando la forma basilare
a quattro movimenti della
sinfonia classica con
l'intreccio polifonico. E
sotto questo punto di vista,
si può comprendere
senz'altro, nella sua
sostanza musicale e nella
sua tecnica, un'opera come
l'Ottava Sinfonia in do
minore, la più lunga
sinfonia bruckneriana e la
più ampia formalmente, anche
se non la più audace nel
linguaggio sonoro. E proprio
in Bruckner questo
normalmente non avviene, in
quanto il compositore stesso
con il suo candido
misticismo ha dato spesso
motivo ai suoi esegeti ed
ammiratori per
interpretazioni
extramusicali.
È fuor di dubbio che la sua
musica trasmette
monumentalità e grandezza.
Volerla chiarire però da un
punto di vista
programmatico, e in questo
potrebbero animare le
osservazioni di Bruckner
stesso in merito - in
particolare per l'Ottava
Sinfonia - andrebbe a
discapito di una definizione
del materiale composto.
Significativi in questa
terza sinfonia che Bruckner
ha composto in do minore,
sono lo sviluppo, la
metamorfosi e l'unificazione
della materia tematica. Già
il primo tema corto del
movimento iniziale che va da
fa a sol bemolle e a re
bemolle, passa per il
semitono do, sale a mi
bemolle per poi arrivare
cromaticamente alla tonalità
di base do, dimostra nella
sua irregolare successione
degli intervalli, alla quale
si aggiunge un ritmo
staccato con doppi punti e
sedicesime, in quale
specifico modo sia costruito
un tale tema, anche per
quanto riguarda la sua
possibilità di ampliamento e
di trarne altri motivi.
Grandi intervalli o, in
contrasto, linee vicine
sviluppate cromaticamente
racchiudono la possibilità
di plasmare la musica in
modo coloristico, nel senso
di effetti di registro ampi,
estensivi. In Bruckner,
quindi, molto di più che nei
suoi contemporanei, si
ottiene l'impressione di un
tempo musicalmente intuito e
colmato.
L'Ottava Sinfonia è stata
composta in un tempo
relativamente breve, tra il
1884 e il 1886. La notazione
del finale, che rappresenta,
nell'utilizzazione di tutti
i temi principali dei 4
movimenti, richiese
addirittura meno di un mese.
Per dare una forma
definitiva alla Sinfonia di
Bruckner necessitò però di
parecchio tempo e poiché
venne manifestato da più
parti un certo scetticismo
nei confronti della sua
opera, egli la presentò in
una versione modificata; e
così essa fu rappresentata
per la prima volta nel 1892
a Vienna sotto la direzione
di Hans Richter.
Allo studioso bruckneriano
Robert Haas va il merito di
aver riscoperto le stesure
primitive di tutte le
sinfonie di Bruckner; le
rappresentazioni odierne,
quindi, ce ne presentano le
versioni originali anzichè
quelle più moderate fornite
dagli allievi di Bruckner,
Ferdinand Löwe e Franz
Schalk.
Hanspeter
Krellmann
(Traduzione:
Mirella Noack-Rofena)
|
|
|