 |
|
1 LP -
AC 691 - (p) 1965
|
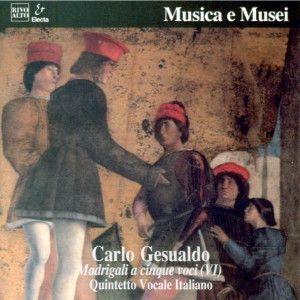 |
| 1 CD -
CRA 8912-6 - (c) 1996 |
|
Carlo
GESUALDO da Venosa (1566-1613)
|
|
|
|
|
|
MADRIGALI
A CINQUE VOCI, LIBRO VI (1611) -
seconda parte
|
|
|
|
|
|
| - Deh, come
invan sospiro |
4' 06" |
|
| - Io pur
respiro |
3' 33" |
|
| - Alme d'amor
rubelle |
2' 40" |
|
| - Candido e
verde fiore |
2' 41" |
|
| - Ardita
zanzaretta |
4' 25" |
|
| - Ardo per te,
mio bene |
3' 13" |
|
| - Ancide sol
la morte |
2' 50" |
|
| - Quel "no'"
crudel |
2' 58" |
|
|
|
|
| - Moro, lasso,
al mio duolo |
3' 16" |
|
| - Volan quasi
farfalle |
3' 12" |
|
| - Al mio gioir
il ciel si fa sereno |
3' 02" |
|
| - Tu segui, o
bella Clori |
2' 24" |
|
| - Ancor che
per amarti |
2' 42" |
|
| - Già piansi
nel dolore |
2' 57" |
|
| - Quando
ridente e bella |
1' 56" |
|
|
|
|
| QUINTETTO VOCALE
ITALIANO /
Angelo Ephrikian, direttore |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Villa Litta, Milano (Italia) -
21-30 settembre 1965
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Giambattista
Pirelli / Karla Schlean - Angelo
Ephrikian |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Arcophon
- AC 691 - (1 LP) - durata 45' 55"
- (p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizione CD |
|
Rivo Alto &
Electa "Musica e Musei" - CRA
8912-6 - (1 CD) - durata 73' 32"
- (c) 1996 - ADD
|
|
|
Note |
|
In copertina
(CD): Andrea Mantegna, Camera
degli Sposi (particolare)
- Palazzo Ducale - Mantova
L'edizione in CD
contiene l'intero Sesto Libro
mentre l'edizione in Lp contiene
gli ultimi 15 numeri. |
|
|
|
|
IL QUINTO E IL
SESTO LIBRO DEI MADRIGALI
Il quinto e il sesto libro dei
madrigali del Principe di
Venosa furono pubblicati quasi
contemporaneamente a Gesualdo
nel 1611, per i tipi di G.G.
Carlino e per cura di tale
Giovanni Pietro Cappuccio,
certo un cortigiano del
principe che - secondo la
consuetudine - dedicò la
raccolta allo stesso
compositore: si trattava
ovviamente di uma finzione
resa necessaria dal costume
del tempo che vietava a un
personaggio del rango del
Venosa di assumere
direttamente la responsabilità
della pubblicazione delle
proprie opere.
La data di composizione dei
madrigali raccolti nel quinto
e nel sesto libro si scagliona
presumibilmente lungo un arco
di tempo assai ampio, come si
deduce tra l’altro dalla
dedica del sesto libro al
Gesualdo, stesa dallo stesso
Giovanni Pietro Cappuccio:
"Questi madrigali della sesta
muta furono composti da V.E.
nelli medesirni anni che
furono quelli della quinta; e
perciò questi ancora sono
stati aspettati con
grandissimo desiderio dal
mondo da sì lungo tempo". Si
tratta dunque di una scelta
che Gesualdo stesso compì
delle proprie opere composte
dopo il 1596, con la consueta
severità e l’acuto senso
critico che gli vietò, per
esempio, di divulgare i suoi
esperimenti in stile monodico
di cui è fatta menzione da
parte del Fontanelli (cfr. la
mia presentazione del III° Li-
bro dei Madrigali di Gesualdo,
Disco Arcophon AM 668) e le
canzonette pubblicate postume
da Pomponio Nenna nel proprio
Ottavo Libro dei Madrigali,
Roma, 1618.
Nella sua critica vicenda
esistenziale che dovette
assumere negli ultimi anni
aspetti e momenti veramente
allucinanti, la musica non
cessò di essere un polo
costante di interesse, un
campo di studio e di ricerca
assidua e febbrile, nella
quale Gesualdo impegnò la
parte migliore di sè, le sue
lucide doti intellettuali non
meno dell’appassionata
dedizione interiore. Tornato a
Napoli nel 1597, raccolse
intorno a sè un’accademia
musicale comprendente Scipione
Stella, Rocco Rodio, Pomponio
Nenna, Muzio Efrem, Giovanni
Macque, Bartolomeo Roy,
Giovambattista di Pavolo,
Scipione Cerreto, Giustiniano
Forcella, Domenico Montella,
"compositori, sonatori e
cantori eccellentissimi" che
il principe, secondo le parole
di un contemporaneo "per suo
gusto e intertenimento tiene
in sua corte a sue spese".
Gesualdo preso tutto dalla sua
passione, ignorava le accuse
di eccessiva prodigalità e di
sperpero che la sua famiglia
gli moveva. Egli, pontefice in
questo eletto cenacolo
d’artisti, mirava certo ad
emulare i fasti musicali della
corte estense: desiderio
conferrnato dalla fondazione,
nel castello di Gesualdo, di
una stamperia musicale diretta
da G.G. Carlino, la stessa che
pubblicò i suoi due ultimi
libri di madrigali e una sua
raccolta di responsori.
Gesualdo volle consolidate la
sua fama di compositore,
pubblieando tra il quarto
(1596) e il quinto (1611)
libro di madrigali tre
raccolte di musica religiosa:
Sacrarum Cantionum Quinque
Vocibus Liber Primus
(1603); Sacrarum Cantionum
Liber Primus Quarum Una
Septem Vocibus, Ceterae Sex
Vocibus Singulari Artificio
Compositae (1603); Responsoria
et Alia ad Officium
Hebdomadae Sanctae
Spectantia, a sei voci
(1611). Opere tutte, a parte
ogni ricerca di carattere
espressivo, veramente "singulari
artificio composiate",
sulla linea della più rigorosa
arte contrappuntistica
cinquecentesca. Per quanto più
propriamente concerne le
ultime due raccolte di
madrigali, si nota una
sostanziale continuazione
degli atteggiamenti espressivi
maturati nei libri precedenti,
soprattutto nel quarto. Nella
scelta dei testi incontriamo
ancora la predilezione per
poesie brevi e di limitate
pretese letterarie (nel Quinto
Libro, su ventuno madrigali,
uno solo, l’ultimo, è dovuto a
un autore illustre,
Giovanbattista Guarini). In
questo modo Gesualdo si
riserva da parte sua la
massima possibilità
d`intervento, sia dal punto di
vista di un’autonoma
organizzazione strutturale del
madrigale, sia da quello di
una totale ricreazione
semantica del contenuto
espressivo della poesia.
Secondo la fine notazione
critica di Nino Pirrotta "non
“serva” ma “compagna"
dell’orazione, la musica ha il
compito di dire ciò che è
indicibile a parole, di
esprimere coi rivolgimenti
cromatici il torcersi
dell’anima nel dolore, con i
salti melodici violenti e
inconsueti la sfida del
sarcasmo e della ribellione,
con i travolgenti contrappunti
di diatoniche colorature di
quest'ultimo periodo... il
fervore disperato della
speranza o il dilatarsi panico
della personalità nella
gioia".
I gesti espressivi si
semplificano, sino a ridursi
all’alternanza e alla
successione di atmosfere
espressive nettamente
contrastanti: è come se la
poetica espressionistica di
Gesualdo, portata alle sue
ultime conseguenze non
riconoscesse altro che la
possibilità di un procedere
apodittico, articolato
attraverso la contrapposizione
di concetti e di momenti
opposti, che solo la ferrea
logica con cui è condotto il
discorso riesce a fondere in
una struttura organica. Ancora
più sviluppato che non nel
quarto libro è il parametro
armonico, piegato ad audacie
che per più di due secoli non
furono emulate nella
tradizione musicale
occidentale. Parallelamente,
la tecnica contrappuntistica
si decanta sino a raggiungere
una sorta di astratta e
cristallina purezza,
soprattutto laddove essa è
impiegata in quei passi che
Vincenzo Giustiniani definiva
"fughe dolci e correnti";
momenti nei quali Gesualdo
raggiunge una gioiosa e
prorompente pienezza di vita.
Accanto a questo si delinea
negli ultimi due libri di
madrigali un tipo di
contrappunto affatto nuovo,
che potrebbe delinirsi, con il
Pirrotta, "contrappunto di
recitativi, dacché la sua
sostanza non è più il gioco
delle immagini sonore in
movirnento, ma la
moltiplicazione
contrappuntistica
dell’intensità affettiva della
declamazione". Un calore umano
tutto nuovo hanno i passi
trattati omoritmicamente in un
declamato accordale aperto a
preziose, ricchissime
sfumature di senso, e, in
generale, a un accento di
straordinaria immediatezza e
verità umane.
Anche da un punto di vista
contenutistico le due ultime
raccolte chiudono
circolarmente la tematica
estetica di Gesualdo:
suggellano, portandolo alle
ultime conseguenze, in una
sorta di apoteosi lucida, ma
pure allucinata e barocca, il
tema unico della sua arte,
l’amore. Con le parole del
Pirrotta: "Egli fu, si
direbbe, romanticamente
innamorato del complesso
cerimoniale del corteggiamento
amoroso, delle promesse
deluse, delle negazioni
provocanti, delle speranze
risorgenti. La vita non gli
diede che delusioni,
incomprensioni coniugali o
troppo facili avventure
degradanti del senso. Pure il
sogno persiste fino
all’ultimo, si rinnova anzi
negli ultimi anni in una fase
gioiosa che le fasi precedenti
non avevano conosciuto".
LIBRO
SESTO (Seconda parte)
IX.
Deh, come invan
sospiro,
Deh, come invan vi miro,
Poichè, crudel, voi fate
ogni un gioire
Et a me sol morire!
Infelice mia sorte,
Che la vita per me
divenga Morte.
E' composizione vibrante e
commossa, costruita attraverso
una catena di sospese, intense
esclamazioni, secondo una misura
e un'intonazione tipica
dell’arte di Gesualdo.
Caratteristica anche l’enfasi
posta dal compositore sugli
ultimi due versi, che paiono
incarnare un aspetto
fondamentale della sua poetica.
X.
Io pur respiro
in così gran dolore
E tu pur vivi, o
dispieiato core?
Ahi, che nan vi è più
speme
Di riveder il nostro
amato bene!
Deh, morte, danne aita,
Uccidi questa vita!
Pietosa ne ferisci, e un
colpo solo
A la vita dia fin ed al
gran duolo.
All’espansa complessità del
testo poetico, corrisponde una
struttura musicale che riunisce
in armonico fluire di forme
momenti e moduli fortemente
contrastanti, secondo una
tecnica largamente generalizzata
nella scrittura di Gesualdo a
partire dal Quinto Libro. Si
distaccano per altezza e
intensità dell’accento le parti
sollecitate dalle parole di più
rilevata carica patetica e le
commosse esclamazioni: O
dispietato core! - Deh,
morte, danne aita!, e,
ancora una volta, tutta la
sezione finale, caratterizzata
da preziosi trascoloranti cambi
d’armonia su lunghe note tenute
dal basso.
XI.
Alme d’Amor
rubelle,
Che con leggiadri suoni e
dolci accenti
Frenar potete i venti,
E invaghite di voi
l'ardenti stelle:
Beato chi voascolta e chi
vi mira,
Beato chi per voi langue
e sospira!
Elaborato su una minutissima
orditura di piccoli incisi
contrappuntistici in imitazione
che si specchiano l’uno
nell’altro in una fitta serie di
rifrangenze, il madrigale
culmina sull’esclamazione del
sesto verso, trattata per
contrasto in una piana scrittura
accordale, per chiudersi sulla
patetica e come sfrangiata
chiusa (Beato chi per voi
langue e sospira).
XII.
Càndido e verde
fiore,
Che di speranza e fede
Tu pur m'imbianchi e mi
rinverdi il core.
Lasso, sì come chiaro in
te si vede
Il tuo color sincero,
Scorgessi io sì de la mia
donna il vero;
O di mia speme allor
goder potrei,
O di mia fede ne’
tormenti miei!
Sia nel testo, sia nella musica
il madrigale si inserisce più
nella classica tradizione
tardorinascimentale che
nell’esasperata dimensione
barocca propria dell’ultimo
stile di Gesualdo: qui le
caratteristiche più ardite e
violente della sua scrittura pur
tralucendo a tratti si
stemperano in un accento di
contenuta e malinconica
dolcezza.
XIII.
Ardita
Zanzaretta
Morde colei che il mio
cor strugge e tiene
In così crude pene;
Fugge poi e rivola
In quel bel seno che il
mio cor invola,
Indi la prende e stringe
e le dà morte
Per sua felice sorte.
Ti morderò ancor io,
Dolce amato ben mio,
E se mi prendi e stringi,
ahi, verrò meno
Provando in quel ben sen
dolce veleno.
Il madrigale prende l’avvio da
un tenuissimo motivo classico
(il pseudovirgiliano culex)
sviluppato nella direzione di un
leggero e malizioso scherzo
erotico: il musicista ne fa il
pretesto per un descrittivismo
manieristico di estrema
virtuosità, che trascolora nel
finale, ove si incontrano passi
di singolare audacia di
scrittura, e di profonda
intensità emotiva, in una
conclusione che pare allo
Einstein "a1trettanto icastica e
naturalistica, ma quasi
patologica".
XIV.
Ardo per te,
mio bene, ma l’ardore
Spira dolce aura al core.
Moro per te, mia vita, ma
il morire
Gioia divien, dolcissimo
il languire.
Felice sorte ancor ch’io
arda e moia:
L’ardor divien dolce
àura, el morir gioia.
Il madrigale è costruito
attraverso una serie di violenti
contrapposti su parole tutte
cariche di una intensa
virtualità espressiva: (ardo,
moro, gioia, dolcissimo
languire..). Per tutto
l’arco della composizione
rimandano l’una all’altra, come
attraverso un gioco di specchi.
Il musicista le assapora
lentamente, come attraverso un
sottile godimento sensuale, sino
alla geniale conclusione, che
volutamente infrange lo schema
della struttura letteraria.
XV.
Ancide sol la
morte,
E tu, mio core, che la
vita sei,
Uccirler non mi puoi
Col dolce colpo de’ begli
occhi tuoi.
Io, morendo per te, lieto
morrei,
Se ferita mortale
Uscir potesse da beltà
vitale.
Il madrigale é tra i più unitari
e conseguenti di Gesualdo; si
organizza con ferrea logica in
una struttura rigidamente
unitaria, che si sviluppa senza
esitazioni o sbavature in un
fermo arco formale. Non si puù
tuttavia fare a meno di isolare
nella memoria certe icastiche
frasi, cariche di un singolare pathos,
come quella che apre il
madrigale.
XVI.
Quel "no"
crudel che la mia speme ancise
Ecco che pur trafitto
Da mille baci di mia
bocca ultrice,
Qual fiera serpe in mezzo
a i fori essangue,
Tra quelle belle labbra a
morte langue.
O vittoria felice!
In quel vago rossor gli
amanti scritto
Leggan: "Di quel bel
volto ha vinto Amore."
Amor vince ogni core.
Il raffinato e delicato scherzo
erotico che costituisce
l’elegante e svagata sostanza
poetica di questo madrigale
viene investito
nell’interpretazione di Gesualdo
da una violenta carica
passionale: si rivelano venature
di intensa e desolata mestizia,
che confermano ancora una volta
il senso drammatico che l’eros
assume in Gesualdo.
XVII.
Moro, lasso, al
mio duolo
E chi mi può dar vita,
Ahi, che m'ancide e non
vuol darmi aita!
O dolorosa sorte,
Chi dar vita mi può, ahi,
mi dà morte!
Qui il tono di cupa malinconia
del testo induce Gesualdo a dar
sfogo al suo più violento e
sfrenato rovello
espressionistico; ne nasce una
delle sue prove più audaci e
insieme una delle sue più alte
conquiste espressive.
XVIII.
Volan quasi
farfalle
A i vostri almi
splendori,
O bella donna, i
pargoletti Amori;
Indi scherzando
intorno al chiaro lume,
Chiaro sì, ma cocente,
Provan l’altra virtù,
quella ch’è ardente,
Ne le tènere piume;
E intorno a voi cadendo a
mille a rnille.
Tranno da le faville
Di lor penne riarse il
foco e poi
Fanno l'incendio onde
avampate voi.
Il preziosismo del madrigale
sollecita un parallelo
raffinatissimo gioco forrnale
sul piano musicale. La
composizione che ne deriva,
dalle ampie e maestose
proporzioni, ha una bellezza
astratta, quasi strumentale.
XIX.
Al mio gioir il
ciel si fa sereno,
Il crin fiorito il Sole a
i prati inaura.
Dànzano l’onde in mar al
suon de l’aura,
Cantan gli augei ridenti,
Scherzan con l’aria i
venti,
Così la gioia mia
versando il seno
Io d’ogni intorno inondo
E fo, col mio gioir,
gioioso il mondo.
Strette affinità con il
precedente ha questo madrigale,
che è un esempio significativo
delle improvvise aperture alla
gioia e alla serenità cui può
abbandonarsi, nella sua suprema
stagione, l’arte di Gesualdo;
qui il sentimento giunge a una
sospesa e goduta pace, a una
tersa trasparenza memore della
misura dei più puri madrigalisti
cinquecenteschi.
XX.
Tu segui, o
bella Clori,
Un fuggitivo core,
E 'l mio tu fuggi ch’arde
sol d’amore.
Ah, non fuggir chi t'ama,
Sprezza chi te non brama!
E s'hai d’amor desio
Ama me sol, perché te sol
amo io.
La muta presenza
dell’interlocutrice, cui si
rivolge, implorando amore e
pietà il madrigale, conferisce
al discorso musicale una
singolare intensità e un
profondo calore espressivo; in
questo tono dolcissimo, a fior
di labbra, in cui pure si
avverte una bruciante
partecipazione sentimentale,
l’arte di Gesualdo rivela la sua
misura più personale.
XXI.
Ancor che per
amarti io mi consumi,
In ogni parte e non a me
rimiri,
Tu, bramata cagion di
miei martiri,
Deh, volgi omai ver me
gli amati lumi
Poi che vil fango ancor
rimirar suole,
Senza oscurar i suoi bei
raggi, il Sole.
La forma ellittica con cui si
svolge il filo logico del
madrigale con una premessa (Ancor
che per amarti...) e una
spiegazione causale (poi che
vil fango...) che
inquadrano l’ardente invocazione
dell’amata (Deh, volgi omai
ver me gli amati lumi...)
suggeriscono una costruzione
ardita sul piano musicale; le
voci trattate all’inizio della
composizione singolarmente e a
gruppi, con larghe pause tra
un’entrata e l’altra delle
singole parti, vanno confluendo
al centro verso compatti blocchi
omoritmici, per sfrangiarsi di
nuovo alla conclusione in più
morbido e vago fluire.
XXII.
Già piansi nel
dolore;
Or gioisce il mio core
Perché dice il ben mio:
"Ardo per te ancor io."
Fuggan dunque le
noie, e 'l tristo pianto
Ormai si cangi in dolce e
lieto canto.
E' una prova di sublime
raffinatezza di stile, che
richiama tutti i più sottili
procedimenti della tecnica
madrigalistica. Si noti, tra gli
altri preziosismi, il
compiaciuto manierismo di alcuni
passi.
XXIII.
Quando ridente
e bella
Più vaga d’ogni stella
Mi si mostra Licori
E seco sclaerzan
lascivetti Amori,
Tutto gioisco e sì di
gioia abbondo
Che de la gioia mia
gioisce il mondo.
Su una nota di gioiosa letizia,
con una composizione inondata di
luce, di prorompente viralità
ritmica, si chiude la
monumentale opera madrigalistica
di Gesualdo: l’ultimo messaggio
di questo musicista violento e
sfrenato, dettato in un momento
tra i più tetri e infelici della
sua travagliatissima esistenza
è, singolarrnente, un inno
all’amore e alla gioia.
|
|