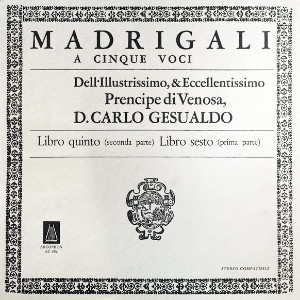 |
|
1 LP -
AC 682 - (p) 1965
|
 |
| 1 CD -
CRA 8912-5 - (c) 1996 |
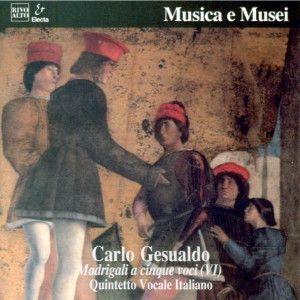 |
| 1 CD -
CRA 8912-6 - (c) 1996 |
|
Carlo
GESUALDO da Venosa (1566-1613)
|
|
|
|
|
|
| MADRIGALI
A CINQUE VOCI, LIBRO V (1611) -
seconda parte |
|
|
|
|
|
| - Asciugate
i begli occhi |
2' 48" |
|
| -
Tu m'uccidi, o crudele |
2' 58" |
|
| - Deh, coprite
il bel seno |
2' 19" |
|
| - Poichè l'avida
sete | Ma tu,
cagion |
6' 10" |
|
| - O tenebroso
giorno |
2' 58" |
|
| - Se tu fuggi |
2' 32" |
|
| - "T'amo mia
vita!" |
3' 00" |
|
|
|
|
| MADRIGALI
A CINQUE VOCI, LIBRO VI (1611) -
prima parte |
|
|
|
|
|
| - Se la mia
morte brami |
3' 10" |
|
| - Beltà, poi
che t'assenti |
2' 41" |
|
| - Tu piangi, o
Filli mia |
3' 28" |
|
| - Resta di
darmi noia |
2' 17" |
|
| - Chiaro
risplender suole |
4' 03" |
|
| - "Io parto" e
non più dissi |
3' 46" |
|
| - Mille volte
il dì, moro |
4' 17" |
|
| - O dolce il
mio tesoro |
3' 03" |
|
|
|
|
| QUINTETTO VOCALE
ITALIANO /
Angelo Ephrikian, direttore |
|
| - Karla
Schlean, soprano |
|
| - Rosanna Giancola,
mezzosoprano |
|
| - Clara
Foti, contralto |
|
| - Adele Bonay,
contralto |
|
| - Rodolfo
Farolfi, tenore |
|
| - Carlo Gaifa, tenore |
|
| - Gastone Sarti, basso |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Villa
Litta, Milano (Italia) - 20-27
maggio 1965 (Libro Quinto)
Villa Litta, Milano (Italia) -
21-30 settembre 1965 (Libro sesto)
|
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Giambattista
Pirelli / Karla Schlean - Angelo
Ephrikian |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Arcophon
- AC 682 - (1 LP) - durata 49' 30"
- (p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizione CD |
|
Rivo
Alto & Electa "Musica e Musei"
- CRA 8912-5 - (1 CD) - durata 67'
07" - (c) 1996 - ADD - (Libro
Quinto)
Rivo Alto &
Electa "Musica e Musei" - CRA
8912-6 - (1 CD) - durata 73' 32"
- (c) 1996 - ADD - (Libro Sesto) |
|
|
Note |
|
In
copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera
degli Sposi (particolare) -
Palazzo Ducale - Mantova - (Libro
Quinto)
In copertina
(CD): Andrea Mantegna, Camera
degli Sposi (particolare)
- Palazzo Ducale - Mantova -
(Libro Sesto)
|
|
|
|
|
IL
QUINTO E IL SESTO LIBRO DEI
MADRIGALI
Il quinto e il sesto libro dei
madrigali del Principe di Venosa
furono pubblicati quasi
contemporaneamente a Gesualdo
nel 1611, per i tipi di G.G.
Carlino e per cura di tale
Giovanni Pietro Cappuccio, certo
un cortigiano del principe che -
secondo la consuetudine - dedicò
la raccolta allo stesso
compositore: si trattava
ovviamente di uma finzione resa
necessaria dal costume del tempo
che vietava a un personaggio del
rango del Venosa di assumere
direttamente la responsabilità
della pubblicazione delle
proprie opere.
La data di composizione dei
madrigali raccolti nel quinto e
nel sesto libro si scagliona
presumibilmente lungo un arco di
tempo assai ampio, come si
deduce tra l’altro dalla dedica
del sesto libro al Gesualdo,
stesa dallo stesso Giovanni
Pietro Cappuccio: "Questi
madrigali della sesta muta
furono composti da V.E. nelli
medesirni anni che furono quelli
della quinta; e perciò questi
ancora sono stati aspettati con
grandissimo desiderio dal mondo
da sì lungo tempo". Si tratta
dunque di una scelta che
Gesualdo stesso compì delle
proprie opere composte dopo il
1596, con la consueta severità e
l’acuto senso critico che gli
vietò, per esempio, di divulgare
i suoi esperimenti in stile
monodico di cui è fatta menzione
da parte del Fontanelli (cfr. la
mia presentazione del III° Li-
bro dei Madrigali di Gesualdo,
Disco Arcophon AM 668) e le
canzonette pubblicate postume da
Pomponio Nenna nel proprio Ottavo
Libro dei Madrigali, Roma,
1618.
Nella sua critica vicenda
esistenziale che dovette
assumere negli ultimi anni
aspetti e momenti veramente
allucinanti, la musica non cessò
di essere un polo costante di
interesse, un campo di studio e
di ricerca assidua e febbrile,
nella quale Gesualdo impegnò la
parte migliore di sè, le sue
lucide doti intellettuali non
meno dell’appassionata dedizione
interiore. Tornato a Napoli nel
1597, raccolse intorno a sè
un’accademia musicale
comprendente Scipione Stella,
Rocco Rodio, Pomponio Nenna,
Muzio Efrem, Giovanni Macque,
Bartolomeo Roy, Giovambattista
di Pavolo, Scipione Cerreto,
Giustiniano Forcella, Domenico
Montella, "compositori, sonatori
e cantori eccellentissimi" che
il principe, secondo le parole
di un contemporaneo "per suo
gusto e intertenimento tiene in
sua corte a sue spese". Gesualdo
preso tutto dalla sua passione,
ignorava le accuse di eccessiva
prodigalità e di sperpero che la
sua famiglia gli moveva. Egli,
pontefice in questo eletto
cenacolo d’artisti, mirava certo
ad emulare i fasti musicali
della corte estense: desiderio
conferrnato dalla fondazione,
nel castello di Gesualdo, di una
stamperia musicale diretta da
G.G. Carlino, la stessa che
pubblicò i suoi due ultimi libri
di madrigali e una sua raccolta
di responsori.
Gesualdo volle consolidate la
sua fama di compositore,
pubblieando tra il quarto (1596)
e il quinto (1611) libro di
madrigali tre raccolte di musica
religiosa: Sacrarum
Cantionum Quinque Vocibus
Liber Primus (1603); Sacrarum
Cantionum Liber Primus Quarum
Una Septem Vocibus, Ceterae
Sex Vocibus Singulari
Artificio Compositae
(1603); Responsoria et Alia
ad Officium Hebdomadae Sanctae
Spectantia, a sei voci
(1611). Opere tutte, a parte
ogni ricerca di carattere
espressivo, veramente "singulari
artificio composiate",
sulla linea della più rigorosa
arte contrappuntistica
cinquecentesca. Per quanto più
propriamente concerne le ultime
due raccolte di madrigali, si
nota una sostanziale
continuazione degli
atteggiamenti espressivi
maturati nei libri precedenti,
soprattutto nel quarto. Nella
scelta dei testi incontriamo
ancora la predilezione per
poesie brevi e di limitate
pretese letterarie (nel Quinto
Libro, su ventuno madrigali, uno
solo, l’ultimo, è dovuto a un
autore illustre, Giovanbattista
Guarini). In questo modo
Gesualdo si riserva da parte sua
la massima possibilità
d`intervento, sia dal punto di
vista di un’autonoma
organizzazione strutturale del
madrigale, sia da quello di una
totale ricreazione semantica del
contenuto espressivo della
poesia. Secondo la fine
notazione critica di Nino
Pirrotta "non “serva” ma
“compagna" dell’orazione, la
musica ha il compito di dire ciò
che è indicibile a parole, di
esprimere coi rivolgimenti
cromatici il torcersi dell’anima
nel dolore, con i salti melodici
violenti e inconsueti la sfida
del sarcasmo e della ribellione,
con i travolgenti contrappunti
di diatoniche colorature di
quest'ultimo periodo... il
fervore disperato della speranza
o il dilatarsi panico della
personalità nella gioia".
I gesti espressivi si
semplificano, sino a ridursi
all’alternanza e alla
successione di atmosfere
espressive nettamente
contrastanti: è come se la
poetica espressionistica di
Gesualdo, portata alle sue
ultime conseguenze non
riconoscesse altro che la
possibilità di un procedere
apodittico, articolato
attraverso la contrapposizione
di concetti e di momenti
opposti, che solo la ferrea
logica con cui è condotto il
discorso riesce a fondere in una
struttura organica. Ancora più
sviluppato che non nel quarto
libro è il parametro armonico,
piegato ad audacie che per più
di due secoli non furono emulate
nella tradizione musicale
occidentale. Parallelamente, la
tecnica contrappuntistica si
decanta sino a raggiungere una
sorta di astratta e cristallina
purezza, soprattutto laddove
essa è impiegata in quei passi
che Vincenzo Giustiniani
definiva "fughe dolci e
correnti"; momenti nei quali
Gesualdo raggiunge una gioiosa e
prorompente pienezza di vita.
Accanto a questo si delinea
negli ultimi due libri di
madrigali un tipo di
contrappunto affatto nuovo, che
potrebbe delinirsi, con il
Pirrotta, "contrappunto di
recitativi, dacché la sua
sostanza non è più il gioco
delle immagini sonore in
movirnento, ma la
moltiplicazione
contrappuntistica dell’intensità
affettiva della declamazione".
Un calore umano tutto nuovo
hanno i passi trattati
omoritmicamente in un declamato
accordale aperto a preziose,
ricchissime sfumature di senso,
e, in generale, a un accento di
straordinaria immediatezza e
verità umane.
Anche da un punto di vista
contenutistico le due ultime
raccolte chiudono circolarmente
la tematica estetica di
Gesualdo: suggellano, portandolo
alle ultime conseguenze, in una
sorta di apoteosi lucida, ma
pure allucinata e barocca, il
tema unico della sua arte,
l’amore. Con le parole del
Pirrotta: "Egli fu, si direbbe,
romanticamente innamorato del
complesso cerimoniale del
corteggiamento amoroso, delle
promesse deluse, delle negazioni
provocanti, delle speranze
risorgenti. La vita non gli
diede che delusioni,
incomprensioni coniugali o
troppo facili avventure
degradanti del senso. Pure il
sogno persiste fino all’ultimo,
si rinnova anzi negli ultimi
anni in una fase gioiosa che le
fasi precedenti non avevano
conosciuto".
LIBRO QUINTO
(Seconda Parte)
XIV.
Asciugate i
begli occbi,
Deh, cor mio, non
piangete
Se lontano da voi gir mi
vedete!
Ahi, che pianger debb’io
misero e solo
Che partendo da voi
m’uccide il duolo.
Tutto giocato su parole
privilegiate, è tra i madrigali
più belli della raccolta: più
che in altri pezzi, assume qui
primaria importanza, ai fini
espressivi, il pararnetro
timbrico, trattato con singolare
sensibilità in preziosi effetti
cromatici.
XV.
Tu m’uccidi, o
crudele,
D'Amor empia omicida,
E vuoi ch'io taccia e 'l
mio morir non grida?
Ahi, non si può tacer
l’aspro martire
Che va innanzi al morire,
Ond’io ne vo gridando:
"Oimè, ch’io moro
amando!"
Il madrigale viene articolandosi
attraverso una minuta analisi
dei singoli nessi semantici, con
un rovello quasi
espressionistico: la chiara
struttura bipartita del testo
poetico viene così infranta in
favore di una pittura
violentemente chiaroscurata, in
libero e continuo divenire.
XVI.
Deh, coprite il
bel seno,
Che per troppo mirar
l'alma vien meno!
Ahi, nol coprite, no, che
l'alma avezza
A viver di dolcezza
Spera, miranda, aíta
Da quel bel sen, che le
dà morte e vita.
Sia nel testo, un’estenuata e un
po’ perversa fantasia erotica,
sia nella musica si è certo di
fronte a una composizione
manieristica. Assai
interessante, tuttavia, per una
definizione dell’estremo stile
di Gesualdo la violenta
contrapposizione di figurazioni
musicali, intese a rendere, con
icastica evidenza, il contenuto
concettuale e sentimentale del
testo.
XVII.
Prima Parte:
Poichè l'avida
sete
C’hai del mio tristo e
lagrimoso umore
Non è ancor spenta, o
dispietato core,
Spengala il sangue mio
C'or verserà dal mio
trafitto petto
Un doloroso rio.
Seconda Parte:
Ma tu, cagion
di quella atroce pena
Che a la morte mi mena,
Mira, mal grado tuo,
pietoso effetto
De la tua crudeltà, del
mio tormento
Che morendo al mio duol,
morte non sento.
In questi due ampi madrigali,
riuniti a formare un unico arco
espressivo, si ha un esempio di
quello stile che si era più
sopra definito "contrappunto di
recitativi", una delle conquiste
de1l’ultimo linguaggio di
Gesualdo.
XVIII.
O tenebroso
giorno,
Infelice mia stato,
O mio cor tristo, sol a
pianger nato!
Quando lieto ritorno
Farai dinanzi a quella
Che è più d’ogni altra
bella,
Più leggiadra e più vaga,
Che can suoi sguardi
morte e vita appaga?
E' un dolcissirno vagheggiamento
dell’amata, bella e lontana; la
tristezza del distacco e la
serenante immagine della donna
sono rese in due sezioni
nettamente distinte sul piano
stilistico e su quello
significativo.
XIX.
Se tu fuggi, io
non resto
Che 'l cor ti segue
e grida.
Ahi, cor crudele, ove
impietà s'annida,
Dove ten vai?
Deh, pria mi rendi il
core
E poi ten fuggi e fugga
teco amore!
La sezione iniziale e quella
finale, giocate su una serie di
veloci irnitazioni
contrappuntistiche (in
concomitanza con 1’idea della
"fuga"), inquadrano un episodio
centrale svolto prevalentememe
attraverso una drammatica
declamazione accordale.
XX.
"T’amo, mia
vita!" la mia cara vita
Mi dice e in questa sola
Dolcissima parola
Par che trasformi
lietamente il core
Per farsene signore.
O voce di dolcezza e di
diletto,
Prendila tosto, Amore,
Stampala nel mio core!
Spiri solo per te l'anima
mia
"T'amo, mia vita", la mia
vita sia.
L’eleganza raffinata della
poesia di Giovanbattista Guarini
detta a Gesualdo una
composizione dolcissima, che
chiude questo quinto libro su
una nota di sospesa serenità.
LIBRO SESTO
(Prima parte)
I.
Se la mia morte
brami,
Crudel, lieto ne moro
E dopo morte ancor te
solo adoro.
Ma se vuoi ch’io non
t'ami,
Ahi, che a pensarlo solo,
Il duol m’ancide e l’alma
fugge a volo.
Il piano formale del madrigale
presenta due sezioni, la seconda
delle quali ritornellata (ABB):
trattata in un denso, vischioso
si direbbe, cromatismo la prima,
nella quale caratteristicamente
in ogni verso compare il
concetto chiave della morte, in
un più terso e leggero
linguaggio armonico la seconda,
che si risolve nel volo leggero
di leggiadri contrappunti
correnti dell’aereo finale.
Caratteristico del compiaciuto
gioco di ambiguità modale che
caratterizza questo madrigale,
come la maggior parte delle
composizioni del sesto libro.
II.
Beltà, poi cbe
t’assenti,
Come ne porti il cor,
porta i tormenti.
Chè tormentato cor può
ben sentire
La doglia del morire,
E un'alma senza core
Non può sentir dolore.
La poesia è costruita sulla
esasperazione di una metafora
tipica della poesia per musica
del primo Seicento. Altissima la
resa musicale: si osservi come
all’esasperazione del paramento
armonico si associ un gusto
asciutto e crudo per gli urti,
gli scontri e gli attriti delle
parti contrappuntistiche, che
Gesualdo può aver mediato
dall’estrema produzione
madrigalistica di Luca Marenzio.
Di singolare bellezza ed
efficacia espressiva e la
lunghissima progressione
cromatica che si sviluppa, di
voce in voce, dal basso al
soprano, per più di un’ottava e
mezza.
III.
Tu piangi, o
Filli mia,
E pensi estinguer
quell’ardente fiamma
Che sì dolce m’infiamma.
Ahi, che sì picciol
pianto fa che il core
Tanto più avvampi di
vivace ardore.
Si tratta di uno dei madrigali
pin interessanti per definire la
libertà con la quale Gesualdo si
pone di fronte al testo. Alla
chiara stesura bipartita della
poesia, Gesualdo oppone
un’architettura musicale assai
più libera e complessa, ma non
meno perspicua sotto il profile
formale, reiterando in forma di
libera variazione i primi tre
versi, evidenziando al massimo
l’esclamazione del quarto, che
diviene il punto focale della
composizione e riservando
all’ultimo un’intera, ampia
sezione ritornellata, nella
quale le voci sono trattate in
uno scorrevole contrappunto di
sapore squisitamente
strumentale.
IV.
Resta di darmi
noia,
Pensier crudo e fallace,
Ch'esser non può già mai
quel che a te piace!
Morta è per me la gioia,
Onde sperar non lice
D'esser mai più felice.
E' questo uno dei più celebri,
se non il più celebre madrigale
di Gesualdo. Già i contemporanei
ne sottolineavano
l’eccezionalità, sotto il
profilo musicale ed espressivo.
Così, G.B. Doni, nel Compendio
del Trattato de’ Generi e de'
Modi della Musica, 1635
osserva: "...oggi non si trovano
composizioni cromatiche vere
(non che enarmoniche)
eccettuatene alcune poche, che
ne hanno qualche mistura; come
quell’artificiosissimo madrigale
del Principe: Resta di darmi
noia...". E Pietro della
Valle ricordava commosso
l’intensa emozione che,
giovinetto, gli aveva dato
l’ascolto della composizione di
Gesualdo: "...mi piaceva per
affetto pietoso e
compassionevole Resta di
darmi noia del Principe di
Venosa, famoso madrigale" (Della
musica dell’età nostra che non
è punto inferiore, anzi è
superiore a quella dell’età
passata, 1640).
Opera davvero
"artificiosissima", si segnala
come una delle Vette stilistiche
dell’ultima stagione dell’arte
di Gesualdo, che ritrova qui una
misura di estrema intensità
espressiva, unita a
quell’accento di pacata e
sommessa interiorità proprio dei
suoi momenti più felici.
V.
Chiaro
risplender suole
A tutti il mio bel sole,
Ma oscuro e fosco a me
misero appare,
Onde in lagrime amare
Consumo la mia vita.
Ah s’io potessi almen
chiederle aita!
Lieto all'or ne morrei
E finirìan, oimè, gli
affanni miei.
Vien meno in questo madrigale
l'espressionistica ricerca
armonica delle composizioni
precedenti, mentre sulla più
tersa e distesa tessitura
musicale vien fatto risaltare
dal musicista l’elemento
timbrico, che gioca sin dalla
contrapposizione iniziale, quasi
programmatica (Chiaro
risplender suole a tutti il mio
bel sole / Ma oscuro e fosco
a me misero appare) un
fondamentale ruolo
significativo.
VI.
"Io parto" e
non più dissi, che il dolore
Privò di vita il core.
Allor proruppe in pianto
e disse Clori
Con interrotti omèi:
"Dunque a i dolori
Io resto. Ah, non fia mai
Ch’io non languisca in
dolorosi lai."
Morto fui, vivo son, che
i spirti spenti
Tornaro in
vita a sì pietosi accenti.
La virtuale struttura drammatica
del madrigale offre il destro al
musicista di proiettare la
vicenda espressiva su una
prospettiva mossa e franta,
ricchissima di delicatissime
sfumature di senso.
VII.
Mille volte il
dì moro,
E voi, empi sospiri,
Non fate, oimè, che in
sospirando io spiri?
E tu, alma crudele, se
il mio duolo
T'affigge sì, che non
ten' fuggi a volo?
Ahi, che sol Morte al mio
duol aspro e rio
Divien pietosa e ancide
il viver mio!
Così dunque i sospiri e
l'alma mia
Sono ver me spietati e
Morte pia.
Da questo testo poetico, che è
la quintessenza dei motivi più
vieti e triti della poesia
madrigalistica
Cinque-secentesca, Gesualdo ha
tratto una composizione di
altissimo livello espressivo.
Dal suo tessuto musicale, un
seguito di sfolgoranti
intuizioni poetiche degne della
fantasia di un artista quale
Gongora, isoliamo l’ultima
sezione, nella quale il
manierismo del testo viene
trasigurato in accenti di una
poesia allucinata e metafisica.
VIII.
O dolce mio
tesoro,
Non mirar s’io mi moro,
Che il tuo vitale sguardo
Non fa che mi consumi il
foco ond'ardo.
Ah no, mìrami pur, ànima
mia,
Che vita allor mi fia la
morte mia!
L’anonimo poeta tocca in questo
madrigale il culmine del suo
freddo e convenzionale
concettismo. Gesualdo ne ha
fatto un’ampia composizione
dall’incalzante ritmo narrativo,
che tocca il suo clima nella
rilevata esclamazione centrale:
"Ah, no, mìrami pur, anima
mia", e nel finale, che si
apre nell’improvviso raggio di
luce dell’ultimo, inaspettato
accordo perfetto di mi maggiore.
|
|