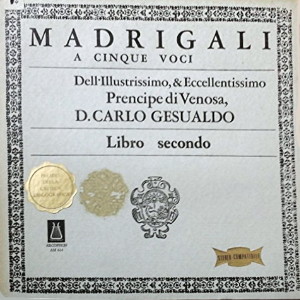 |
|
1 LP -
AM 664 - (p) 1965
|
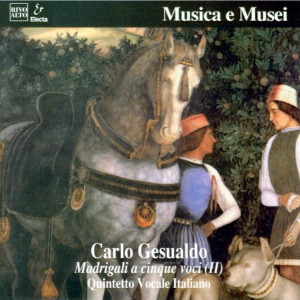 |
| 1 CD -
CRA 8912-2 - (c) 1996 |
|
Carlo
GESUALDO da Venosa (1566-1613)
|
|
|
|
|
|
| MADRIGALI A CINQUE VOCI,
LIBRO II (1594) |
|
|
|
|
|
- Caro amoroso
nèo | Ma se tale ha costei
|
4' 19"
|
|
| - Hai rotto, e
sciolto |
3' 37" |
|
-
Se per lieve ferita | Che
sentir deve
|
6' 07" |
|
| -
In più leggiadro velo |
3' 15" |
|
- Se così
dolce è il duolo | Ma
s'avverrà ch'io moia
|
3' 23"
|
|
| - Se taccio,
il duol s'avanza |
2' 45" |
|
- O come è
gran martire | O mio
soave ardore
|
3' 21"
|
|
|
|
|
| - Sento che
nel partire |
5' 29" |
|
- Non è questa
la mano | Nè tien face o
saetta
|
4' 12"
|
|
| - Candida man |
2' 49" |
|
- Da l'odorate spoglie
| E quell'arpa felice
|
3' 22"
|
|
| - Non mai non
cangerò |
2' 50" |
|
| - All'apparir
di quelle |
2' 56" |
|
| - Non mi toglia il
ben mio |
2' 10" |
|
|
|
|
| QUINTETTO VOCALE
ITALIANO /
Angelo Ephrikian, direttore |
|
| - Karla
Schlean, soprano |
|
| - Clara
Foti, mezzosoprano |
|
| - Rashida Agosti,
contralto |
|
| - Rodolfo
Farolfi, tenore |
|
| - Gastone Sarti,
basso |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Villa
Litta, Milano (Italia) - 12-19
febbraio 1965 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Giambattista
Pirelli / Karla Schlean - Angelo
Ephrikian |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Arcophon
- AM 664 - (1 LP) - durata 52' 18"
- (p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizione CD |
|
Rivo
Alto & Electa "Musica e Musei"
- CRA 8912-2 - (1 CD) - durata 52'
18" - (c) 1996 - ADD |
|
|
Note |
|
In
copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera
degli Sposi (particolare) -
Palazzo Ducale - Mantova |
|
|
|
|
IL
SECONDO LIBRO DEI MADRIGALI
Il Secondo Libro dei Madrigali
di Carlo Gesualdo, pubblicato
come il primo, nel 1594,
rappresenta, nell’evoluzione
stilistica del cornpositore, la
dimostrazione di un assoluto
padroneggiamento della tecnica e
la perfetta adeguazione al
modulo linguistico della civiltà
madrigalistica contemporanea, e
insieme la prima rivelazione di
un nuovo mondo espressivo, di
un’inedita misura artistica ed
umana.
Gesualdo ci appare il musicista
finissimo ed aristocratico che
ricrea con rara perizia
d'artefice, e quasi prolunga
nello atto compositivo,
l'atmosfera raffinata della sua
accademia musicale, cui
partecipavano le più eminenti
personalità artistiche della
Napoli del suo tempo, Giovanni
de Macque, Bartolomeo Roy,
Pomponio Nenna.
Se le estreme prove del quinto e
del sesto libro presuppongono un
dialogo solitario e allucinato
del musicista con la sua
materia, questi madrigali non si
comprendono al di fuori di un
deterrninato ambiente, di un ben
definito contesto culturale e
mondano.
Un musicisia soprattutto, sembra
attirare irresistibilmente
l’attenzione di Gesualdo: Luca
Marenzio. Ma non mancano anche
scoperte allusioni ad altri
compositori, specie ai grandi
fiamminghi: a Cipriano de Rore,
per esempio, in Sento che
nel partire, o a Giaches
de Wert, in Da le odorate
spoglie.
Questo Secondo Libro, contiene
tuttavia ben altro che una
semplice adesione ai modi
illustri della contemporanea
civiltà madrigalistica.
Sorvoleremmo su certe
particolarità segnalate
dall’Einstein, allusive alla
condizione di nobile
"dilettante" del rnusicista,
"particolarità ruvide e
sgraziate, come la densa
condotta delle parti, gli urti
delle voci che tradiscono un
orecchio stranamente
insensibile, l'indifferenza alle
false relazioni...". Più
interessante ci sembra invece
l'affermazione dello stesso
studioso circa "il più
pronunciato stacco tra le
sezioni contrappuntisticamente
animate e quelle omoritmiche, o
sovraccaricate da tentazioni
armoniche" rispetto agli
analoghi passi nelle
composizioni di Luca Marenzio.
In realtà, Gesualdo rivela sin
da ora, anche se in maniera
discontinua ed episodica, specie
laddove il testo lo solleciti a
una più intensa partecipazione
sentimentale (si vedano al
proposito soprattutto i
madrigali; Se taccio il duol
s’avanza, Sento che
nel partire, Non é
questa la mano) molti
tratti della sua arte maggiore:
in particolare la peculiare
concentrazione espressiva del
linguaggio musicale e la nervosa
strutturazione formale,
procedente per episodi
contrastanti.
Seguire l’inquieto tralucere di
una nuova misura d’arte e
d’umanità nelle pieghe di un
discorso sostenuto da una
profonda e aristocratica
esperienza culturale, è tra i
piaceri più singolari che
l’ascolto di questo disco può
offrire.
*****
Caro amoroso néo
ch’illustri un sì bel
volto
col negro tuo fra 'l suo
candor avvolto,
se per te stesso sei
tu pur macchia e difetto,
con qual’arte perfetto
poi rendi 'l colmo de le
grazie in lei!
Ma se tale
ha costei
in sua beltà le mende,
qual poi saranno i fregi
ond’ella splende?
(T. Tasso)
In questo primo madrigale, in
due parti, Gesualdo interpreta
il testo tassesco, già presago
di certa tematica ampiamente
sfruttata dalla poesia barocca,
in maniera esasperatamente
analitica. Lo scherzo di
società, elegantemente galante,
acquista nella trasposizione
musicale un accento più serio e
tormentato; sotto le forme
leggiadramente modellate della
musica, si sente urgere uno
spirito ardente e una sensualità
inquieta.
Hai rotto e sciolto e spento
a poco a poco
lo stral e il laccio e ’l
foco
cbe punse, che legò,
ch'arse ’l mio core.
O me beato, Amore,
che sento, e senza pena,
altro dardo, altra
fiamma, altra catena.
E’ tra i madrigali di questo
Secondo Libro il più vicino a un
tipo di interpretazione non si
dice convenzionale, ma certo
meno profondamente personale del
testo poetico. Pure, anche
attraverso l’uso di tratti
stilistici largamente diffusi
nella prassi compositiva del
secondo Cinquecento, è possibile
scorgere la più vera fisionomia
artistica del Gesualdo: specie
nell’estatica e sospesa
espressione di certe
esclamazioni commosse e nella
contrapposizione di episodi
profondamente contrastanti nel
ritmo, nell’agogica e nella
tematica.
Se per lieve ferita
onde te stessa offendi,
così dogliosa, o bella
man, ti rendi,
menlre tue bianche nevi
rare inostrano e brevi
di liquidi rubin parpuree
stille,
che sentir deve 'l petto
mio che langue
versando ognor da mille
piaghe e mille
per le vene del cor fiumi
di sangue?
Ahi, che a maggior dolore
convien pietà maggiore!
Vi è qui, seppur moderata da
un’esrtema eleganza e misura
mondana, l’intensità e il pathos
del Gesualdo maggiore. La
musica, espansa in due ampie e
distinte sezioni, si direbbe
distilli e assapori lentamente
le parole del testo, non privo
(nella contemplazione della mano
femminile solcata dai sottili
rivoli di sangue) di una
tonalità "morbida", che Gesualdo
non deve avere avvertita
estranea.
che non le nubi in cielo
In più leggiadro velo
Madonna il suo bel visa
discoperse,
Amor, deh, che in quel
punto
non so se il cor fu pria
degli occhi punto!
onde un raggio discese
che gli occhi e 'l cor
m'accese.
Nella sua levità, è tra i
madrigali più felicemente
compiuti e compiuti sul piano
espressivo. Si noti come la
musica riesca a rendere, nella
casta essenzialità dei suoi
gesti, il senso di sorpresa
all’apparire inaspettato del
leggiadro volto femminile e la
sommessa malinconia del sospeso,
amoroso vagheggiamento della
bellezza.
Se così dolce è il duolo,
deh, qual dolcezza
aspetto
d'imaginato mio novo
diletto!
Ma s'avverrà ch’io moia
di piacer e di gioia,
non ritardi la morte
sì lieto fine e sì felice
sorte.
(T.
Tasso)
Lo squisito testo
del Tasso sollecita in Gesualdo
un'intensa ricerca espressiva;
ma per giudicare la distanza che
separa il musicista dalle prove
della sua maturità, si confronti
con quanta più personale
partecipazione egli tratti
l’identico inciso "Ma
avverrà ch'io moia",
accolto nel Libro quarto dei
Madrigali, di dieci anni a
questo posteriore.
Se taccio il duol s’avanza,
se parlo accresce l'ira
donna bella e crudel che
mi martira.
Ma pur prendo speranza
che l'umiltà vi pieghi,
chè nel silenzio ancor
son voci e prieghi.
(T. Tasso)
E’ un madrigale degno delle
massime prove del musicista. Nel
testo tassesco il Gesualdo ha
trovato un invito al suo
peculiare modus operandi,
procedente per contrapposti,
attraverso il quale le sue
musiche acquistano la loro
caratteristica, inconfondibile
densità significativa. La chiusa
del madrigale: "ché nel
silenzio ancor son voci e
prighi" potrebbe essere
posta ad epigrafe dell’arte del
Gesualdo, nella quale il
silenzio - un silenzio carico di
tensione e di pathos - concorre,
come nel contemporaneo luminismo
pittorico l’ombra, non meno
della musica alla delineazione
di un acceso e vibrante mondo
sentimentale.
O come è gran martire
a celar suo desire
quando con pura fede
s'ama chi non se 'l
crede!
O mio soave ardore,
o dolce mio desire,
s'ognun ama il sua core
e voi sete il cor mio,
allor fia che non v’ami,
cbe viver più non brami.
La situazione evocata dal testo
(peraltro tra i loci
communes della poetica
madrigalistica), suggerisce a
Gesualdo un madrigale in due
parti, distesamente modellato
attraverso una piana
declamazione accordiale, che
solo alla fine si increspa in
brevi disegni imitati, a
contatto con le ultime parole,
più intensamente drammatiche.
Sento che col partire
il cor giunge al morire
ond’io misero ognora,
ogni momento
grido: morire mi sento!
non sperando di fare a
voi ritorno.
E così dico mille volle
il giorno:
partir io non vorrei
se col partir accresco i
dolor miei.
Sarà interessante rilevare che
questo madrigale è una sorta di
parafrasi negativa di quello,
celeberrimo nel Cinquecento di
Alfonso d’Avalos marchese del
Vasto, musicato, tra gli altri,
da Cipriano de Rore:
Ancor
che nel partire
Io mi senta
morire,
Partir vorrei
ogni momento
Tant’è il piacer
che sento
De la vita
ch’acquisto nel ritorno.
E così mille e
mille volte il giorno
Partir da voi
vorrei,
Tanto son dolci
i ritorni miei.
Gesualdo non esita
a misurarsi con il de Rore in
una grande composizione in due
parti, che dilata al massimo la
trama semantica del testo; e si
direbbe che il capovolgimento
della situazione sentimentale
delineata dal madrigale del de
Rore non derivi da un puro gioco
letterario, ma sia motivata, per
Gesualdo, da intrinseche,
profonde ragioni espressive.
Non è questa la mano
che tante e sì mortali
avventò nel mio cor
fiammelle e strali?
Ecco che par si trova
ne le mie man ristretta,
nè forza od arte per
fuggir le giova.
Nè tien face o saetta
che da me la difenda.
Giusto è ben ch'io ne
prenda,
Amor, qualche vendetta
e se piaghe mi die’, baci
le renda.
(T. Tasso)
Sin dall’esordio appassionato,
questo madrigale ci fa
comprendere come Gesualdo sia
incapace di mantenersi entro un
ambito disteso e pacato di
affetti, ma tenda, dall’inizio
della sua attività compositiva,
ad accentuare le tinte, a
marcare i contrasti, a disporre
insomma la sua fantasia in una
prospettiva virtualmente
drammatica anche quando, come in
questo caso, il testo (finissima
prova letteraria del Tasso), si
risolva in elegante
divertimento.
Candida man qual neve a gli
occhi offerse
la mia cara angioletta
per far strana vendetta
de l'acceso mio core
che, ingannata al
candore,
sperando di temprar sue
fiamme, forse
precipitoso corse.
O me misero, Amore,
chè ne la neve sento
ardor maggiore!
E’ un’altra prova di stile; pur
nell’analitica e puntuale
pittura dei singoli nuclei
testuali, il madrigale riesce a
raggiungere un perfetto
equilibrio di struttura, in
virtù dei suoi puri valori
musicali.
Da le odorate spoglie
sciogliete ormai la mano
che il mio voler e
disvoler mi toglie;
e quell'arpa felice
a cui non si disdice
stringersi col bel petto,
d’Amor fido ricetto,
togliete, e con
l’usata leggiadria,
fateci udir, cara la vita
mia.
Come nel madrigale Sento che
nel partire vi era un
esplicito riferimento a Cipriano
de Rore, è indubbio che
Gesualdo, scegliendo questo
testo, abbia voluto rendere
ornaggio a un altro grande
musicista fiammingo, Giaches de
Wert. Suo è infatti il madrigale
(più volte utilizzato nel
Cinquecento anche come base per
composizioni religiose), che si
immagina eseguito sul liuto
dalla bella cantatrice: Cara
la vita mia. La musica
leggiadramente dipinge la scena,
con partecipazione e distacco
insieme, come si conviene a uno
squisito divertimento di
società.
Non mai non cangerò
stato, voglia e pensiero
che la cruda nemica del
mio core
con dolcissimo impero
volge la mia vita i
giorni e l'ore
e tempra i miei desiri
or con speme, or con
gioia, or con martiri.
E’ un delicatissimo madrigale,
soffuso tutto di una dolce
malinconia: qui Gesualclo emula
Luca Marenzio nella delineazione
di un’atmosfera sentimentale
singolarmente tenue e sfumata.
A l'apparir di quelle luci
ardenti
il duol che sì m'annoia
subito sparve e
convertissi in gioia.
Amor, ferisci pur, ardi e
saetta
se un così picciol ben
tanto diletta!
Gesualdo è un maestro nella
pittura di un divenire
psicologico magistralmente
sviluppato nell’arco fermo e
netto del divenire formale;
sentimento e struttura musicale
concorrono del pari alla
creazione di un madrigale tra i
più belli della raccolta.
Non mi toglia il ben mio
chi non arde d’amor come
faccio io.
Io solo avrò de la mia
donna il core:
dunque lasci il ben mio
chi non arde d'amor come
faccio io.
L’ultimo madrigale del Secondo
Libro si fà notare, più che per
intrinseci pregi di scrittura,
come un documento della
propensione caratteristica del
nostro autore, quando si trovi
di fronte a un testo piuttosto
neutro, come il presente, a
risolvere la composizione in
puri ed autonomi valori
musicali, attraverso la libera
iterazione di frammenti e di
nuclei tematici.
|
|