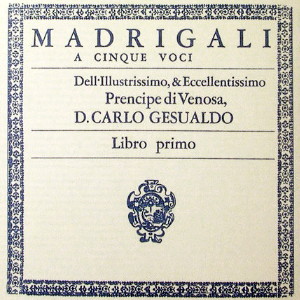 |
|
1 LP -
AM 656 - (p) 1965
|
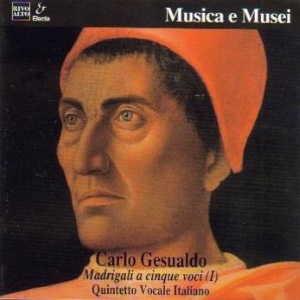 |
| 1 CD -
CRA 8912-1 - (c) 1996 |
|
Carlo
GESUALDO da Venosa (1566-1613)
|
|
|
|
|
|
MADRIGALI A CINQUE VOCI,
LIBRO I (1594)
|
|
|
|
|
|
- Baci soavi e
cari | Quanto ha di dolce
Amore
|
6' 02"
|
|
- Madonna, io
ben vorrei
|
3' 28" |
|
| -
Com'esser può |
2' 43" |
|
| - Gelo ha
madonna il seno |
2' 44" |
|
- Mentre
madonna | Ahi! troppo
saggia
|
4' 58"
|
|
| - Se da sì nobil mano |
2' 20" |
|
| - Amor, pace
non chero |
1' 21" |
|
| - Sì gioioso
mi fanno |
2' 22" |
|
|
|
|
| - O dolce mio
martire |
3' 00" |
|
- Tirsi morir
volea | Frenò Tirsi il
desio
|
5' 45" |
|
| - Mentre, mia
stella, miri |
2' 13" |
|
| - Non mirar,
non mirare |
2' 56" |
|
| - Questi
leggiadri |
3' 43" |
|
- Felice
primavera! | Danzan le
Ninfe
|
3' 58" |
|
| - Son sì belle le rose |
1' 59" |
|
| - Bell'angioletta |
2' 02" |
|
|
|
|
QUINTETTO VOCALE
ITALIANO /
Angelo Ephrikian, direttore
|
|
| - Karla
Schlean, soprano |
|
| - Clara
Foti, mezzosoprano |
|
| - Elena
Mazzoni, contralto |
|
| - Rodolfo
Farolfi, tenore |
|
| - Gastone
Sarti, baritone |
|
| - Dmitri
Nabokov, basso |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Villa
Litta, Milano (Italia) - 10-15
gennaio 1965 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Giambattista
Pirelli / Karla Schlean - Angelo
Ephrikian |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Arcophon
- AM 656 - (1 LP) - durata 53' 53"
- (p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizione CD |
|
Rivo
Alto & Electa "Musica e Musei"
- CRA 8912-1 - (1 CD) - durata 53'
53" - (c) 1996 - ADD |
|
|
Note |
|
In
copertina (CD): Andrea Mantegna, Ritratto
d'uomo - Galleria degli
Uffizi - Firenze |
|
|
|
|
1. BACI SOAVI E CARI
È
caratteristico di Gesualdo
costruire il suo madrigale
attorno ad un sentimento
centrale, a un pensiero sotteso
che a poco a poco emerge e
finalmente s’impone come
essenziale nucleo poetico della
composizione. Questo sentimento
egli sceglie liberamente tra
quelli che un testo spesso
anodino gli suggerisce: e se il
testo gli suggerisce l’idea
della morte, è
questa l’idea che fatalmente lo
attrae. È
ciò che
avviene in questo primo “doppio”
madrigale: nella prima parte le
parole: “... non sente il duol
di morte - e pur si muore”; e
nella seconda “... la mia vita
finire - oh, che dolce morire”
danno origine ai momenti
musicalmente più
commossi. Non si può ascoltare
senza emozione il drammatico
ascendente di ottava del tenore
(ripreso alla fine dal
contralto) sulle parole “si muore”: né la
sconsolata melodia (II parte) sulle
parole “la mia vita finire”, da
cui si sviluppa, con impressionante
vigore patetico, il finale “oh,
che dolce morire”.
2. MADONNA, IO BEN VORREI
Se si esclude un breve episodio
sulle parole “... che l’uno al
cor darìa”,
in cui la rigidezza
del procedimento imitativo è
riscattata dalla vivacità del ritmo e da
una timbrica vocale
particolarmente attraente, il
madrigale è
tutto un abbandonarsi delle
singole voci a espressioni
musicali “recitanti” (tutto
l’episodio sulle parole “... o
tanta crudeltate”; e l’altro
sulle parole “... o l'altra finiria la vita
mia”). Il giudizio di
Pietro della Valle, che colloca
Gesualdo come maestro del nuovo
mondo musicale monodico, trova
qui certamente una delle sue più valide
giustificazioni.
3. COM’ESSER PUÒ
Di un testo intessuto su
consuetudinarie e artificiose
secentesche antinomie, Gesualdo
coglie e riesprime musicalmente
il senso d’una angosciosa
interrogazione senza risposta e
ne fa la costante poetica di
tutta la breve composizione.
4. GELO HA MADONNA IL SENO
Il testo è
del Tasso; ma non si discosta
qui dal consueto formulario di
artificiose
contrapposizioni verbali (“gelo-fiamma”,
“ghiaccio-fuoco”, e via
dicendo). Gesualdo lo riveste di
una music di carattere
essenzialmente lirico: la melodia vi
predomina con accenti di
profonda cornmozione (vedi la
bellissima frase “Io son ghiaccio
di fuore”, e l‘altra, verso la
fine, “sì ch’io
l’abbia negli occhi”): onde si
ha l’impressione (suggerita
anche dall’assenza di
agglomerati armonici di
particolare rilievo) che
l’intero madrigale si sviluppi
in un’atmosfera “monodica” che,
nell’esecuzione, va messa in
giusta evidenza.
5. MENTRE MADONNA
È un
madrigale “doppio”, articolato
cioè, come
il 1°, in due parti. Il testo è del Tasso ed è pervaso da una
sottile vena or d’ironia, or di
nostalgia. La musica di Gesualdo
ne coglie infallibile le più tenui
sfumature e le illumina con
tocco delicato e sicuro; ne esce
un madrigale particolarmente ricco
d’invenzione, dove, a episodi di
arguzia ritmica
(“sussurrando predava...”) altri
ne succedono di tenera melodia
(“ai dolcissimi colori”) o di
intensa vita armonica (“purpurea
rosa”, nel finale della prima
parte, in cui la luminosa
risoluzione esplode da un
agglornerato armonico
fortemente dissonante). La
seconda parte è
caratterizzata da un impiego
delle voci in funzione
“coloristica”,
da un certo loro modo di disporsi
in particolari “timbri” (vedi ad
esempio la frase “vil ape amor”)
che sortono ad effetti
stranamente strumentali. Il finale, in simmetria con
quello della prima parte, si
affida alla suggestione di un
progressivo “aprirsi”
di armonie nascenti dalla
espansione melodica orizzontale delle
singole voci.
6. SE DA SI
NOBIL MANO
Di chiara
struttura e tenue ispirazione,
questo madrigale, nel suo
equilibrato alternarsi di
episodi omofoni
e polifonici, nella chiarità delle
sue risultanti armoniche,
nella linearità delle
sue strutture melodiche sembra
non voler accogliere alcuna
suggestione del testo poetico
tassesco, che gli rimane
del tutto estraneo, semplice
pretesto al disteso lirismo
del discorso musicale.
7. AMOR, PACE NON CHERO
L'emozione
poetica di questo breve
madrigale sembra concentrarsi
tutta - ed esaurirsi - nelle
prime dieci battute,
culminando nei due arditi
salti d'ottava del tenore e
del basso sulla parola “amor”.
Da questo punto, la
composizione è
portata avanti con gran
mestiere, ma con sensibile
disinteresse. Il
testo non meritava di più.
8. SI GIOIOSO MI FANNO
Anche questa composizione
è
caratterizzata dalla presenza
- seppur dissimulata nei numerosi
episodi polifonici - di uno
spirito essenzialmente
monodico, polarizzato nella
voce superiore: cosicchè è
facile immaginare questo
madrigale eseguito “a voce
sola” (soprano) con l'accompagnamento
di strumenti
in luogo delle altre quattro
voci.
9. O DOLCE MIO MARTIRE
Questo madrigale, uno dei più belli
di questo primo libro, si
snoda in un’atmosfera di
tenera dolcezza, or raccolta
in ombra, or illuminata da
brevi luci di gioia, in una
continua oscillazione di modi
maggiori e minori che, nel
gioco delle imitazioni,
riverberano tenuti colori
vocali. La composizione trova
il momento di più alta
commozione lirica là dove,
conclusasi in aperto “maggiore”
la frase “... io più beato
e più felice vivo”, la voce
del tenore - sulle parole
“quest’è
poter d’amore” - viene quasi
avvolta dalle altre voci in
un’onda melodica di struggente
dolcezza.
10. TIRSI MORIR VOLEA
È
questo, forse, il capolavoro
del primo libro. Già l’Ambros
l’aveva, un secolo fa,
segnalato nella sua prima
analisi critica dell’opera
gesualdiana. Il testo
letterario, pur nel suo
convenzionale barocchismo, ha
un suo strano fascino:
Gesualdo lo trasfigura in
altissima poesia. Nella
seconda parte, in particolare,
l'idea
di una morte desiderata tanto
da morire (“sentendo morte in
non poter morire”) diviene
disperata angoscia
nell’ossessiva ripresa,
attraverso tutte le voci e su
tutti i gradi, delle quattro
note ascendenti sulle parole
“di non poter”. E l’ultima
ascesa del soprano, alla
quintultima battuta, tocca
veramente un vertice tragico.
11. MENTRE MIA STELLA MIRI
Di colore chiaro,
armonisticamente disteso,
deciso nel bel ritmo
dattilo-spondaico, sospeso
talora (“le tue dolci
faville”) in trasparenti
sonorità
omofone, è
questo il madrigale d’un
Gesualdo rasserenato e composto
in classica euritmia.
12. NON MIRAR, NON MIRARE
È un
madrigale che vorremmo definire
“sinfonico”: il gioco delle
sonorità
vocali (vedi l’inizio; o la
frase “e loquace silenzio” che
rimane come sospesa
nell’immobilità creata da
una nota tenuta
del mezzosoprano), il ricco
movimento melodico
delle parti, il riverberarsi
di voci in echi (“va, va”), ne
fanno un “divertimento” di raffinatissima
sensibilità
musicale.
13. QUESTI LEGGIADRI
Anche qui Gesualdo sa cogliere
infallibile il sentimento centrale
del testo e su questo mette il
suo accento di poeta: “Pietà vi
move della doglia mia”.
L’arditezza armonica del finale,
articolata
sui salti d’ottava ascendente
del baritono e del basso,
esprime con commozione
di rara potenza l’accoratezza
dell’invocazione.
14. FELICE PRIMAVERA
Nell’alternanza
consueta di episodi polifonici
ed omofoni, ma nell’inconsueta
disposizione vocale di questi
ultimi e nella levità melodica dei
primi, Gesualdo realizza
musicalmente il pastorale,
dolcissimo testo del Tasso con
una preziosa trasparenza di
colori e di timbri.
15. SON SÌ BELLE
LE ROSE
A una introduzione che, con il
progressivo
entrar delle voci, sembra
passare da una zona d’ombra ad
una di luce, segue un discorso
musicale in cui
omofonia e polivocalità si snodano e si
alternano con elegante moto. Un
brano, comunque, in cui l’arte non
sorte a poetica commozione e il cui fine sembra essere una
pura e preziosa dilettazione
sonora.
16. BELL’ANGIOLETTA
Quest’ultimo rnadrigale è animato,
dall’inizio alla fine, da uno
slancio lirico che non ha pausa
o respiro, tutto teso verso il
vertice espressivo delle parole
“io amo”,
che concludono la breve,
stupenda composizione.
Francesco
Degrada
|
|