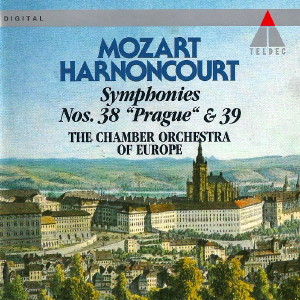 |
1 CD -
4509-90866-2 - (p) 1994
|
|
| Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) |
|
|
|
|
|
|
|
| Symphony No. 38 in D major,
KV 504 "Prague" |
|
38' 08" |
|
| - Adagio - Allegro |
19' 15" |
|
1
|
- Andante
|
10' 47" |
|
2
|
| - Presto |
7' 56" |
|
3
|
| Symphony No. 39 in E flat
major, KV 543 |
|
31' 23" |
|
| - Adagio - Allegro |
10' 37" |
|
4
|
- Andante
con moto
|
8' 31" |
|
5
|
- Menuetto: Allegretto
|
4' 05" |
|
6
|
| - Finale: Allegro |
8' 00" |
|
7
|
|
|
|
|
| The
Chamber Orchestra of Europe |
|
| Nikolaus
Harnoncourt, Dirigent |
|
|
Luogo
e data di registrazione
|
-
Stefaniensaal, Graz (Austria) - 28 &
29 giugno 1993 (Symphony No. 38)
- Großer Musikvereinsaal, Vienna
(Austria) - 5 dicembre 1991
|
|
Registrazione
live / studio
|
| live |
Producer
/ Engineer
|
Wolfgang
Mohre / Helmut Mühle / Michael Brammann
|
Prima Edizione CD
|
-
Teldec - 4509-90866-2 - (1 cd) - 69' 37"
- (p) 1994 - DDD (Symphony No. 38)
- Teldec - 9031-74858-2 - (2 cd) - 67'
41" + 40' 52" - (p) 1992 - DDD (Symphony
No. 39) |
|
Prima
Edizione LP
|
-
|
|
Nota
|
| Questa
pubblicazione contiene la sinfonia n.39
già pubblicate nel 1992. |
|
|
Note
|
Durante il suo
periodo Viennese (1781-91) Mozart
compose sei sinfonie; la terza in
ordine cronologico (Sinfonia n.
38 in re maggiore K. 504, Praga)
occupa una posizione particolare:
non appartiene infatti al gruppo delle
tre ultime sinfonie dell'estate del
1788 (in mi bemolle maggiore K. 545,
in sol minore K. 550 e in do
maggiore K. 551, Jupiter), ma precede questo
trittico di un anno
e mezzo. Inoltre,
a diiferenza di queste
tre composizioni,
la Sinfonia in
re maggiore non è in quattro bensì
in tre movimenti, le "manca", per
così dire, il
Minuetto. Ciononostante
si pone affianco
alle tre ultime sinfonie come una compagna
di pari importanza e
infatti, forse anche per via della
loro vicinanza temporale,
su tutte e quattro le composizioni aleggia uno "spirito" artistico assai simile, che
emerge chiaramente
dal raffronto fra la Sinfonia
Praga e la Sinfonia in mi
bemolle maggiore K. 543.
La Sinfonia Praga - a
differenza ad esempio della Sinfonia Linz
- non fu scritta
nella città alla quale è
intitolata, nè fu composta
con lo sguardo rivolto alla vita
musicale praghese: Mozart si recò in visita a Praga all’inizio
del 1787, perché là era riuscito ad
ottenere (al più presto per la fine
di novembre del 1786) la prima
rappresentazione fuori Vienna delle
Nozze di Figaro, che
gli fruttò un successo enorme. La
notizia di tale successo si
diffuse rapidamente: a metà dicembre aveva percorso tutto il
territorio asburgico;
neppure Mozart si sarebbe apettato un tale
trionfo. A quel
tempo tuttavia la Sinfonia Praga
era già terminata: il 6 dicembre Mozart l’aveva
completata, aggiungendo al movimento
finale, già scritto all'inizio di
quell'anno, un nuovo tempo iniziale
ed un tempo lento. La composizione
doveva quindi essere stata concepita
per Vienna, per la stagione concertistica dell’Avvento;
altrimenti non si spiegherebbe la premura
di Mozart di concludere il lavoro. Dalla genesi
di questa sinfonia
viene quindi ridimensionato un
particolare
biografico: verso la
fine del 1786 Mozart deve avere avuto
ancora occasione di dare dei concerti a Vienna e mancano pertanto i dati
per affermare che
a quell'epoca il
suo astro era già
avviato al
tramonto.
Le affinità con la Sinfonia in mi bemolle
maggiore K. 543, composta
nel 1788 in circostanze assai meno confuse,
risultano inizialmente da
un dettaglio finora ignorato
dalle analisi formali ma di grande importanza: a differenza delle
ultime due sinfonie entrambe le composizioni
iniziano con una introduzione lenta.
Da un punto di vista generale la funzione di tali
introduzioni è quella di esporre la tonalità d'impianto e di
presentare l'organico dell'orchestra
impiegata al completo; tuttavia è notevole
osservare il fatto che in entrambi i
casi Mozart ahbandoni
la tonalità d'impianto nonchè il modo
in cui ciò avviene: il radioso re
maggiore della Sinfonia Praga
si ribalta infatti nel "demonico"
re minore, che si incontra anche
nel Don Giovanni di appena
due anni prima; il solenne
universo del mi bemolle maggiore
della Sinfonia K. 543 si
apre invece su di una
sezione nella quale compaiono
dissonanze asperrime. In entrambi
i casi viene rappresentato il
trapasso verso la parte veloce del
movimento, che sostituisce in
tutte e due le sinfonie un effetto
di rilassamento dopo la tensione.
Similmente Mozart spezza anche la
monotonia espressiva dei secondi
movimenti lenti, in
cui si assiste in entrambi i
casi ad una crescita della
tensione paragonabile a quanto
avviene nelle introduzioni.
Ambedue i tempi lenti iniziano
tuttavia in maniera molto
tranquilla e semplice, con un
motivo iniziale conciso e assai
orecchiabile, in un tempo
scorrevole di andante e con una
scrittura per soli archi in
piano. Anche i finali presentano
un alto grado di affinità: qui
frasi concise in un tempo vivace
di 2/4 rendono possibili bruschi
ribaltamenti
espressivi. Con questo
particolare, che determina
sostanzialmente l'impressione
generale, entrambe le
composizioni battono quindi
strade di un'analogia sorprendente; la
Sinfonia in mi bemolle
maggiore si distingue
pertanto in maniera inattesa
dalle sue due consorelle del
1788.
Infine vi è
probabilmente un ultimo
elemento comune alle due
sinfonie: l'accoglienza
particolare avuta a Praga.
Uno dei primi biografi
mozartiani, Franz
Niemetschek, riferisce che
oltre alla Sinfonia
Praga, coronata da
tanto successo, in quella
città fu eseguita anche la
grande Sinfonia in mi
bemolle maggiore.
Niemetschek erra però nel
ritenere che ciò possa
essere avvenuto già
all'inizio del 1787,
poichè la Sinfonia in
mi bemolle maggiore
fu composta solamente un
anno e mezzo più tardi. E'
possibile tuttavia che
Mozart l'avesse eseguita a
Praga nel 1791, all'epoca
della prima della Clemenza
di Tito. In tal modo
anche la Sinfonia in
mi bemolle maggiore
sarebbe una sinfonia
praghese, non
diversamente da quella in
re maggiore.
Konrad
Küster
Traduzione: Marco Marica
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|