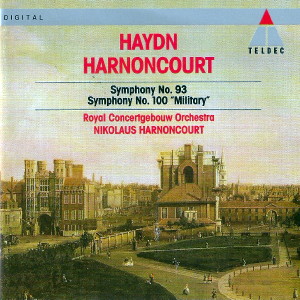 |
1 CD -
9031-74859-2 - (p) 1993
|
|
| Franz Joseph
Haydn (1732-1809) |
|
|
|
|
|
|
|
| Symphony Nr. 93 D major |
|
22' 33" |
|
| - Adagio - Allegro assai |
7' 24" |
|
1
|
- Largo cantabile
|
5' 43" |
|
2
|
| - Menuetto - Trio |
3' 52" |
|
3
|
- Finale: Prestoma non
troppo
|
5' 34" |
|
4
|
Symphonie Nr. 100 G-dur
"Militär"
|
|
24' 53" |
|
| - Adagio - Allegro |
8' 16" |
|
5
|
- Allegretto
|
6' 04" |
|
6
|
- Menuett: Moderato
|
5' 11" |
|
7
|
| - Finale: Presto |
5' 22" |
|
8
|
Symphonie
Nr. 68 B-dur
|
|
29' 07" |
|
- Vivace
|
7' 02" |
|
9
|
| - Menuetto |
3' 13" |
|
10
|
| - Adagio cantabile |
14' 14" |
|
11
|
| - Finale: Presto |
4' 38" |
|
12
|
|
|
|
|
| ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA, AMSTERDAM |
|
| Nikolaus
Harnoncourt, Dirigent |
|
|
Luogo
e data di registrazione
|
Concertgebouw,
Amsterdam (Olanda):
- ottobre e novembre 1986 (100 e 68)
- gennaio 1992 (93)
|
|
Registrazione
live / studio
|
| studio |
Producer
/ Engineer
|
Wolfgang
Mohre / Helmut Mühle / Michael Brammann
|
Prima Edizione CD
|
-
Teldec - 8.43301 ZK - (1 cd) - 54' 11" -
(p) 1986 - DDD (Symphonies No. 100 e No.
68)
- Teldec - 9031-74859-2 - (1 cd) - 76'
55" - (p) 1993 - DDD (Symphony No. 93) |
|
Prima
Edizione LP
|
Teldec - 6.43301
AZ - (1 lp) - 54'
11"
- (p) 1986
- Digital (Symphonies No. 100 e 68)
|
|
Nota
|
| Questa
pubblicazione, oltre alla sinfonia n. 93,
contiene anche le sinfonie n.100 e 68 già
pubblicate nel 1986. |
|
|
Gli esperimenti
sinfonici di Joseph Haydn
|
Joseph Haydn
era tutt'altro che un compositore di
musica "d'intrattenimento", un
musicista in pantofole felpate, e
"papà" Haydn non lo fu mai. Tutt'al
più si potrebbe definirlo "padre"
(ma non "inventore") della sinfonia
classica, ma senza accogliere per
questo il luogo comune che lo
vorrebbe "orecursore" di Mozart e
Beethoven, anzi addirittura un
"pre-classico". Haydn
sviluppò la nuova forma sinfonica
senza operare una radicale rottura
con la tradizione barocca, e nei
36 anni del suo confronto creativo
con questo genere lo portò al suo
pieno "compimento".
Dobbiamo tener
presente che Haydn aveva già 27
anni quando Georg Friedrich Händel morì;
correva l'anno 1759, e proprio
in quell'anno vide la luce la
prima Sinfonia composta da
haydn. E quando Haydn morì, nel
1809, erano trascorsi quasi
venti anni dalla scomparsa di
Mozart e Beethoven scriveva la sua Sesta
Sinfonia; quattro anni più
tardi Franz Schubert acrebbe
composto la sua Prima
Sinfonia. Tra Haydn e Schubert
ci sono tanti fili di
collegamento, che sembrano
addirittura preannunciare
sviluppi dell'Ottocento
inoltrato.
Nel corso
degli anni - quasi un
trentennio (1761-1790) -
trascorsi al servizio del
principe Esterházy
in qualità di maestro di
cappella, Haydn compì
incessantemente
"wsperimenti" compositivi,
in particolare nel genere
sinfonico. Ritornando con la
memoria a quegli anni, Haydn
dirà poi: "Il mio signore
era contento di ogni mio
lavoro, riscuotevo il suo
plauso, potevo in qualità di
direttore d'un'orchestra
compiere esperimenti,
esaminare quel che suscita
impressioni e quel che le
attenua, potevo dunque
migliorare, aggiungere,
tagliare, osare di più;
ero appartato dal mondo.
Vicino a me non c'era
nessuno che potesse
confondermi e molestarmi,
e così non potevo non
divenire originale".
Parole degne di nota, che
ancora oggi fanno
riflettere sia
sull'apertura e sulla
tolleranza di un mecenate,
sia sulla ricerca da parte
d'un compositore
d'"avanguardia" di un
intenso tratto espressivo.
Le
impressioni uditive che
potevano ricevere
gli Esterházy
e i loro ospiti,
saranno state (almeno
in parte) fonte di
stupore, se non di
diniego, e per
convincersi di ciò
basta proiettare a
ritroso in quei tempi
certe nostre reazioni
odierne. Infatti nelle
composizioni di Haydn
possiamo rinvenire
soluzioni che ancora
oggi ci appaiono
inusitate, ci
sorprendono, a volta
addirittura ci sconcertano
- e tali sensazioni
non mancano, o non
dovrebbero mancare,
in una fedele e
coerente
interpretazione.
Quando
Haydn compose la sua
Sinfonia n. 68
del 1774/75
(oppure nel
1779), aveva
oltrepassato la
fase dello
"Sturn und
Drang", senza
per questo
perdere nulla
della sua
irruenza. Ancora
una volta sapeva
creare sorprese
collocando un
Adagio come
terzo movimento
nell'ambito del
collaudato ciclo
sinfonico in
quattro
movimenti. Così
facendo
intendeva
sottolineare la
particolare
incidenza e
profondità
espressiva di
questo Adagio.
Nel Finale
ritroviamo tutto
il tipico humour
di Haydn, con la
sua verve
caratteristica,
stimolante.
Dopo
la morte del
principe
Esterházy
nel 1790 la
cappella di
corte fu
sciolta, ma
Haydn continuò
a rivecere la
sua
retribuzione
dal nuovo
principe. Ora
libero, Haydn
si trasferì a
Vienna e si
portò anche a
Londra dove
gli fu
riservata
un'accoglienza
particolarmente
cordiale. Tra
le prime
Sinfonie
"londinesi"
c'è anche
quella
numerata come
la prima, ma
che fu in
realtà la
terza ad
essere
composta, la
Sinfonia in re
maggiore n.
93, eseguita
la prima volta
nel 1792.
Anche qui non
mancano
soluzioni
singolari,
anomale,
sorprendenti,
già nelle due
prime battute
con i suoi
colpi in
fortissimo e
la
presentazione
concentrata
dell'idea
tematica nelle
quattro
battute
seguenti. In
una scrittura
serrata il
discorso
musicale è
portato a
tonalità
lontane, prima
di passare
alla sezione
in tempo
veloce dalla
dizione più
sciolta, ma
dove moduli
contrappuntistici
d'ogni genere
sottolineano
una cifra
espressiva
peculiare. Si
possono sempre
rilevare
soluzioni
"sperimentali",
come
l'intervento
del fagotto a
conclusione
del movimento
lento, che ha
qualcosa di
irritante e
inquietante in
quel suo urto
esplosivo in
fortissimo
anticipato di
mezza battuta,
o ancora come
quell'effetto
un po'
"militaresco"
nel Trio del
Minuetto.
La
Sinfonia n.
100 del 1794
venne
denominata
"Militare" già fin
dall'annuncio della sua
prima esecuzione; possiamo
così ritenere che Haydn
non avesse obiezioni
contro tale denominazione.
Ad ogni modo non se ne può
desumere che Haydn
intendesse qui procedere
ad una celebrazione di
istanze bellicose - tra
l'altro vi manca il
ricorso a ritmi di marcia,
altrimenti impiegati
volentieri in tali
occasioni. Erano trascorsi
due anni dall'ultima
guerra contro i Turchi, ma
lo sgomento era tanto penetrato
nell'animo di Haydn che
la sua scelta degli
strumenti "turchi" non
si poteva spiegare in
senso pittoresco ed
esotico, ma come un
monito. In tal modo si
può parlare di una
Sinfonia "militaresca".
Diversamente non si
possono spiegare quelle
esplosioni veementi di
pretesti rumorosi e
violenti che percorrono
la Sinfonia fin nel
Finale. Si pensi poi
all'idillio di marca
familiare del movimento
lento, dal quale ci
strappa un richiamo
militaresco, sì che la
conclusione avviene
all'insegna della tristezza.
Ancora
oggi gli strumenti che
produxono rumore e
strepito risuonano
come un'accusa piena
di amarezza:
triangolo con
anelli, piatti, un
tamburo percosso ora
da una bacchetta,
ora da un sordo
bastone. Questo
tamburo, come
riferisce J. F.
Reichardt da Parigi
nel 1803, era
"liberamente sospeso
ad una certa
altezza, in modo da
rimbombare
liberamente in sala,
ed era persosso da
una persona con
tutte le forze di
cui disponeva". E
aggiungeva che si
trattava di una
"musica turca d'un
fragore
insopportabile".
Wolf-Eberhard
von Lewinski
Traduzione: Gabriele Cervone
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|