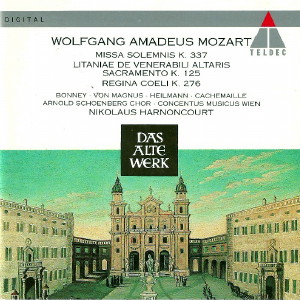 |
1 CD -
4509-90494-2 - (p) 1993
|
|
| Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) |
|
|
|
|
|
|
|
| Missa Solemnis in do
maggiore, KV 337 |
|
21' 35" |
|
| - Kyrie |
2' 08" |
|
1
|
| - Gloria |
3' 32" |
|
2
|
| - Credo |
5' 40" |
|
3
|
| - Sanctus |
1' 39" |
|
4
|
| -
Benedictus |
2' 29" |
|
5
|
- Agnus Dei
|
6' 07" |
|
6
|
| Litaniae
de venerabili altaris sacramento in si
bemolle maggiore, KV 125 |
|
34' 18" |
|
| - Kyrie |
3' 54" |
|
7
|
| - Panis vivus |
5' 29" |
|
8
|
| - Verbum
caro factum |
0' 49" |
|
9
|
- Hostia
sancta
|
3' 23" |
|
10
|
- Tremendum
|
1' 13" |
|
11
|
| - Panis Omnipotentia |
6' 14" |
|
12
|
| - Viaticum |
1' 30" |
|
13
|
- Pignus
|
4' 47" |
|
14
|
| - Agnus Dei |
6' 59" |
|
15
|
| Regina coeli in do maggiore,
KV 276 (321b) |
|
7' 01" |
|
| - Allegro |
7' 01" |
|
16
|
|
|
|
|
| Barbara Bonney,
Soprano |
|
| Elisabeth von
Magnus, Contralto |
|
| Uwe Heilmann,
Tenore |
|
| Gilles
Cachemaille, Basso |
|
|
|
| Arnold Schönberg
Chor / Erwin Ortner, Einstudierung |
|
|
|
CONCENTUS MUSICUS
WIEN (mit
Originalinstrumenten)
|
|
-
Erich Höbarth, Violino
|
-
Eduard Hruza, Violone |
|
| -
Alice Harnoncourt, Violino |
-
Andrew Ackerman, Violone |
|
| -
Anita Mitterer, Violino |
-
Christian Gurtner, Flauto
traverso |
|
| -
Andrea Bischof, Violino |
-
Sylvie Summereder, Flauto
traverso |
|
| -
Karl Höffinger, Violino |
-
Hans Peter Westermann, Oboe |
|
| -
Walter Pfeiffer, Violino |
-
Marie Wolf, Oboe |
|
| -
Maighread McCrann, Violino |
-
Milan Turkovič, Fagotto |
|
| -
Silvia Walch-Iberer, Violino |
-
Nikolaus Broda, Fagotto |
|
| -
Mary Utiger, Violino |
-
Eric Kushner, Corno naturale |
|
| -
Editha Fetz, Violino |
-
Alois Schlor, Corno naturale |
|
| -
Maria Kubizek, Violino |
-
Friedemann Immer, Tromba
naturale |
|
| -
Christian Tachezi, Violino |
-
Martin Rabl, Tromba naturale |
|
| -
Peter Schoberwalter junior, Violino |
-
Dietmar Küblböck, Trombone |
|
-
Helmut Mitter, Violino, Viola
|
-
Josef Ritt, Trombone |
|
-
Peter Schoberwalter, Violino,
Viola
|
-
Horst Küblböck, Trombone |
|
-
Gerold Klaus, Violino, Viola
|
-
Martin Kerschbaum, Timpani |
|
| -
Herwig Tachezi, Violoncello |
-
Herbert Tachezi, Orgel |
|
-
Dorothea Guschlbauer, Violoncello
|
|
|
|
|
| Nikolaus
Harnoncourt, Direzione |
|
|
Luogo
e data di registrazione
|
| Pfarrkirche,
Stainz (Austria) - luglio 1992 |
|
Registrazione
live / studio
|
| studio |
Producer
/ Engineer
|
Renate
Kupfer / Wolfgang Mohr / Helmut Mühler /
Michael Brammann
|
Prima Edizione CD
|
| Teldec
"Das Alte Werk" - 4509-90494-2 - (1 cd)
- 60' 23" - (p) 1993 - DDD |
|
Prima
Edizione LP
|
-
|
|
|
Note
|
Nella seconda metà
del XVIII secolo nei trattati
musicali si andarono
moltiplicandosi le visioni apocalittiche
circa il tramonto e il
declino della musica sacra. Johann
Friedrich Reichardt,
maestro di cappella di Federico II e
decan della critlca
musicale Berlinese, scriveva ad
esernpio nel 1782 nel suo
saggio~manifesto irititolato Kirchenmusik
(Musica sacra), pubblicato
nel Musikalisches Kunstmagazin
(Rivista d'arte musicale): "Imperdonabile,
sacrilega è la
sconsacrazione della rnusica di
chiesa, il suo ablnassnmento da quella
nobile dignità a cui
anelava già da secoli, a
misero, ridicolo trastullo
e facile diletto del gusto. Essa, la
nobile, la sublime, la divina
arte... si deve ora accontentare di
solleticare i nervi e di compiacere il
buon gusto!"
Non erano tanto i difetti
compositivi ciò
contro cui
Reichardt si scagliava,
quanto piuttosto
il fatto che lo stile dell'opera
e della sinfonia
avessero lasciato le
loro impronte anche nella musica
sacra. Lo stesso
Mozart, qualora le sue composizioni
sacre fossero giunte agli occhi di
Reichardt, avrebbe
subìto tale rirnprovero
di aver mescolato le
differenti "scritture"
compositive. Tuttavia
anche questo fatto
sarebbe stato in fin
dei conti unicamente una prova di come
la teoria rnusicale rimanga spesso
indietro rispetto alla prassi
compositiva. Lo "stile
ecclesiastico" di Mozart è
infatti geniale ed è
stalo preso a modello proprio per via
di questa sua fusione di influenze
stilistiche eterogenee.
Nato a Salisburgo, in una città
dalla ricca tradizione nel campo
della musica sacra, Mozart aveva
acquisito un proprio stile
compositivo studiando le
opera di Adlgasser, di
Michael Haydn e del padre Leopold.
La corrispondenza farniliare presenta
una gran quantità di
riferimenti in tal senso:
"24 marzo [1777]:
la sera alle sei nel Duomo predica di
Padre Primo, poi resto
fino alla Litania dell’Adlgasser."
E ancora: "13
aprile [1778]:
alle sei nel Duomo fino alla fine. La
litania era dell'Haydn
nostrano." La conoscenza che
Mozart ebbe della musica sacra di
Salisburgo si univa
alle molteplici influenze stilistiche
derivanti dai suoi
numerosi viaggi. Soprattutto il soggiorno in
Italia
presso Padre Martini svolse una
funzione determinante
nello sviluppo
del suo stile
contrappuntistico.
Echi del secondo viaggio in Italia si
ritrovano nelle Litaniae
de venerabili altaris sacramento
K..125. Il testo di quest'opera, cornposta
nel 1772 e annunciante l'esaltazione, la
venerazione e l’effetto salvifico
dell’eucarestia, è stato suddiviso da Mozart
in più sezioni.
Nella musica
del "miserere nobis" centrale si
rispecchia
tutta la
ricchezza
espressiva di questa composizione.
Dal canto espressivo del "Panis
vivus" alle inflessioni delicate
del "Panis omnipotentia", il
"miserere nobis" appare come un elemento capace di
continue trasformazioni
e mirante ad uno
scopo ben preciso: la venerazionc
del sacramento dell'eucarestia. I
suoi differenti aspetti formali
corrispondono alle diverse attitudini stilistiche del
compositore. Già
il musicologo Hermann Abert era
dell'avviso che il "Kyrie" equivalga "da un
punto di vista formale ad un
movimento di sinfonia come se ne,
scriveranno in quegl’anni,
eseguito qtiindi coerentemente
dall'orchestra a cui è stato aggiunto un coro".
Ciononostante Mozart ha messo la musica
completarnente al servizio
dell’enunciazione del testo. Il modello
dell’aria d’opera napoletana
caratterizza le parti dei soli,
tuttavia l’intento di Mozart non è altro che quello
di trasferire in questa
composizione un principio
stilistico da un
contesto ad
un altro.
Il Regina Coeli K. 276 fu
scritto da Mozart dopo il suo
ritorno da Parigi. L’affinità di questa
composizione con il primo
movimento del Vespro K. 321 fa presupporre come anno
di composizione il 1779. A differenza del Regina coeli
del passato, Mozart ha compresso il
testo cantato
in un unico
rnovimento. Una
tripla acclamazione del coro,
eseguita enfaticamente su di una
melodia di triade, apre la
composizione, nel corso della
quale si alternano delle sezioni
solistiche e
delle sezioni corali. Quest'opora
pasquale, in
cui prevale lo
splendore festoso e gioioso, si
presenta con on appatato orchestrale di
grandi dimensioni,
tuttavia subisce a tratti
dei mutamenti d’espressione a
seconda del testo. Ad esempio sulle parole "ora pro nobis Deum" Mozart ricorre
agli accordi di settima diminuita,
che
determinano un’atmosfera quasi
tragica, dopo la quale il
movimento si conclude con delle quanto mai
travolgenti acclamazioni allelujatiche.
Il
manoscritto autograto della Missa
solemnis
in do maggiore
K. 337
riporta in un'annotazione la data
di composizione: "nel Marzo 1780 in
Salisburgo". Mozart compose la messa insieme
ad una nuova sonata da chiesa (K. 336/336d) per
la solenne cerimonia di Pasqua nel
Duomo di Salisburgo. Mentre il
poderoso apparato orchestrale sembra
giustificare la definizione di "Missa solemnis", la sua
modesta estensione la farebbe piuttosto classificare come "Missa brevis".
Il "Kyrie
eleison" si
apre come uscendo dall’oscurità. La lrase di
risposta "eleison", eseguita in
piano, sottolinea l'atteggiamento di
riverenza e l’implorazione di pietà espressa in
questo movimento. Il "Gloria in
excelsis Deo" è invece dominato
da un’atmosfera
festosa. Il Credo
inizia impetuosamente, sfociando tuttavia
alle parole "et incarnatus" est
nel suo più assoluto
contrario;
qui infatti,
mentre l'organico si riduce al massimo e il tempo
rallenta, il soprano intona un assolo carico
di nostalgia, al quale fa seguito
il "Crucifixus",
simboleggiante uno stato di
estremo abbattimento.
Con l’"et resurrexit" torna a
prevalere l'atmosfera
iniziale. La triplice ripetizione
dell'acclamazione
del "Sanctus", con le sue incisive
figurazioni di
ottave, mostra forza
e dignità e
viene contrastato dai ticciti
naelismi
dell’"Hosanna in excelsis". Nel "Benedictus" Mozart dà prova di saper
padroneggiare lo "stile antico",
vale a dire lo stile barocco della
musica
sacra, scrivendo questo movimento
in forma di fuga. Nell'Agnus Dei per
un attimo
sembra quasi di sentire l’eco
della cavatina della Contessa
"Porgi, amor, qualche
ristoro" delle Nozze di
Figaro. A nostro avviso è secondario
stabilire se effettivamente
Mozart fosse
stato consapevole di questa
affinità al
momento di comporre
la sua opera alcuni
anni più tardi; ciò che
conta è
piuttosto il fatto che
il tipo di melodia
che ritroviamo qui, tanto nella messa
che nell'opera, vuole
esprimere essenzialmente il gesto del
supplicare. Allo stesso tempo ci
troviamo di fronte ad un'ulteriore
prova di
come il compositore
d'opere Mozart abbia
influemzato il compositore
di musica sacra e viceversa.
Hans-Günter
Ottenberg
Translation:
Marco Marica
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|