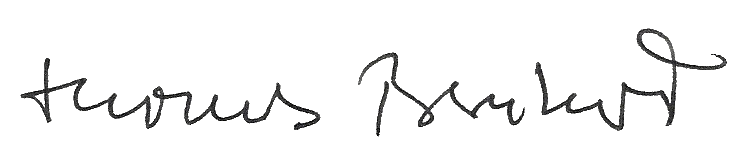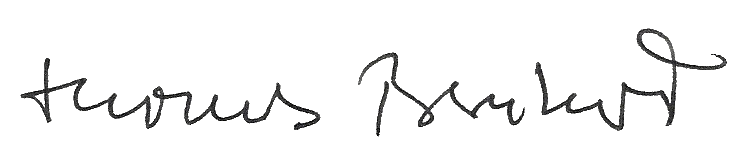|
Uno
scrigno di damasco per la rabbia di Bernhard
"Heldenplatz"
nel Teatro della Josefstadt a Vienna.
di Michele Vangi
"Alias", settimanale de il "Manifesto", Sabato 19
febbraio 2011
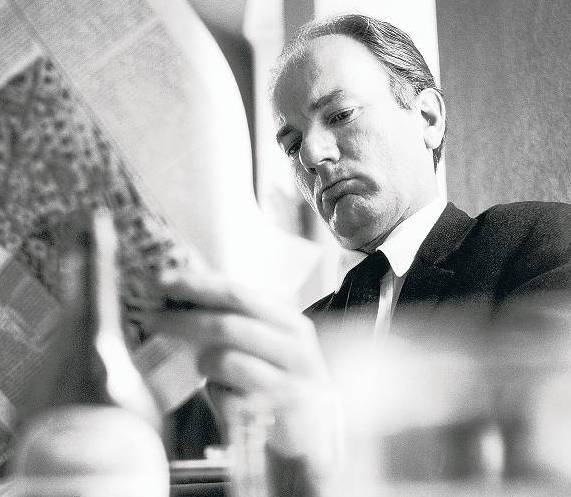 Quando la
governante, Frau Zittel, inizia a elencare manie private
e pubbliche ossessioni del padrone di casa, il Professor
Josef Schuster, che qualche giorno prima si Ŕ buttato
gi¨ dal balcone della sua casa viennese vicino a
Heldenplats (Piazza degli eroi), il pubblico non pu˛ che
ripensare alla prima assoluta del novembre 1988. Oggi
non siamo per˛ come allora al Burgtheater sul Ring, ma
nell'accogliente teatro della Josefstadt, scrigno di
damasco rosso e stucchi dorati. Piazza degli eroi
(trad. it. R. Zorzi, Garzanti) di Thomas Bernhard va in
scena qui da settembre scorso, per la regia di Philipp
Tiedemann. Quando la
governante, Frau Zittel, inizia a elencare manie private
e pubbliche ossessioni del padrone di casa, il Professor
Josef Schuster, che qualche giorno prima si Ŕ buttato
gi¨ dal balcone della sua casa viennese vicino a
Heldenplats (Piazza degli eroi), il pubblico non pu˛ che
ripensare alla prima assoluta del novembre 1988. Oggi
non siamo per˛ come allora al Burgtheater sul Ring, ma
nell'accogliente teatro della Josefstadt, scrigno di
damasco rosso e stucchi dorati. Piazza degli eroi
(trad. it. R. Zorzi, Garzanti) di Thomas Bernhard va in
scena qui da settembre scorso, per la regia di Philipp
Tiedemann.
Il testo vive delle conversazioni fra famigliari e
colleghi del Professor Schuster. Essi ritornano dal
funerale passando per il Volksgarten e convengono nella
casa ormai vuota del suicida. Rievocano il dramma del
professore ebreo che negli anni del nazionalsocialismo
era dovuto emigrare a Oxford - evidente
riferimento a Ludwig Wittgenstein - e che dopo la guerra
era tornato nell'apparentemente pacificata repubblica
alpina, riprendendosi la sua cattedra all'UniversitÓ di
Vienna. L'aver constatato di essere caduto nella
"trappola viennese" . le cose erano pi¨ gravi ancora di
cinquant'anni prima - non aveva lasciato al professore
altra via di scampo.
La prima peatrale del 1988 - regia di Claus Peymann - fu
un caso letterario memorabile che cadeva non a caso nel
cinquantesimo anniversario dell'annessione dell'Austria
al Terzo Reich. Proprio a Heldenplatz, Hitler aveva
tenuto il 15 marzo 1938 un discorso trionfale, accolto
dalle urla di giubilo della folla. Queste urla la moglie
del professor Schuster le sente ancora oggi.
I dialoghi dei personaggi furono vero materiale
incendiario per il dibattito politico e pubblico della
seconda repubblica austriaca. Bernhard non risparmiava
attacchi feroci alla politica, distribuiti in modo
ecumenico fra i socialisti del SPÍ - che con Fred
Vranitzky guidavano un governo di Gro▀e Koalition - e i
loro alleati, i popolari della ÍVP, partito scosso pochi
anni prima dal "caso Waldheim". L'elezione di Kurt
Waldheim a presidente federale nel 1986 era stata
infatti accompagnata da accese polemiche. Una
commissione di storici, istituita appositamente per
accertare il grado di coinvolgimento di Waldheim in
azioni militari della Wehrmacht, era giunta alla
conclusione che non gli si poteva imputare "crimini di
guerra", la sua ricostruzione dei fatti era tuttavia
lacunosa e in parte falsa. La seconda metÓ degli anni
ottanta sarebbe entrata cosý nei libri di storia come
una fase di svolta epocale nella coscienza collettiva
del paese. Fino a quel momento gli austriaci si erano
considerati le prime vittime di Hitler; gli storici e
gli scrittori venivano a raccontare ora un'altra storia.
Bernhard dava cosý il suo sarcastico contributo alla
commemorazione, scardinandone ogni versione
politicamente edulcorata. Ma non sono solo i politici a
essere il bersaglio di Piazza degli eroi,
il Professor Robert - fratello del defunto - rovescia le
sue invettive sulla societÓ austriaca en bloc:
"L'Austria stessa non Ŕ altro che una quinta di teatro
[...] una comparsata, odiosa anche a se stessa, di sei
milioni e mezzo di abbandonati a se stessi, sei milioni
e mezzo di dementi e pazzi furiosi che ininterrottamente
e a squarciagola invocano un regista". In un agone
politico lacerato dal riemergere di un passato
politicamente scomodo, in un clima reso ancora pi¨
incandescente dalle anticipazioni della stampa, si
arriv˛ alla prima del 1988. L'editore di Bernhard,
Siefried Unseld, ne Ŕ testimone: "Il giorno
dimostrazioni, poi contro-dimostrazioni, infine
contro-contro-dimostrazioni [...]. La rappresentazione Ŕ
presieduta dalla polizia. Inizio dello spettacolo alle
ore 19. L'atmosfera Ŕ di calma irreale, di apparente
serenitÓ. Ma quandoentra in scena Annaliese R÷mer, che
interpreta la governante Frau Zittel, e inizia con la
prima critica a Vienna e all'Austria, viene gi¨ una
bordata di fischi come mai si era sentita al
Burgtheater. La bordata provoca applausi a scena aperta
e, tanto pi¨ sonori si fanno i fischi, tanto pi¨ il
consenso cresce in frastuono e il duello fra protesta e
approvazione sancisce infone il trionfo di Bernhard e
Peymann".
Bernhard non nascose la sua soddisfazione per il
successo di Piazza degli eroi, ma a una
riconciliazione con lo stato austriaco non si giunse
mai. Nel suo testamento - sarebbe morto nel 1989 -
Bernhard avrebbe sancito, non senza maestria teatrale,
la sua "emigrazione postuma": per tutta la durata legale
dei diritti d'autore, poibiva stampa, rappresentazione e
lettura della sua opera "all'interno dei confini dello
stato austriaco".
Il pubblico della Josefstadt di oggi non Ŕ quello del
Burgtheater. Gli spettatori reagiscono compassati alle
cannonate del Professor Robert, la sua satira cupa
suscita di tanto in tanto risate bonarie. La meraviglia
della stampa austriaca di fronte alla tranquilla
"digestione" dell'ormai classico Bernhard, Ŕ tuttavia
una reazione superficiale. Allargando il ficus, sembra
invece che anche il pubblico austriaco si avvii verso
una ricezione meno emotiva. I registi si confrontano
oggi anche con altri testi di Bernhard: coraggiosa ad
esempio, al Landestheater Nieder÷sterreich di Sankt
P÷lten, a 80 chilometri da Vienna, la versione
teatrale del romanzo Verst÷rung (Perturbamento,
trad. it. E. Bernardi, Adelphi); un amaro viaggio reale
e ideale di un medico e di suo figlio nella desolazione
umana della provincia austriaca.
La pubblicazione della casa editrice tedesca Suhrkamp di
tutte le opere in ventidue volumi a partire dal 2003
favorisce questa ricezione pi¨ matura. La presunta
perdita di virulenza politica dei pezzi di Bernhard Ŕ
inversamente proporzionale alla percezione della loro
inquietante grandezza. I suoi testi richiedono un
lettore e uno spettatore smaliziato, non incline a
estrapolare citazioni o battute dal flusso magmatico del
discorso. Il nastro della prosa bernhardiana scorre e si
riavvolge sempre attorno alle stesse "bobine": il taggio
nazi-cattolico nell'Austria moderna, il microcosmo
opprimente della famiglia, la maniacale ossessione per
l'ordine, la vita solitaria nella quiete montana.
L'opera matura di Bernhard - teatrale o narrativa che
sia - Ŕ un enorme marchingenio grottesco, ruminante di
continuo invettive radicali, convinzioni astruse e
neologismi esilaranti. Essa Ŕ dunque, presa nel suo
complesso, una riflessione tutta postmoderna sulla
possibilitÓ stessa della parola letteraria, soprattutto
attraverso il ricorso alla mimesi del parlato (tipici i:
"diceva", "dicevo", "pensava", "pensavo") che mette
sempre in discussione le forme concluse del racconto.
Questo stile inconfondibile - che Ŕ una poetica - Ŕ una
conqueista faticosa a cui l'autore giunge tardi,
allontanandosi decisamente dagli esordi da realismo
"rurale" dei primi anni cinquanta. La pubblicazione
dell'opera omnia permette di seguire il processo di
genesi della sua scrittura.
La frattura stilistica non produce per˛ un
allontanamento dall'amato-odiato mondo della provincia
austriaca: da lý - dal complesso dell'origine -
provengono le sue "nevrosi produttive" e anche il suo
tono da amabile misantropo che non si risparmia
l'autoironia. Quando il Professor Robert gracchia
sardonico che deve concedersi ogni giorno una sana
agitazione - "perchŔ non crediate che io sia giÓ morto,
tutto al contrario" - il pubblico fa un mezzo sorriso e
riconosce il suo antico maestro.
|