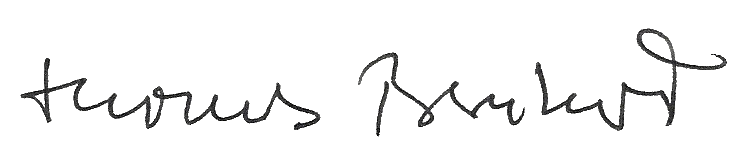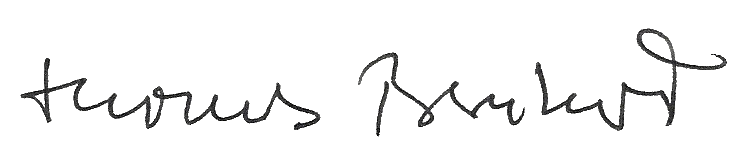|
Dietro le
parole
Tenebra e
geometria
(già edito con il titolo "Beckett
sul Danubio", in "Il Mondo", 10 agosto 1972
di Claudio Magris
Garzanti, "I Garzanti - Argomenti", I edizione:
settembre 1978
 Monologue de
l'Etat-schizophrène, témoignage sur la maladie
d'ensemble: con queste ed altre tumultuose
parafrasi Michel Cournot esaltava qualche mese fa, sul
"Nouvel Observateur", la versione francese di un romanzo
di Thomas Bernhard, la cui narrativa appartata e
solitaria, salutata di recente come un evento
d’eccezione anche da "Le Monde" o dall’"Exprès", è oggi
al centro di un interesse internazionale che fra poco,
con la pubblicazione di un suo libro, dovrebbe
coinvolgere pure l’Italia. Anche nel caso di Bernhard,
la periferica provincia austriaca nella quale egli è
amaramente radicato si rivela il punto di partenza per
avventure del pensiero e del linguaggio d’uno
straordinario significato culturale. L'intelaiatura del
racconto di Bernhard è sempre essenziale come
un’equazione algebrica, è una "geometria delle
lacerazioni, una geometria dell’agonia" e si scandisce
nei "pseudo-geornetrici movimenti" delle mani intente ad
un'operazione laida o feroce quale ad esempio la strage
di frenetici ed assordanti uccelli; l’ininterrotto
processo di distruzione e di decomposizione, che si
ripete con ossessiva e possente monomania in tutta
l’opera dello scrittore, si affida a strutture
rigidarnente simmetriche e viene verbalizzato con un
minuzioso ordine protocollare. Implacabile recensore del
caos, Bernhard dimostra che il caos non esiste e che
tutto è organizzato seeondo regole infami e precise. E'
il rigoroso, gerarchico ordine del male che incrementa
l’orrore, perché dall’impero di un ordine non c’è via di
scampo; è questa lucidissima costruzione perversa che
costituisce l'originalità dei romanzi di Bernhard,
perfino nell’attuale universo letterario in cui
l'industria della negazione è divenuta la più scontata e
redditizia delle mode. Caparbiamente monocorde, la
scrittura di Bernhard ha una sua assillante forza d’urto
e colpisce come un pugno, per usare un’espressione di
Kafka, col quale Bernhard, nonostante la facile e quasi
obbligata ovvietà di tale raffronto, ha un sostanziale,
anche se ben delimitato rapporto di parentela. Monologue de
l'Etat-schizophrène, témoignage sur la maladie
d'ensemble: con queste ed altre tumultuose
parafrasi Michel Cournot esaltava qualche mese fa, sul
"Nouvel Observateur", la versione francese di un romanzo
di Thomas Bernhard, la cui narrativa appartata e
solitaria, salutata di recente come un evento
d’eccezione anche da "Le Monde" o dall’"Exprès", è oggi
al centro di un interesse internazionale che fra poco,
con la pubblicazione di un suo libro, dovrebbe
coinvolgere pure l’Italia. Anche nel caso di Bernhard,
la periferica provincia austriaca nella quale egli è
amaramente radicato si rivela il punto di partenza per
avventure del pensiero e del linguaggio d’uno
straordinario significato culturale. L'intelaiatura del
racconto di Bernhard è sempre essenziale come
un’equazione algebrica, è una "geometria delle
lacerazioni, una geometria dell’agonia" e si scandisce
nei "pseudo-geornetrici movimenti" delle mani intente ad
un'operazione laida o feroce quale ad esempio la strage
di frenetici ed assordanti uccelli; l’ininterrotto
processo di distruzione e di decomposizione, che si
ripete con ossessiva e possente monomania in tutta
l’opera dello scrittore, si affida a strutture
rigidarnente simmetriche e viene verbalizzato con un
minuzioso ordine protocollare. Implacabile recensore del
caos, Bernhard dimostra che il caos non esiste e che
tutto è organizzato seeondo regole infami e precise. E'
il rigoroso, gerarchico ordine del male che incrementa
l’orrore, perché dall’impero di un ordine non c’è via di
scampo; è questa lucidissima costruzione perversa che
costituisce l'originalità dei romanzi di Bernhard,
perfino nell’attuale universo letterario in cui
l'industria della negazione è divenuta la più scontata e
redditizia delle mode. Caparbiamente monocorde, la
scrittura di Bernhard ha una sua assillante forza d’urto
e colpisce come un pugno, per usare un’espressione di
Kafka, col quale Bernhard, nonostante la facile e quasi
obbligata ovvietà di tale raffronto, ha un sostanziale,
anche se ben delimitato rapporto di parentela.
Nato nel 1931, Bernhard è giunto al successo -
attraverso un itinerario duro e difficile - nel 1963 col
romanzo Gelo, cui è seguita una serie febbrile
ed omogenea di opere narrative: Amras, 1964, Verstörung,
1967 (il termine, che indica una distonia psichica, è
stato reso in francese con "perturbation"), Prosa,
1967, Ungenach, 1968 (nome d’un possesso
terriero), Al limite dell'albero, 1969, Watten.
Carte postume, 1969 (watten è la denominazione di
un gioco di carte), Das Kalkwerk, 1970 (lett. La
fabbrica di calce), Camminare, 1971, cui
s'aggiungono lavori lirici, saggistici e teatrali
decisamente rninori. Oggetto di scandalo politico per le
dichiarazioni violentemente polemiche pronunciate in
occasione del premio nazionale austriaco conferitogli
nel 1967, Thomas Bernhard ha proseguito in tutte le
opere un suo discorso coerente sino alla mania, sicché
ogni romanzo contiene potenzialmente, nel suo vortice
verbale, gli altri; il cerchio linguistico più
conturbante è costituito da Verstörung.
Totalmente autonomo nella sua protesta, Bernhard ha
battuto una strada indipendente dal dissenso
industrialmente pianificato e tecnologicamente integrato
dell'avanguardia letteraria tedesca e deve a questa
posizione isolata la sua forza e la sua liberta; c’è da
augurarsi che il successo, che ora gli arride, non
snaturi il suo disadattamento.
I romanzi di Bernhard si compongono di un’ampia
stratificazione di livelli stilistici, ordinatamente
incapsulati l’uno nell’altro come parentesi rotonde
quadre e graffe. I protagonisti sono quasi sempre
cronisti e registratori di parole, giacché tutto accade
non nella realtà ma soltanto nel linguaggio; sono voci o
penne, spesso indifferenziate, che riportano
l'incessante fluire del mormorio universale: lo studente
di Gelo finisce coinvolto nel maniacale monologo
del pittore nevrastenico ch’eg1i ha l'incarico di
riferire, il narratore di Amras è uno dei due
fratelli semifolli autosegregatisi in una torre, in Ungenach
le annotazioni di tre personaggi variano e deformano un
unico contenuto narrativo, Watten è una sorta di
verbale d’una serie di colloqui, Verstörung è la
cronaca di un giro di visite professionali compiuto da
un medico condotto e da suo figlio, estensore della
cronaca medesima la quale riproduce soprattutto i
discorsi dei pazienti e consiste dunque in una
riproduzione di moduli mentali ed espressivi. In questo
forsennato metalinguaggio la negatività universale,
unica dimensione del mondo di Bernhard, viene
progressivamente trasferita dal campo del reale - la
brutalità dell’idillio strapaesano - nell’ambito della
parola. Certo Bernhard, pur dominato dall’idea
prevalente del patologico, eommisura il particolare
frantumato con l’implicito metro della totalità perduta
e della gerarchia infranta: denunciando la corruzione
della vita, quest’archivista del negativo riesce ad
evocarne un’ultima volta, per contrasto, l'integrità ed
a far trasparire l’intero o almeno la sofferta assenza
dell’intero. Narratore che scrive idealmente dopo
l'avanguardia ossia dopo l’esaurimento della sua
problematica tecnica ed ideologica, Bernhard crea il suo
universo per riduzione, restringendo il suo arsenale
lessicale, stilistico e retorico ad un’estrema, classica
sobrietà di mezzi, così come l’industriale diabetico di
Verstörung svuota la propria casa d’ogni oggetto
e i boschi d’ogni animale; ü da questo margine
ridottissimo che il personaggio di Bernhard fissa lo
sguardo in una totalità abnorme e mostruosa e compie le
sue "autopsie sul corpo della natura come su quello del
mondo e della sua storia."
Spesso erede d’un grande patrimonio feudale ch’egli
liquida sminuzzandolo in minimi lasciti da donare a
ricoverati nei manicomi o negli ergastoli, il
personaggio di Bernhard si ritira in un lercio squallore
o, ancor più radicalmente, nel soliloquio, come il
principe di Verstörung, il cui monologo viene
citato integralmente sì da occupare più di metà del
libro, nella mimesi di un "parlato" ininterrotto che
distrugge, nel suo furioso e altero fluire, ogni
parvenza d’oggettività. Tale monologo è un perenne
"soggiorno alle periferie delle distonie nervose"; la
parola, schedata in elenchi minuziosi, si riversa con
furore da ogni parte, al pari dell’inondazione di cui
discorre il principe nel suo esatto vaneggiare. Come per
certe figure del grande Canetti, pure per quelle di
Bernhard tutto esiste "soltanto nelle teste, fuori delle
teste non c’è nulla"; l'individualità appare cioé quale
monomania. Se l’unica realtà umana oggettiva è ormai
quella massificata e cioè alienata dalla tecnica e dal
mito, l'intelligenza individuale che non può accettare
questo trapasso si trincera nella paranoia e nella
schizofrenia, nell’eroica e patologica sopraffazione
soggettiva del reale. "Io sono costruito totalmente
contro la realtà," afferma il principe. L’unica libertà
è dunque la carenza d’ogni relazione col mondo; la
ragione (sempre "dittatoriale" e mai "repubblicana") è
l'imperiosa e dogmatica conoscenza della tragicità
naturale. Simile al dottor Kien di Canetti, che cerca di
educarsi a una finta cecità per escludere una porzione
sempre piu vasta del reale, l’industriale paranoico di
Bernhard legge i giornali quando sono arretrati alrneno
di un mese, quando sono cioè ormai "privi di forza
distruttiva, già poetici". Anche il frastuono interiore,
che perseguita la mente del principe e ch'egli cerca di
coprire col suo monologo, isola e protegge la coerenza
del suo essere. Esterna alla "testa", la natura stessa è
"surreale, è un mostruoso surrealismo universale"; i
colori dell’autunno costituiscono una "riflessione della
natura su se stessa", i boschi una "sempreverde
Matematica metafisica". Il pensiero vede se medesimo e
la natura come un unico labirinto e cerca di
catalogarlo, e quindi di catalogarsi, con un rigore
scientifico e con una classificazione positivista. Ma la
scienza, la musiliana utopia dell’esattezza, perviene
alla verifica della stupidità assoluta, registrata nel
sistema linguistico: le parole risultano tutte insensate
come quelle che Konrad, nel Kalkwerk, ripete
crudelmente alla moglie paralitica per studiare le sue
reazioni auditive.
Il principe di Verstörung abita in un castello,
parla, pur capovolgendoli, di Basso e di Alto; egli vive
ancora in una dimensione verticale e gerarchica, ultima
eco della tradizione austriaca
religioso-aristocratico-feudale. Il castello, scenario
simbolico dell’Austria postdiluviana, significa
liquidazione e fine di un retaggio ossia della
dimensione totale dell’individuo: la cultura austriaca
identifica il declino dei valori individuali con lo
sfacelo della civiltä aristocratica, non giä di quella
borghese che appare quale disordine, riduzione,
appiattimento orizzontale. La tradizione viene certo
vista come una piramide di tare e di follie, ma sempre
nell'ambito di una visione che considera l'esistenza
quale storia naturale o meglio quale processo entropico
e autodistruttivo della natura, per cui la fine del
negativo non comporta un progresso, bensì un’ulteriore
decadenza. Stato, repubblica e democrazia si rivelano
putredine e menzogna, il futuro socialista viene irriso
quale delirio; "la tenebra è una scienza politica", dice
il principe. La politica e la sfera sociale
rappresentano cioè l’altro rispetto al sistema
chiuso e totale della sua disperazione, l'irriducibile alterità
del mondo rispetto all’io. Il principe accetta "la
modernità in un cranio, la modernità interna" ovvero la
negazione rivoluzionaria della società passata e
presente; la modernità "esterna" gli appare una
falsificazione ideologica. Il principe è una testa, una
biblioteca; egli respinge l’infinito perché concepisce
solamente un complesso, vasto ma non illimitato, di
eventi e di cellule in via di degenerazione Nell’orrore
globale, il passato è più sincero del futuro perchè è un
incubo noto che non si camuffa in indefinita speranza;
il futuro inoltre è la storia, l'evoluzione, dunque il
progresso della malattia. Il figlio del principe,
studente marxisteggiante che liquiderà il feudo, è
anch’egli uno schizofrenico; "il figlio deve infine
sempre diventare ancor più raccapricciante del padre".
Bernhard è un tipico esempio d’intellettuale anarchico e
conservatore, o meglio conservatore perché anarchico,
che demistifica le sovrastrutture ideologiche delle
classi dominanti ma al contempo presuppone
l'immodificabilità della condizione umana. Lettore di
Wittgenstein è vicino per certi aspetti a quella che fu
la "Wiener Gruppe", se ne distacca perché non ne
condivide lo slancio giocoso insito nel gesto
iconoclasta né lo sperimentalismo programmatico, così
come rifiuta la lezione dei maestri del cosiddetto
romanzo totale austriaco, da Doderer a Gütersloh, che
hanno cercato di superare la tragedia mediante una
sterminata e stratificata rete di rapporti analogici
interindividuali. Bernhard è l’unico Beckett che abbia
oggi la letteratura di lingua tedesca; pur nell’assoluta
negatività dei contenuti, in lui tuttavia il linguaggio
è ancora sfogo, liberazione, autoterapia, catarsi. La
sua radicale protesta non elimina il soggetto né un
rapporto gerarchico fra esso e gli oggetti, a differenza
dei testi della "Wiener Gruppe" che distruggono la
struttura sintattica per sgretolare il predominio
spiritualistico dell’io sulle cose. Folle e dilacerato,
il soggetto conserva in Bernhard la funzione di
principio di rispecchiarnento e organizzazione del
reale; la pazzia non annienta la coscienza ma ne
esaspera l’individualità: il principe siede alla
finestra e vede e sente la fila dei suoi antenati che lo
chiamano, mentre le stagioni, lì alla finestra,
trascorrono e passano senza interruzione. Con la sua
precisione ottocentesca, Bernhard non s’abbandona al
pathos del caos ma é attratto dal disgusto dell’ordine:
"la tenebra dipende interamente dalla geometria... tutto
è la realtà, pensavo".
|